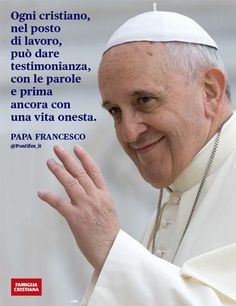La mia voce matura.. ovvero teologia del quotidiano attraverso testimoni di fede..
Papa Francesco il seminatore di Speranza
"La speranza cristiana non è negazione del dolore, è celebrazione dell’amore di Cristo Risorto che è sempre con noi"
Papa Francesco
Le Encicliche di Papa Francesco

Francesco: parole della gente comune
Riccardo Cristiano
Francesco si è preso dei rischi, ma anche delle libertà: la libertà di un’espressione non calcolata, che poi qualche ufficio avrebbe corretto magari, ma intanto questo stile colloquiale passava, diventava normale. In un comunicazione sempre controllata non si prendono rischi ma tutto diviene più paludato.
Un pontificato non lungo quello di Jorge Mario Bergoglio, ma difficilmente la Chiesa cattolica potrà tornare ad essere quel che è stata prima di lui. In questa realtà nuova c’entra senz’altro il linguaggio di Francesco: un linguaggio rivoluzionario.
Mi attengo soltanto a questo non per dire che i nuovi dovranno parlare come lui, ma per dire che il suo linguaggio ha traghettato la Chiesa in un mondo a lei poco conosciuto, non quello dei teologi, dei dotti, degli esegeti, ma quello delle persone normali; ascoltare il Papa non è più un’impresa per dotti, ai “semplici” non sono più riservati soltanto i gesti. Anche le parole sono rivolte a loro.
Nell’epoca della comunicazione a mezzo social media, cioè in un tempo di rapporto diretto tra chi parla e chi ascolta, tra chi dice e chi recepisce, questo ha una valenza enorme.
Ignari di questo alcuni si sono attardati, ad esempio, a non comprendere i colloqui tra Francesco ed Eugenio Scalfari. Nei suoi resoconti, con aria divertita, qualcuno poteva obiettare che Scalfari commetteva “errori” dottrinali, attribuiva al Papa una parola invece che un’altra: ma quella frase non doveva arrivare ai sacrestani, a catechisti, ma a chi lontano dalla Chiesa a mezzo di una semplificazione forse erronea, o sgrammatica diciamo, poteva così capire la voce del Papa pur non essendo parte del suo mondo di fede, ma interessato alle sue considerazioni sul mondo, sulla vita (e sulla morte).
Dunque la prima novità è stata questo mettere la voce di un romano pontefice nella non perfetta interpretazione “teologica” di un “estraneo” a quel mondo, come tanti di noi.
In questo non c’è alcuna forma di imbroglio, ma una “commistione” di stili e linguaggi, per consentire una reciproca comprensione. Questo rimanendo “nel seminato” ufficiale, bollinato, non si sarebbe potuto ottenere.
Se vogliamo paragonare questo discorso “linguistico” con quello dei gesti, possiamo trovare il corrispettivo con l’apparizione del Papa al Festival di Sanremo. Luogo non certo santo, né aduso alle discussioni sulla patristica, ma momento di svago e di vita vissuta come la gente vuole viverla da milioni di persone, alle quali il Papa si è dunque rivolto, mettendosi sullo schermo di quelle che alcuni saccenti chiamano “canzonette” e anche “soubrette”.
Le risposte a braccio
Guardando più addentro al suo pontificato cogliamo inoltre come Francesco, che non era incline alle interviste prima di diventare pontefice, ha creato anche uno stile espressivo nuovo ed ulteriore, quello del Papa che “ risponde a braccio”.
Durante i voli Papali, ovviamente, i giornalisti erano invitati a presentare le loro domande per il Papa in anticipo e in forma scritta, poi alcune sarebbero stato scelte, magari con qualche “levigatura”. E il Papa aveva il tempo per pensare a cosa dire e non dire. Francesco ha voluto l’intervista senza rete: i giornalisti sul volo Papale hanno potuto chiedere quel che volevano al Papa.
In questo modo Francesco si è preso dei rischi, ma anche delle libertà: la libertà di un’espressione non calcolata, che poi qualche ufficio avrebbe corretto magari, ma intanto questo stile colloquiale passava, diventava normale. In un comunicazione sempre controllata non si prendono rischi, si ovatta il messaggio, lo si rende “compatibile”. Non ci sono rischi, ovviamente, ma tutto diviene più paludato, difficilmente si tratta di un modo di esprimersi che riesce a comunicare.
In alcuni casi questo stile, questo modo di esprimersi è stato decisivo, come quando, parlando in questo linguaggio “informale”, ha detto “chi sono io per giudicare?” . Una frase che è entrata nella storia di questo pontificato.
Ho notato che in tempi recenti, in tutte le interviste che ha dato – a differenze di quanto accade con i testi scritti, il Papa non si è mai riferito all’aborto “dal momento del concepimento”: ha sempre fatto riferimento al momento, soggiungendo che sopraggiunge assai presto, in cui tutti gli organi sono formati. Ha scelto questo come il momento in cui dire che c’è vita umana. Un segnale che non è stato colto?
Alle spalle di questo, se si volesse indagare, c’è tutta una lunga e importantissima scuola teologica, che include San Tommaso, non certo autori minori: se avessi ragione, non lo so, sarebbe un caso di messaggio che il nuovo stile non è riuscito a veicolare, anche per la scarsa volontà di dialogo dell’altro campo, convinto della sua verità.
Vettori insoliti, “esterni”, linguaggio informale: sono due grandi novità di questo pontificato che potrebbero o dovrebbero restare, comunque, nel pontificato che verrà. Si tratti di un “bergogliano” o no, tornare al vecchio sarebbe dannoso.
Ma la novità più profonda e significativa, a mio avviso, è un’altra e quella è un dono che quindi non può costituire un precedente, perché i doni chi non li ha non li può chiedere in prestito: parlo del linguaggio poetico.
Il linguaggio poetico
Il linguaggio poetico di Francesco lo conoscono tutti quelli che lo hanno sentito parlare e sanno che questa era la sua forza comunicativa, quella che svegliava, attraeva, rendeva vivi coloro che lo ascoltavano, scoprendosi così coinvolti anche se non credevano, per la forza vitale che il linguaggio poetico ha.
I neologismi che lui ha introdotto- è famoso il “balconear” per invitare a non fare così, a non limitarsi a osservare lo scorrere della vita dalla finestra, dal balcone di casa- ma anche il “disinstallarsi” riferito non alle app, ma all’azione che la Chiesa dovrebbe compiere per divenire “Chiesa in uscita”, sono espressioni immaginifiche che raggiungono e toccano gli uomini, le donne, i giovani, portando un messaggio importante che non ha bisogno di citazioni che allontanano, facendo sudare l’uditorio, che rimane lontano, diciamo difficilmente coinvolto se non tramite quei “mediatori culturali” che oggi sono ascoltati o seguiti con decrescente attenzione.
Anche le sue figure vere o presunte, come la vecchina che in parrocchia gli ha detto una frase che vuole dire ma semplicemente, tipo “Dio perdona sempre, altrimenti il mondo sarebbe finito da tanto tempo”, ha un senso poetico, perché ci chiede di immaginare la vecchina, la sua “cultura sapienziale”, non universitaria, alta, ma autentica, che ci parla con un’altra saggezza e che così ci dice di più.
Ma il linguaggio propriamente poetico è quello che apre orizzonti, risveglia. Faccio un esempio che mi ha sempre colpito: quando giunse per l’incontro interreligioso a Ur, in Iraq, realizzando il sogno da tanto tempo dei Papi di poter visitare i luoghi d’Abramo in Iraq, il Papa ha detto:
L’Oltre di Dio ci rimanda all’altro del fratello. Ma se vogliamo custodire la fraternità, non possiamo perdere di vista il Cielo. Noi, discendenza di Abramo e rappresentanti di diverse religioni, sentiamo di avere anzitutto questo ruolo: aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la preghiera al Cielo.
Questo linguaggio che dall’oltre giunge all’altro è certamente poetico: possiamo usare le successive parole del Papa per capirlo in termini che riguardano i tre monoteismi, la loro fratellanza nella discendenza comune, ma anche per capire, come faccio io, che l’oltre è sempre tale, non può essere rinchiuso in una sola comprensione, riguarda e unisce le diversità senza omologarle, andando oltre ciascuna di loro.
Forse è per questo che nel testo torna più volte a parlare del cielo:
Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono Abramo a camminare sulla terra, a intraprendere un viaggio che, attraverso la sua discendenza, avrebbe toccato ogni secolo e latitudine. Ma tutto cominciò da qui, dal Signore che “lo fece uscire da Ur” (cfr Gen 15,7).
Il suo fu dunque un cammino in uscita, che comportò sacrifici: dovette lasciare terra, casa e parentela. Ma, rinunciando alla sua famiglia, divenne padre di una famiglia di popoli.
Anche a noi succede qualcosa di simile: nel cammino, siamo chiamati a lasciare quei legami e attaccamenti che, chiudendoci nei nostri gruppi, ci impediscono di accogliere l’amore sconfinato di Dio e di vedere negli altri dei fratelli. Sì, abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri.
In queste breve e non certo innovativa, o originale, escursione nei linguaggi di Francesco troviamo che il linguaggio esce dal ciclostile della forma nota, sperimenta sistemi idonei all’oggi, accorcia le distanze, come sanno fare solo i veri comunicatori, ma soprattutto porta il Vangelo e la sua predicazione in un tempo che ha modificato profondamente i sistemi di comunicazione.
Anche questo conferma che Francesco, il grande umanista di un tempo spaesato tra i nuovi ismi, come il sovranismo e il populismo, è stato un potente antidoto a queste novità preoccupanti.
Queste parole, il cui esempio più noto in termini di prossimità è il suo presentarsi dicendo “buongiorno”, o “buonasera”, come fa qualsiasi amico, qualsiasi compagno di viaggio, esempio dunque di prossimità che elimina la distanza che si era creata tra il Papa e i fedeli, la gente comune, sono state accompagnate dai suoi gesti più noti e ad esse collegati: abolire gli ori, le limousine, visitare le carceri, o i centri dove si trovano i migranti forzati.
Parola e gesto hanno composto un ritratto nuovo della Chiesa e del Papa vissuto e presentato come essere umano: la riforma più riuscita. Chi volesse smontarla avrà difficoltà a farlo, soprattutto per il linguaggio, che comunque ha dato inizio ad un’epoca ecclesiale nuova.

L'omaggio senza fine a Francesco: «Vi raccontiamo perché siamo qui»
Luca Liverani
24 aprile 2025
Dalla pace alla cura dei fragili, abbiamo raccolto alcune voci de più di 50mila fedeli che hanno voluto sostare in San Pietro davanti alla salma nelle prime 24 ore. «È stato il Papa dell'umiltà»
Non si è fermato nemmeno nella notte l'immenso afflusso di fedeli in fila per rendere omaggio a papa Francesco, la cui salma è esposta nella basilica di San Pietro. Stamattina la coda raggiunge i due chilometri di lunghezza e va da piazza Risorgimento a Porta Angelica. La coda, che comincia in piazza, fa diverse curve prima di arrivare in via di Porta Angelica dove le persone poi si incolonnano tra le transenne. Contrariamente a quanto previsto, ieri sera la basilica è rimasta aperta a oltranza dopo la mezzanotte: è stata chiusa alle 5.30 per poi essere riaperta alle 7, secondo il programma diffuso nei giorni scorsi. E secondo i media vaticani dalle 11 di ieri alle 11 di questa mattina, più di 50mila persone hanno reso omaggio ai Papa.
«Semplice. Diretto. Controcorrente. Coraggioso. Sorprendente. Spiritoso. Umano. Universale. Santo»: eccoli, gli aggettivi che ricorrono nelle parole di chi si è messo in fila per l'ultimo saluto a Francesco. E c’è veramente gente di tutti i tipi in questo brulichio di umanità che comincia a piazza Pia, si snoda lungo via della Conciliazione e si intruppa paziente nel serpentone che attraversa piazza San Pietro e arriva alla Basilica. Per vederlo, per salutarlo, per ringraziarlo, per pregarlo.
Ragazzi col Tau al collo, anziane col bastone, famiglie con figli piccoli e con figli grandi, stranieri dai look poco consoni alla situazione, coppie col passeggino. Cattolici praticanti e non, agnostici, atei. Una fiumana multicolore e multietnica che ha pochissime cose in comune, tranne una: questa enorme ammirazione per il Papa venuto “dalla fine del mondo” ma entrato subito in sintonia con un’umanità eterogenea. Con tutti e con ciascuno di loro.
Come Anna ed Elisabetta, due amiche di mezza età con due nomi biblici importanti. Hanno gli occhi pieni di luce dopo averlo salutato l’ultima volta. «Solo due ore», dicono quasi incredule. Vengono da Ladispoli, cittadina di mare in provincia di Roma. Cosa li ha colpiti di Francesco? «La semplicità, prima di tutto. Era uno di noi. Ma abbiamo capito la grandezza di quest’uomo leggendo la Evangelii Gaudium, con l’apertura ai laici, l’invito a farsi Chiesa in uscita. E la Fratelli tutti. Ancora di più con la Laudato si’, che ci ha fatto percepire il lamento flebile della Terra. Un dono che Dio ci ha affidato per custodirlo. Non per spremerlo».
Un Papa tanto diverso dai suoi predecessori, ma che a suo modo ha proseguito la loro opera. «Giovanni Paolo II ha spalancato le porte – dice Elisabetta – poi Benedetto XVI ci ha messo sui binari, con la sua delicatezza. E Francesco ci ha insegnato a camminare e a non fermarci. Col sorriso di papa Luciani». E ora? «Noi speriamo in un Francesco II. La gente ha paura che si ritorni indietro. Un nuovo Papa che non copi Bergoglio, ma che ne prosegua l’azione». Elisabetta e Anna ci provano a mettere in pratica il magistero di Francesco con il Circolo Laudato si’ Sacro Cuore di Ladispoli: «Abbiamo fatto uscire i preti dalle parrocchie», dicono sorridendo. Cioè? «Con la staffetta in bici di 140 chilometri “Alzati e pedala”, da Fiumicino a Civitavecchia. Ogni parroco ha raggiunto la parrocchia vicina consegnando all’altro la Laudato si’». Mariolina è romana di Roma, sulla sessantina, e non è voluta mancare. «Francesco mi è stato subito simpatico. Un papa moderno, che è riuscito ad avvicinare alla Chiesa tanta gente lontana, con la sua semplicità e col suo senso dell’umorismo».
Fabrizio ha 35 anni e al collo porta il lupetto della Roma. Romano? «Di Spinaceto», precisa, profondo sud romano. Cosa ti ha colpito di Francesco? «Pace, pace, pace. Lo ha ripetuto all’infinito. Era il Papa che ci voleva oggi che c’è troppa guerra, troppa». «Siamo di vicino Roma, non potevamo non venire», dicono Fabrizio e Cristina. Di dove? «Castelgandolfo. Certo, Francesco alla Villa Pontificia non è mai venuto e i negozianti non sono stati molto felici... Ma non importa, noi l’abbiamo amato tanto, quanto Giovanni Paolo II. Questo è stato un Papa che ha portato una ventata di novità. Un Papa controcorrente. Un Papa della gente».
Alessandra e Chiara sono amiche e colleghe, eleganti e curate più della media dei pellegrini. «Sono qui perché sono cattolica – racconta Alessandra – e venni a vedere anche papa Luciani con mia mamma, ero una ragazzina. Allora non c’era mica tutta questa gente. Con Giovanni Paolo II purtroppo non ho potuto, lavoravo. Stavolta ho voluto esserci, perché questo Papa mi ha colpito. Per il suo essere fuori dagli schemi, un latinoamericano, un po’ “populista”. Da quando si affacciò con quel sorprendente “buonasera” il giorno della sua elezione, per finire col mostrarsi senza falsi pudori in carrozzella. Per dirci “non vergognatevi della debolezza, sono anch’io come voi”. Ha comunicato tanto coi gesti». All’ingresso di sinistra del Colonnato Pasquale arriva con la moglie Barbara e i due figli grandi, Elena e Cosimo. Sono partiti da Benevento, torneranno subito in serata. Lo hanno fatto senza esitazioni, «per questo Papa dell’umiltà che ha voluto rompere gli schemi, rigettare certi simboli del potere papale. Ed è per questo che tanta gente gli si è avvicinata». Non solo: «Anche per l’attenzione per il Creato. È stato l’altro elemento che l’ha reso così importante».
Va di fretta e non si ferma a parlare col cronista l’uomo canuto e bassino. Dice solo due cose. La prima è da dove viene: «Dalla Sicilia». La seconda è il motivo per cui ha voluto salutare Francesco: «Perché è un santo». Basta e avanza. La signora anziana e distinta cammina faticosamente, una mano sul bastone, l’altra sottobraccio al figlio. «Quando si è mostrato in carrozzella – dice anche lei – mi ha colpito nel profondo. Non potevo non venire a dirgli grazie. Oggi quanto manca al mondo la sua benedizione e la sua presenza». Ed ecco un’altra famiglia che ha fatto ore di macchina prima che ore di fila. «Siamo calabresi, ma veniamo da Como», spiega Leonardo con moglie e figli. «Abbiamo cominciato all’una, siamo usciti quasi alle cinque». Ne è valsa la pena? «Assolutamente sì!», dice sgranando gli occhi, per far capire quanto è stata sciocca la domanda. Tutti diversi, tutti con lo stesso desiderio nel cuore.

L’ultima benedizione
Anita Prati
La preoccupazione per la conflittualità montante ad ogni angolo del pianeta ha accompagnato papa Francesco fino ai suoi ultimi respiri.
Rispondendo ad un messaggio di auguri di pronta guarigione inviatogli dal direttore del Corriere della Sera, lo scorso 18 marzo, dalla sua stanza d’ospedale al Policlinico Gemelli il Papa scriveva:
Caro Direttore, desidero ringraziarla per le parole di vicinanza con cui ha inteso farsi presente in questo momento di malattia nel quale, come ho avuto modo di dire, la guerra appare ancora più assurda.
L’assurdità della guerra si palesa ancor di più in tutta la sua drammatica insensatezza quando la si guarda da quel punto di osservazione privilegiato che è la malattia, luogo in cui si dispiega compiutamente tutta l’essenza dell’umana fragilità.
Dal suo letto d’ospedale papa Francesco ha levato un accorato appello, invitandoci a sentire tutta l’importanza delle parole. In un tempo in cui, in modo più o meno subdolo, torna a montare il clima di propaganda belligerante che avevamo conosciuto nei primi decenni del Novecento, il richiamo di papa Francesco risuona come una profezia: poiché le parole sono fatti che costruiscono i mondi che abitiamo, dobbiamo disarmare le parole, per disarmare le menti e disarmare la Terra.
***
È la proposta di un decisivo cambio di paradigma.
Proprio nei giorni in cui l’UE impegna i soldi dei suoi contribuenti per lanciare un video volto a promuovere un fantomatico kit di sopravvivenza utile a tenersi in vita per 72 ore in caso di minacce non meglio identificate, ma chiaramente identificabili con una bella guerra nucleare; proprio mentre i nostri governanti (e le nostre governanti) si arrabattano in tutti i modi possibili per giustificare l’investimento di fondi in piani di riarmo, a detrimento di istruzione e sanità; proprio mentre si cominciano a (re)introdurre anche nelle scuole progetti di rafforzamento della cooperazione civile-militare e sembra sempre più vicino il giorno in cui torneremo in piazza ad esercitarci nel passo d’oca; proprio mentre tutti i grandi (e le grandi) della terra si affannano a spiegarci la logica della guerra preventiva, sbeffeggiando il pacifismo come retaggio da hippy nostalgici e declinando come un insulto la parola «pacifista!», giacché l’idea-guida è che il Bene si può affermare solo sconfiggendo il Male a mano armata; proprio in giorni così, intrisi di irriducibile bellicosità, un uomo anziano, sulla soglia della morte, usa le sue ultime energie per richiamarci al dovere di sperare la pace.
Domenica 20 aprile, prima della benedizione Urbi et Orbi, impartita con un filo di voce dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, papa Francesco ha chiesto al maestro delle Celebrazioni Liturgiche Diego Ravelli di leggere il suo Messaggio Pasquale. Ci resteranno di lui queste ultime immagini, queste ultime parole: un uomo anziano e ammalato che osa, come pochi al mondo, continuare a credere che solo la pace ci salva dalla disumanità.
Se Cristo, nostra speranza, è risorto, sperare non è un’illusione, ma un dovere e una responsabilità:
Quanti sperano in Dio pongono le loro fragili mani nella sua mano grande e forte, si lasciano rialzare e si mettono in cammino: insieme con Gesù risorto diventano pellegrini di speranza, testimoni della vittoria dell’Amore, della potenza disarmata della Vita.
La potenza della Vita è disarmata e proprio per questo disarmante. Siamo circondati da volontà di morte, da conflitti e da violenze di ogni genere, ma la nostra esistenza non è fatta per la morte, è fatta per la Vita!
In questo giorno, vorrei che tornassimo a sperare e ad avere fiducia negli altri, anche in chi non ci è vicino o proviene da terre lontane con usi, modi di vivere, idee, costumi diversi da quelli a noi più familiari, poiché siamo tutti figli di Dio!
Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile!
***
Nel Messaggio di Francesco tornano, nominati uno ad uno, i luoghi della terra martoriati dalle guerre: il Medio Oriente, il Libano, la Siria; lo Yemen; l’Ucraina; il Caucaso Meridionale, l’Armenia e l’Azerbaigian; i Balcani occidentali; la Repubblica Democratica del Congo, il Sudan e il Sud Sudan, il Sahel, il Corno d’Africa, la Regione dei Grandi Laghi; il Myanmar.
Su tutti, e prima di tutti, la Terra santa insanguinata:
Dal Santo Sepolcro, Chiesa della Risurrezione, dove quest’anno la Pasqua è celebrata nello stesso giorno da cattolici e ortodossi, s’irradi la luce della pace su tutta la Terra Santa e sul mondo intero. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo, il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Faccio appello alle parti belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi e si presti aiuto alla gente, che ha fame e che aspira ad un futuro di pace!
Cessate il fuoco! Chi raccoglierà questo appello di papa Francesco? Chi avrà il coraggio e si assumerà la responsabilità di osare sperare la pace?
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo.
I grandi e le grandi della terra, che in questi giorni affastellano tributi di cordoglio per la morte di papa Francesco, saranno capaci di raccoglierne l’eredità spirituale e fare in modo che, la sua, non rimanga una voce che grida solitaria nel deserto?
***
Il testamento di Francesco, redatto quasi tre anni fa, il 29 giugno 2022, si chiudeva con queste parole, che testimoniano tutta l’urgenza del suo sentire:
La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli.
Tornare a sperare che la pace è possibile: è questa il richiamo potente e la responsabilità che papa Francesco ci ha affidato con le sue ultime parole.
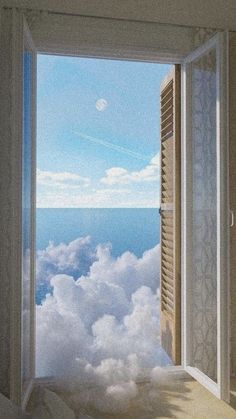
L’ultima omelia
Anita Prati
L’ultima omelia di Papa Francesco è stata l’omelia scritta per il giorno di Pasqua. A motivo della sua voce affaticata il papa non l’ha potuta leggere, ma ne ha affidato la lettura al cardinal Comastri. È un’omelia densa e breve, che si apre significativamente con il nome di Maria di Magdala e si chiude con una citazione dalla teologa e poeta Adriana Zarri.
Maria, dopo aver visto la pietra scostata dal sepolcro, corre a dirlo a Pietro e Giovanni; e Pietro e Giovanni, a loro volta, subito si mettono a correre verso il luogo della sepoltura di Gesù. Quella corsa è, per papa Francesco, molto più di un semplice dato narrativo:
“La corsa della Maddalena, di Pietro e di Giovanni dice il desiderio, la spinta del cuore, l’atteggiamento interiore di chi si mette alla ricerca di Gesù. Egli, infatti, è risorto dalla morte e perciò non si trova più nel sepolcro. Bisogna cercarlo altrove.”
Francesco ci consegna questo invito pressante, perentorio, e questa responsabilità: bisogna cercarlo altrove, il Signore della Vita. Non nei sepolcri, nei musei del tempo che fu, nelle storie imbalsamate, ma nella vita, nei volti e nelle storie vive dei fratelli e delle sorelle che camminano con noi lungo le strade di questo mondo. Dobbiamo cercarlo altrove, e cercarlo sempre:
“Cercarlo sempre. Perché, se è risorto dalla morte, allora Egli è presente ovunque, dimora in mezzo a noi, si nasconde e si rivela anche oggi nelle sorelle e nei fratelli che incontriamo lungo il cammino, nelle situazioni più anonime e imprevedibili della nostra vita. Egli è vivo e rimane sempre con noi, piangendo le lacrime di chi soffre e moltiplicando la bellezza della vita nei piccoli gesti d’amore di ciascuno di noi.”
In questo cercare, in questo cercarlo sempre, è la radice della nostra fede pasquale: una fede che non si adagia nella staticità del “si è sempre fatto così” e non si accomoda nella tranquillità delle rassicurazioni religiose, ma osa il coraggio inquieto della ricerca.
“Come Maria di Magdala, ogni giorno possiamo fare l’esperienza di perdere il Signore, ma ogni giorno noi possiamo correre per cercarlo ancora, sapendo con certezza che Egli si fa trovare e ci illumina con la luce della sua risurrezione.”
I passi svelti della Maddalena, di Pietro e di Giovanni, danno corpo alla speranza: non una semplice idea, una pia illusione, ma un movimento vitale che sostanzia di senso il nostro cammino.
“Non possiamo parcheggiare il cuore nelle illusioni di questo mondo o rinchiuderlo nella tristezza; dobbiamo correre, pieni di gioia. Corriamo incontro a Gesù, riscopriamo la grazia inestimabile di essere suoi amici. Lasciamo che la sua Parola di vita e di verità illumini il nostro cammino. “
L’omelia si chiude con una preghiera di Adriana Zarri: “Scrostaci, o Dio, la triste polvere dell’abitudine, della stanchezza e del disincanto; dacci la gioia di svegliarci, ogni mattino, con occhi stupiti per vedere gli inediti colori di quel mattino, unico e diverso da ogni altro.”
Gli occhi di papa Francesco, questa mattina, hanno accolto con stupore e gratitudine un mattino davvero nuovo.
Cercavo
Cercavo silenzi
di boschi e montagne,
di sguardi profondi,
di vento sul mare.
Cercavo passi
che riportano a casa,
che tracciano strade,
che camminano insieme.
Cercavo luce
a rischiarare la notte –
bagliori di fiamma,
tremolio di candele.
Cercavo acqua
che disseta la sete,
rinfresca la pelle,
inonda i pensieri.
Cercavo pane
per spezzare fatiche,
sostenere gli affanni,
carezzare il dolore.
Cercavo vino
per danzare la festa,
per cantare la vita,
liberare la gioia.
Cercavo parole
da riporre in silenzio
fra le pieghe del cuore –
parole da ascoltare,
parole da parlare,
parole da intrecciare
con legami d’amore.
Cercavo –
ho sempre cercato –
e Tu, ogni volta,
mi hai sempre trovato
Anita Prati

Francesco: un dono dello Spirito
Nel momento in cui riceviamo la drammatica, seppur attesa, notizia della morte di papa Francesco ci siamo rapidamente consultati in redazione. In attesa di un giudizio più ponderato e compiuto ci è parso importante fissare alcuni punti decisivi e alcune linee guida che hanno segnato il suo servizio petrino. Si tratta di guardare a Francesco con l’ottica di Francesco. A partire da quanto è possibile comprendere dai suoi scritti, dai suoi gesti, dalla sua vita e dai suoi indirizzi di governo si possono indicare gli orientamenti di maggior forza che ha inteso proporre e sostenere. Fra questi ve ne sono alcuni a nostro giudizio particolarmente riconoscibili.
Fedeltà al Vaticano II
Si può dire che tutti i pontificati post-conciliari lo hanno affermato, ma con tentativi di correzione e di contenimento. Francesco ha aperto porte e finestre, riprendendo la spinta innovativa dell’assemblea conciliare dei vescovi cattolici. In particolare, nei rapporti con la modernità ha archiviato ogni declinazione di neo-cristianità. La Chiesa, sacramento di salvezza, partecipa con tutti gli uomini e le donne al procedere storico, dando il proprio contributo di testimonianza, luce e senso evangelici senza pretendere di essere parte del potere politico o di condizionare le assemblee legislative.
Evangelizzazione prima della dottrina
Senza ignorare la centralità del deposito della fede, il compito odierno della Chiesa nella sensibilità di Francesco è quello di tornare all’annuncio del Vangelo ad ogni creatura, di uscire dai recinti consueti, di trasformare i propri linguaggi, di sporcarsi le mani con i vissuti di tutti. La scelta dei poveri perde ogni traccia ideologica per tornare al Vangelo sine glossa. Protagonista dell’impresa è l’intero popolo di Dio.
Sinodalità
La fatica degli ultimi anni di chiarire, fondare e praticare la sinodalità è indicativa di una Chiesa che, proseguendo il suo sforzo di comprensione sempre migliore della fondante manifestazione dell’Abbà di Gesù e della rivelazione trinitaria, si impegna a tradurle in una prassi concreta e condivisa nel tempo presente. Siamo ancora all’inizio. Il processo e l’investimento sono destinati a durare a lungo.
Religioni e confessioni cristiane
Davanti alla sfida della violenza con pretese religiose Francesco ha approfondito l’intuizione di Assisi (Giovanni Paolo II), aprendo dialoghi e confronti, in particolare con l’Islam e le fedi non monoteistiche. Contestualmente, ha riconosciuto di dover assumere una nuova centralità della Chiesa cattolica in ordine all’urgenza dell’unità cristiana, al dialogo con le altre confessioni. Ne va della credibilità del cristianesimo e della sua profezia in un mondo sempre più diviso e frammentato.
Il vento del Sud
Provenendo − come ebbe a dire la sera della sua elezione − dalla «fine del mondo», da un Paese periferico rispetto alla civiltà atlantica, Francesco ha incarnato e incoraggiato la crescita delle comunità cattoliche in continenti come l’Africa e l’Asia. Uno spostamento del baricentro ecclesiale che porta in sé cambiamenti profondi nell’autocoscienza della Chiesa, ben al di là della crescita del numero dei cardinali non occidentali.
Laici e donne
Se c’è una denuncia insistente nei suoi discorsi è quella contro il clericalismo, contro una indebita centralità dei vescovi e dei preti. Non per sminuire la rilevanza del ministero ordinato, ma per dare uno spazio effettivo al sensus fidei fidelium e agli innumerevoli carismi che lo Spirito suscita nelle comunità cattoliche. È stato talora accusato di approcciare la questione femminile in termini retorici, ma anche la semplice costatazione dei ruoli ecclesiali oggi riconosciuti alle donne, rispetto al passato recente, indica la sostanza dei passi compiuti.
Contro gli abusi
In fedeltà agli indirizzi avviati da Benedetto XVI, e sull’onda degli scandali svelati e cavalcati dai media di molti Paesi occidentali, Francesco ha definito la risposta canonica, teologica e spirituale davanti all’«intollerabile» della violenza sui piccoli e gli indifesi. Si potranno certo rilevare anche incertezze e rallentamenti, in particole per alcuni casi che lo hanno tangenzialmente coinvolto, ma è difficile negare la sua coerente volontà di affrontare il problema, anche quando esso ha coinvolto ecclesiastici di alto profilo e interi episcopati.
Libertà di ricerca
Solo chi non ha conosciuto il senso di liberazione del Concilio e le successive restrizioni al pensare teologico (dalla teologia della liberazione alla ricerca morale e all’ecclesiologia) può sorvolare sulla ricchezza di dibattiti e di ipotesi teologiche che hanno ripreso a correre in seno alla Chiesa con l’attuale pontificato. I loro limiti e fragilità non possono oggi essere attribuiti alle censure delle istanze vaticane, se non in piccola parte. Paradossalmente, le numerose – talora improponibili – critiche al suo magistero lo confermano.
Riforma della curia
Spostare l’asse di rotazione dalla dottrina all’annuncio del Vangelo, impedire concrezioni improprie di potere, sciogliere le cordate servili, internazionalizzare le presenze, ricambiare i responsabili, facilitare i rapporti con la conferenze episcopali e i vescovi: sono alcune delle importanti intenzioni che reggono la riforma. Le sue insufficienze e contraddizioni, che non mancano, non possono svalutare le preziose novità di indirizzo.
Ambiente, fratellanza, migrazioni
Sono i titoli di alcuni dei suoi testi fondamentali (encicliche, esortazioni, discorsi e gesti) sulle emergenze sociali e mondiali. Rappresentano lo sforzo del magistero pontificio davanti a sfide cruciali per la sopravvivenza dell’umanità. Consapevole della «dissonanza» rispetto alla cultura mediale corrente, Francesco non ha annacquato la genialità della dottrina sociale, affrontando la globalizzazione senza cedimenti al sistema tecnocratico. Essa rappresenta per lui un coerente sviluppo della riforma ecclesiale proposta con il suo grande documento programmatico, l’esortazione Evangelii gaudium.
Guerra ed egemonia
Francesco ha delegittimato la guerra andando oltre la dottrina della «guerra giusta» proprio nel momento in cui essa riappare «a pezzi» nel mondo e in Europa (Russia-Ucraina). C’è qualcosa di agonico e drammatico in questa volontà di resistere al fatto che la pur necessaria ridefinizione dell’egemonia mondiale debba avvenire con la violenza. Da qui si capisce il favore con cui Francesco guarda all’esperienza dell’Unione Europea, alla necessità di tenere aperti i contatti con Mosca e con Pechino e alle domande esigenti nei confronti della democrazia americana. Lo ha fatto perché ha percepito acutamente che c’è una vittima predestinata della distruzione del multilateralismo e della pace: la democrazia.
Fedeltà al Vangelo e acume storico legittimano l’indicazione di Francesco come dono dello Spirito.
Fonte: Settimananews

I gesti, le parole, gli abbracci: il Papa delle prime volte
Mimmo Muolo
Che tipo di Papa sarebbe stato non ci volle molto a capirlo, quel tardo pomeriggio del 13 marzo 2013. Il tempo di vederlo comparire sul balcone centrale della facciata della Basilica di San Pietro, di osservare il semplice vestito bianco, con nient’altro sopra se non la croce pettorale, di ascoltare il suo «buonasera» e le prime parole a braccio, dopo l’annuncio del nome che Jorge Mario Bergoglio aveva scelto per il suo ministero petrino. Francesco. Una novità assoluta nella bimillenaria storia dei papi.
Il pontificato “delle prime volte”
Cominciava così un pontificato “delle prime volte”, estremamente popolare, anche se non scevro da critiche (quasi tutte da “destra” e anche questa è una prima volta, almeno nella storia recente), ma sicuramente rivoluzionario per molti aspetti. A cominciare dal fatto che per la prima volta, appunto, era stato chiamato a guidare la Chiesa cattolica un latino-americano, circostanza che egli stesso sottolineò con un’espressione poi divenuta famosa: «Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo (il nuovo vescovo di Roma, ndr) quasi alla fine del mondo».
Ma insieme a questa frase, molto di quello che sarebbe avvenuto dopo, nei 12 anni di permanenza sulla cattedra di Pietro, fu come preconizzato in quel primo discorso da Pontefice.
La teologia del popolo, ad esempio, sua constante stella polare. La fratellanza, che tanto spazio avrebbe avuto nei suoi documenti e soprattutto nell’enciclica Fratelli tutti. La sua richiesta della preghiera del popolo affinché il Signore apponesse il sigillo della sua benedizione sul nuovo pontificato, ancor prima che fosse – come di consueto – il nuovo Papa a benedire il popolo. E il primo pensiero dedicato a Benedetto XVI, da pochi giorni (a quella data) Papa emerito, per inaugurare un rapporto di considerazione e affetto che sarebbe durato fino alla morte del suo predecessore, il 31 dicembre 2022.
La capacità di sorprendere e la naturale simpatia
Papa Francesco dimostrò fin dall’esordio la sua capacità di sorprendere. E di stabilire una sintonia immediata con i propri interlocutori, anche quelli più lontani, le personalità che fino ad allora avevano guardato alla Chiesa di Roma con sospetto e diffidenza, o magari con indifferenza, se non proprio con aperta ostilità. Quali saranno i frutti che questa naturale simpatia ha prodotto lo giudicherà la storia, ma è un fatto che papa Bergoglio abbia aperto canali di dialogo fino a poco tempo fa impensabili. Si pensi solo agli incontri con Eugenio Scalfari, sia pure al netto degli errori teologico-dottrinali anche gravi, attribuiti dal famoso giornalista al Papa nei suoi report su quei colloqui.
Nei giorni che seguirono l’elezione, in particolare, emersero sempre nuovi aspetti della personalità del Papa argentino, che gli guadagnarono un immediato e quasi totale favore popolare. Come ad esempio la scelta, subito dopo l’affaccio dal balcone, di tornare a Casa Santa Marta in pulmino con gli altri cardinali invece di utilizzare l'automobile papale. Oppure il gesto di recarsi personalmente alla Casa del Clero dove aveva soggiornato nei giorni precedenti al Conclave, per pagare il conto. E poi la decisione di rimanere a Santa Marta, anziché andare a risiedere nel Palazzo apostolico, non come scelta di povertà, ma di contatto con le persone, perché questo lo faceva stare bene, come spiegò egli stesso.
Povertà, pace, creato e misericordia
Anche il nome fu un’indicazione di programma: Francesco è l’uomo della povertà, della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato. «Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!», disse. Si aggiungerà poi la misericordia, a completare i quattro pilastri pastorali del suo magistero. Nel primo Angelus dopo la sua elezione, il 17 marzo, Bergoglio parlò della misericordia come di una parola che cambia il mondo» e lo «rende meno freddo e più giusto». E il 7 aprile, nella basilica di San Giovanni in Laterano, quando il nuovo Vescovo di Roma si insediò sulla sua cattedra, aggiunse: «Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio». Sono solo i primi accenni di tema che troverà il suo momento più alto nella celebrazione dell’Anno Santo straordinario della misericordia (2015-2016).
Nella Messa di inizio ufficiale del ministero petrino, il 19 marzo 2013, giorno di San Giuseppe, il Papa parlò anche di tenerezza, prendendo spunto proprio dal casto sposo di Maria, uno dei santi che gli erano più cari. «In lui – sottolineò - vediamo qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato». Quindi parlando del suo ruolo disse: «Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce». Il che significa «aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame, sete, è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo chi serve con amore sa custodire».
Su questi binari programmatici ecco che il primo anno di pontificato diventa una specie di fuoco pirotecnico delle novità. Il 23 marzo, ad appena dieci giorni dall’elezione al soglio di Pietro, papa Francesco si reca a Castel Gandolfo per visitare il papa emerito Benedetto XVI. È la prima volta nella storia che due papi si incontrano. Il 13 aprile 2013 un comunicato della Segreteria di Stato annuncia la formazione di un gruppo di cardinali «per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor bonus sulla Curia Romana». Nasce così il cosiddetto C8 (otto cardinali), che poi diverrà C9, con l’ingresso del segretario di Stato, Pietro Parolin. Questo gruppo, di cui viene nominato segretario l’allora vescovo di Albano, Marcello Semeraro (poi cardinale), sarà quello che insieme al Papa porterà alla riforma della Curia, ora codificata nella costituzione Praedicate Evangelium, pubblicata il 19 marzo 2022.
I viaggi
L’8 luglio 2013, poi, un po’ a sorpresa, Francesco dà inizio ai suoi viaggi, scegliendo una destinazione emblematica: Lampedusa. C'era stato da non molto l’ennesimo grave naufragio che aveva causato decine di morti tra i migranti. Si comprende così che, pur confermando la prassi dei viaggi papali, Bergoglio intende dare anche a questa attività un’impronta in linea con le proprie priorità pastorali. Periferie sempre al centro. Predilezione per i più poveri. Chiesa in uscita. In Europa, ad esempio, inizierà dall’Albania, non toccherà mai i grandi Paesi. Strasburgo e Marsiglia non furono visite alla Francia, ma al Parlamento Europeo e al Consiglio d’Europa nel primo caso, ai vescovi del Mediterraneo riuniti a convegno nel secondo (solo la periferica Ajaccio lo è stato, suo ultimo viaggio, il più breve), mentre in altri continenti visiterà preferibilmente contesti e situazioni, più che Paesi, con un occhio particolare ai diseredati e al dialogo con le altre religioni, musulmani in primis. Alcuni dei viaggi entreranno direttamente nella storia del Pontificato. Quello in Iraq, ad esempio, in pieno periodo Covid e dopo la fine della devastazione dell’Isis, il viaggio in Terra Santa, le due tappe nella Penisola arabica (Abu Dhabi e Qatar), le prime in assoluto per un Pontefice in quella regione, la visita all’Onu, a suo modo anche il Giappone (dove il Papa avrebbe voluto andare come missionario da giovane) e il sorvolo della Cina durante il viaggio in Corea del Sud. Francesco invece non ha fatto mai ritorno in Argentina, pur avendo viaggiato diverse volte in America Latina.
Tra i viaggi bisogna anche ricordare le Gmg. Grandiosa quella di Rio de Janeiro nel 2013 (suo primo viaggio all’estero, a pochi mesi dall’elezione), cui sono seguite quelle di Cracovia 2016, Panama 2019 e Lisbona 2023.
Il Concistoro
Il primo Concistoro per la creazione di nuovi cardinali si tenne invece il 22 febbraio 2014. E anche in questo ambito si intuì fin da allora che Francesco aveva in mente una sua “geopolitica” delle porpore, che non coincideva con quella codificata nel tempo rispetto alle sedi episcopali cosiddette cardinalizie. La sua preferenza è spesso andata a realtà periferiche e a Chiese che non avevano mai avuto un cardinale.
La libertà
Ma la libertà del Pontefice si esplica anche in altri campi: telefona agli amici, si reca di persona a comprare gli occhiali in un’ottica di via del Corso a Roma, compie alcune visite a sorpresa - quella del febbraio 2021 a casa della scrittrice di origine ebraica, Edith Bruck, sopravvissuta ai lager nazisti e quella a casa di Emma Bonino il 5 novembre 2024 -, festeggia i suoi compleanni e onomastici condividendo un pezzo di pizza o di torta con i clochard che vivono dalle parti di San Pietro. Non può più uscire da solo o prendendo la metropolitana, come faceva quando era arcivescovo di Buenos Aires, ma talvolta si concede piccole “licenze”. Soprattutto con e per i poveri, gli ammalati, gli emarginati, verso i quali dimostra la sua speciale predilezione. Dispone ad esempio che l’elemosineria diventi una specie di braccio operativo della sua carità immediata. E incarica l’elemosiniere Konrad Krajewski (che sarà insignito della porpora cardinalizia) di provvedere ai loro bisogni: docce, dormitorio, perfino il barbiere ogni lunedì, cure e visite mediche dedicate (specie nella giornata mondiale dei poveri, organizzata dall’arcivescovo Rino Fisichella), ma anche spettacoli al circo e concerti nell’Aula Paolo VI. Una volta viene organizzata anche una visita guidata nella Cappella Sistina.
Le parole e i gesti nuovi
È un Pontificato di gesti, oltre che di discorsi e documenti, quasi un’enciclica scritta con il linguaggio del corpo, con gli incontri che non ti aspetti, con gli abbracci agli ammalati, anche i più gravi. Lo stesso stile hanno il suo magistero e la sua predicazione. Soprattutto nelle messe mattutine a Santa Marta (consuetudine interrotta alla fine del periodo del Covid), che diventano un vero e proprio laboratorio di omiletica, in cui il Pontefice dà prova anche della sua capacità di parlare un linguaggio per immagini (“Chiesa in uscita”, appunto, per dire della missionarietà; “pastori con l’odore delle pecore” per raccomandare ai sacerdoti la vicinanza al popolo di Dio; “cristiani della domenica”, per stigmatizzare la distanza tra fede e vita di certi praticanti, e diverse altre espressioni tipiche).
Un’ulteriore grande novità, introdotta fin dal primo anno di Pontificato, è quella di celebrare la messa in coena Domini del Giovedì Santo non più nella Basilica di san Pietro, ma nei luoghi della sofferenza umana: carceri soprattutto (e si comincia con quello minorile di Casal del Marmo a Roma), ma anche nosocomi e centri di riabilitazione.
I documenti
Sono tutte linee che si ritrovano in maniera sistematica nell’esortazione Evangelii gaudium, promulgata nel novembre del 2013, vero e proprio documento programmatico del pontificato e che dà forma compiuta a idee portanti come quella della Chiesa in uscita, intesa come totalità del Popolo di Dio che evangelizza, il discorso sull’economia che uccide e sulle iniquità dei meccanismo del mercato, l’indicazione che il tempo è superiore allo spazio, la realtà superiore all’idea, l’unità prevale sul conflitto, il tutto è superiore alla parte. E poi le indicazioni sull’omiletica, la pace e il dialogo sociale e le motivazioni spirituali per l'impegno missionario.
Francesco anche per quanto riguarda i documenti segue una linea originale. Relativamente pochi, ma molto caratterizzati. Prima della Evangelii Gaudium era stata pubblicata l’enciclica Lumen Fidei (29 giugno 2013), quasi pronta già sotto il pontificato di Benedetto XVI, che però non l’aveva conclusa. Il nuovo Pontefice la fa propria, la completa e la pubblica dichiarando esplicitamente che si tratta di un testo praticamente scritto a quattro mani con il suo predecessore (altra circostanza inedita nella storia dei Papi).
Documenti fondamentali saranno l’enciclica sociale Laudato si', la prima dedicata interamente alla salvaguardia del creato, con la proposta innovativa dell’ecologia integrale (non esistono tante crisi, ma una sola che le comprende tutte) e poi Fratelli tutti, che ne costituisce l’ideale continuazione, e naturalmente Amoris Laetitia, uno dei documenti più commentati (e controversi, soprattutto per la questione della comunione ai divorziati risposati), frutto dei due sinodi dedicati alla famiglia tra il 2014 e il 2015. L'ultima enciclica è Dilexit nos sul Sacro Cuore.
Il Giubileo della misericordia
Il crescendo dei primi anni di pontificato giunge fino alla proclamazione, anche questa una sorpresa, dell’Anno santo straordinario della misericordia. Il Giubileo si svolge con modalità innovative. Il Papa dispone che siano aperte porte sante in tutte le diocesi del mondo. Ed egli stesso ne anticipa di qualche giorno l’inizio, fissato per l’8 dicembre 2015 aprendo il 29 novembre la porta santa della Cattedrale di Notre-Dame di Bangui nella Repubblica Centrafricana, durante il suo primo viaggio in Africa.
I tre momenti storici
Non mancano anche nella seconda fase del Pontificato i momenti storici. Se ne potrebbero indicare tre su tutti. In ordine di data:
- l’incontro del 12 febbraio 2016 a Cuba con il patriarca ortodosso di Mosca, Kirill, novità assoluta nella storia anche questa, che aveva fatto sperare in un definitivo disgelo con la parte numericamente più consistente dell’ortodossia, prima che l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ricongelasse molto di questo rapporto.
- la preghiera sotto la pioggia del 27 marzo 2020 in una piazza san Pietro deserta, per chiedere la fine della pandemia (immagini anche queste rimaste nell’immaginario collettivo);
- la firma ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019 della Dichiarazione sulla fratellanza universale, insieme con il grande imam di Al-Azhar, quale base per costruire la pace e la convivenza tra i popoli.
I migranti, i poveri e l’Economy of Francesco
Il Papa ha approfondito negli anni molti dei temi enunciati già dall’inizio del Pontificato. L’attenzione agli ultimi e ai poveri, ad esempio, anche attraverso un altro modo fare economia. E nasce infatti “Economy of Francesco”, movimento di giovani economisti per cambiare le regole che troppo spesso non tengono conto della sostenibilità, lasciano indietro i più poveri e non rispettano l’ambiente. Il Pontefice si fa promotore anche di alcune iniziative simbolo, come il Sinodo per l’Amazzonia, con finalità non solo pastorale, ma anche legata alla salvaguardia del più grande polmone verde del mondo. Infine, emerge sempre più la questione della sinodalità, come modo di vivere la Chiesa e stabilire un nuovo contatto con il mondo (a questo tema sarà dedicato il doppio sinodo del 2023 e del 2024).
Il Papa alza sempre più spesso la sua voce in difesa dei migranti, chiedendo per loro accoglienza, protezione, promozione e integrazione. E compie ben due visite a Lesbo, l’isola greca dove c’è uno dei campi profughi più grandi d’Europa.
Gli appelli per la pace
Dall’invasione della guerra in Ucraina (24 febbraio 2022) e poi con le ostilità a Gaza (dopo l’inumano attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023), il Pontefice chiede con sempre più insistenza di fermare la violenza, paventando l’avvio di una terza guerra mondiale non più solo a pezzi. Sua la decisione senza precedenti di recarsi personalmente all’indomani dell’aggressione a Kiev nell’ambasciata russa presso la Santa Sede per cercare di parlare (inutilmente) con Putin. Sua anche l'idea di nominare suo inviato speciale per la pace il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, che, se non riesce a fermare le ostilità, quanto meno ottiene il rilascio di molti ostaggi, tra i quali soprattutto bambini ucraini portati in Russia.
L’impegno contro gli abusi nella Chiesa
Sono stati anche anni di lotta senza quartiere agli abusi sui minori all’interno della Chiesa. Francesco ha cercato di attuare una “politica” di tolleranza zero sul tremendo problema, introducendo norme severe per quei vescovi che dovessero coprire casi di loro conoscenza e istituendo una Commissione per la tutela dei minori, affidata alla presidenza del cardinale Seàn Patrick O’Malley. Francesco ha anche voluto una nuova sezione all’interno della Congregazione per la dottrina della Fede, quella disciplinare, chiamata a occuparsi dei delitti riservati alla Congregazione stessa, tra cui l’abuso di minori compiuto da chierici. In materia di abusi, però, non si possono omettere di ricordare alcune “sviste” come quella relativa all’episcopato cileno, prima difeso dal Pontefice, che poi, di fronte a prove inoppugnabili, ha dovuto prendere gli opportuni provvedimenti.
I rapporti con la Chiesa italiana
Sul fronte italiano il pontificato di Jorge Mario Bergoglio si è caratterizzato per un rapporto con l’episcopato italiano che potremmo definire di obbedienza dialettica da parte dei vescovi. Il Papa argentino ha chiesto una semplificazione delle strutture ecclesiastiche, sia per quanto riguarda le diocesi (portando avanti, specie negli ultimi tempi, un programma di accorpamento in persona episcopi, di quelle più piccole con altre territorialmente vicine), sia promuovendo un processo sinodale che tra il 2022 e il 2025 si è articolato in varie fasi.
Il Papa e i giornalisti
Innovativo è stato anche il suo rapporto con il mondo della comunicazione. Nell’itinerario di ritorno a Roma, durante i suoi viaggi, il Papa ha sempre tenuto conferenze stampa con i giornalisti al seguito, sui temi più vari. Decine le interviste concesse a testate di tutto il mondo. Così pure i libri, spesso scritti a quattro mani con i giornalisti, fino alle due recenti autobiografie.
Pure da questo punto di vista è stato un Papa delle prime volte. Un Papa che ha confermato fino all’ultimo giorno (emblematiche resteranno le foto dell'apertura della Porta Santa prima a San Pietro poi al carcere di Rebibbia, altra primizia assoluta, per il Giubileo in corso) la prima impressione suscitata nei fedeli quel 13 marzo 2013. Quando fu facile comprendere che tipo di Pontefice Jorge Mario Bergoglio sarebbe stato.

Febbraio 2025
L'affetto. «Caro Papa, preghiamo per te». Nei disegni l'abbraccio dei bambini
Padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini
Dai piccoli di tutto il mondo pensieri e messaggio di affetto al Pontefice in ospedale. Un invito a riscoprire la purezza e la semplicità che Francesco testimonia alle nuove generazioni
Migliaia di disegni, lettere e preghiere stanno arrivando dai bambini di tutto il mondo al Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini. Un segno che ci ha sorpreso ma che in fondo era da aspettarsi. I bambini, infatti, sono sempre stati nel cuore di papa Francesco, un amore che ha trovato espressione in numerosi gesti e iniziative negli ultimi anni. Penso all’incontro con i piccoli del 6 novembre 2023 nell’Aula Paolo VI che ha dato il via a un legame ancora più forte tra Francesco e i bambini di tutto il mondo. In seguito, il Papa ha risposto personalmente con una lettera a migliaia di bambini che avevano partecipato a quell’incontro, esprimendo loro gratitudine e affetto.
Non solo parole, ma anche azioni concrete come l’introduzione della Giornata mondiale dei bambini (Gmb), un evento che ha avuto risonanza globale e che ha trovato spazio nella pastorale della Chiesa, a livello mondiale, nazionale e locale. Riecheggiano solenni e forti le parole di papa Francesco: «Ci siamo radunati qui allo Stadio Olimpico, per dare il “calcio d’inizio” a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, dove siamo tutti fratelli, un mondo che ha un futuro, perché vogliamo prenderci cura dell’ambiente che ci circonda». A testimonianza di questa profonda attenzione è stato istituito anche il Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini con l’obiettivo di curare e coordinare l’animazione per i bambini in tutta la Chiesa.
In questo contesto, non c’è da sorprendersi della risposta dei bambini, che sono riusciti a inviare messaggi toccanti al Papa. Le loro parole e i loro disegni rappresentano una carezza che papa Francesco, in questi giorni difficili per la Chiesa e per il mondo intero, ha sicuramente accolto con gratitudine. Questi gesti di affetto, pur nella loro semplicità, sono un segno di speranza. In un momento in cui la Chiesa è sotto il peso di veleni o fake news, i bambini ci stanno lanciando un messaggio chiaro: bisogna ripartire da loro, da quella purezza e semplicità che spesso il mondo adulto tende a dimenticare.
Tra i messaggi che toccano il cuore, c’è il disegno di Axel, un bambino peruviano che ha rappresentato papa Francesco sorridente augurandogli una pronta guarigione. Poi ci sono i lavori di gruppo dei bambini dell’Associazione Fraternamente di Taurianova – 14 orfani – come quello di Emma che ha disegnato un mondo popolato dai bambini con l’esortazione: «Prega per tutti i bambini del mondo». Anche da luoghi più difficili e bisognosi giungono messaggi carichi di affetto, come quello di Gabriel, 5 anni del Brasile, che scrive: «Caro papa Francesco, con i miei amici di scuola e a casa prima di dormire prego per te e per tutti i bimbi del mondo».
D’altra parte, anche il Papa un giorno è stato bambino. Ma, secondo Roberto Benigni, bambino lo è rimasto. «Il più piccolo di tutti»: così, sul sagrato di San Pietro, lo definì l’artista toscano nel monologo che chiuse la prima edizione della Gmb. Era un modo di riconoscere in papa Francesco la purezza del cuore e dei sentimenti. Nel chirografo che ha istituito il Comitato per la Gmb il Santo Padre ricorda che «nel Vangelo anche gli Apostoli temono che i bambini possano disturbare il Maestro il quale, invece, dimostra enorme simpatia verso di loro. Non solo non ne è infastidito, ma li propone come modelli del discepolato, poiché “a chi è come loro appartiene il regno di Dio” (Mc 10,14). Lo sguardo del bambino è uno sguardo spalancato sul mistero, che vede ciò che gli adulti stentano a vedere. Perciò il discepolo è chiamato a crescere nella fiducia, nell’abbandono, nello stupore, nella meraviglia: tutte caratteristiche che l’età e la disillusione, spesso, spengono nell’uomo». Facciamo nostre le parole dei più piccoli: forza papa Francesco, ti vogliamo bene! Un messaggio che attraversa confini, lingue e culture, testimoniando la forza di un legame che si rinnova ogni giorno grazie alla sincerità e alla purezza dei più piccoli.

I sogni di papa Francesco
Antonio Dall'Osto
Nei documenti e discorsi di papa Francesco ricorre di continuo il verbo “sognare” o il termine “sogno”. E ciò fin dall’inizio, da quando ha detto di «sognare una Chiesa povera per i poveri» fino all’invito rivolto ai giovani alla Giornata mondiale di Lisbona nei giorni scorsi di «sognare alla grande».
Bisogna continuare a sognare
Attualmente, a dieci anni del suo pontificato, egli continua a sognare con lo sguardo rivolto a Dio, ma nello stesso tempo tenendo i piedi ben per terra. La rivista spagnola Vida Nueva, in occasione del viaggio del papa in Portogallo, ha colto l’occasione per intervistarlo, mettendo al centro due interrogativi imperniati su questo invito che sta alla base del suo programma di pontefice: il primo: «Quali sono i sogni di Dio oggi» e «Quali sono i suoi sogni per la Chiesa in questo momento della storia».
Non senza un pizzico di umorismo, ha ribadito di voler continuare a sognare e si è riferito a san Giuseppe dicendo: «Sono convinto che soffrisse di insonnia: Non riusciva a prendere sonno perché temeva che ogni volta che si addormentava Dio cambiasse i suoi piani attraverso i suoi sogni».
Ma, a parte gli scherzi, parlando seriamente ha affermato che «una persona che smette di sognare nella vita è una persona sosa, arrugada, insipida, avvizzita. (…) C’è sempre qualcosa da sognare, così io la penso. A volte sono programmi, altre volte proiezioni… Che ne so. Però bisogna sognare. Una persona, quando sogna, spalanca le porte e le finestre. Uno che non sogna, non ha futuro; ha un futuro ripetitivo, banale».
Sogno una Chiesa “in uscita”
Ma cosa sogna padre Jorge Begoglio oggi? Continua a sognare una «Chiesa povera e per i poveri»? La risposta è molto chiara:
«L’espressione che ho usato tempo fa è una Chiesa “in uscita”: vale a dire che non sai cosa ti aspetta, però non sta chiusa dentro di sé. Non sognare ti porta alla meschinità all’incapacità di essere generoso… Sogno una Chiesa “in uscita”, una Chiesa di periferia». «In effetti – ha precisato –, per fare un esempio, il prossimo concistoro è un sogno in questo senso. Se guardiamo al numero di cardinali di curia che c’erano dieci anni fa e che ci sono adesso, o alla riduzione del numero dei cardinalati legati alle storiche sedi episcopali, si parla di quella periferia che ora è al centro. C’è il nuovo cardinale di Juba (Sud Sudan), che non sarebbe mai stato preso in considerazione, o la nomina dell’arcivescovo di Penang (Malesia), che molti non sanno nemmeno dove sia».
«Questa è la Chiesa che sogno e che, tra l’altro, è quella degli Atti degli Apostoli: Parti, Medi, Elamiti… Quella mattina di Pentecoste, in cui tutti parlavano la loro lingua, ma tutti si capivano. Adesso deve succedere: ognuno dice la sua, ma tutti ci capiamo, anche se uno accentua di più questa cosa, l’altro quell’altra. Penso che sia la Chiesa che dobbiamo cercare, e non scandalizzarci, perché abbiamo tanto confuso l’essenziale con l’accidentale! Quando ti accartocci, ti rendi ridicolo…».
C’è una parte del mondo in guerra
Difficile però sognare in un mondo come quello di oggi, segnato da una terza guerra mondiale a pezzi…
«Sì, è complicato, certamente. La dimensione tragica di oggi è grave. Dalla fine della seconda guerra mondiale, ci sono stati conflitti in varie parti. Adesso stiamo affrontando la guerra in Ucraina, che ci fa paura perché è vicina. Ma chi pensa allo Yemen, chi pensa alla Siria, chi pensa a tutti quei luoghi in Africa, per esempio, nel Kivu, nella parte settentrionale della Repubblica Democratica del Congo dove non sono potuto andare? Siamo sempre in guerra, ma siccome è lontana…Allo stesso modo, ci sembra naturale, ad esempio, che i Rohingya vaghino per il mondo perché nessuno vuole accoglierli. Solo ciò che è vicino ci spaventa. A volte vedo la cupola di San Pietro e mi dico: “Se uno di questi pazzi lancia una bomba qui, è tutto finito”. Tuttavia, anche in queste circostanze, ci sono motivi di speranza».
Si sta realizzando il sogno che lei ha espresso dieci anni fa di una Chiesa “ospedale da campo”?
«Ci sono posti dove ciò avviene, dipende. A volte, la Chiesa diventa precipitosa nel voler essere un “ospedale da campo” e sbaglia perché accelera. Cadiamo così in una deriva in cui diamo una soluzione giusta come orientamento, ma non si prendono delle soluzioni partendo dalla contemplazione del Vangelo. Non si può riformare una Chiesa al di fuori dell’ispirazione evangelica. Le soluzioni sono molto efficaci, ma fuorvianti. È una trappola molto insidiosa: le soluzioni cercate non vengono dal Vangelo. Sono frutto del buon senso, della possibilità umana di ciò che si deve fare, ma non hanno espressione evangelica. Si prendono velocemente. Hanno ragione a voler risolvere un problema, perché la gente se ne va. Penso che sia quello che sta accadendo nel cosiddetto Cammino sinodale tedesco».
Scommetto sul cammino sinodale
Alla vigilia della prossima assemblea del Sinodo a Roma, il prossimo mese di ottobre, è stata occasione per tornare su uno dei temi che maggiormente gli stanno a cuore, la sinodalità.
«Continuo a scommettere sul processo sinodale avviato da san Paolo VI. Quando si è concluso il 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, le cose erano mature per varare un documento. L’ha elaborato un’équipe di teologi di prim’ordine e io l’ho sostenuto, perché ci permetteva il percorso per arrivarci. Negli ultimi dieci anni alcune cose però sono state perfezionate, non molte. Ad esempio, prima non era nemmeno venuto in mente di interrogare i laici. Se fosse un Sinodo solo per vescovi, allora che votino i vescovi, punto! e tutti fuori, stiano ad osservare! Durante il Sinodo per l’Amazzonia, per la “pausa” durante i lavori, c’era, accanto all’aula, un ufficio riservato al papa. Mi stavo recando lì. Il primo giorno cominciarono a venire le donne, per parlare del voto. È stato il punto di partenza di un dialogo sincero. Allora ho chiesto il parere ai teologi, che hanno fatto un rapido sondaggio e hanno detto: “Sì, le donne possono votare”. Ma il Sinodo era già iniziato. Se sono membri, possono votare. E mi sono detto: “Fare questo adesso può suscitare scandalo, lo lascio per il prossimo…”, che è adesso. Il sogno è maturato fino a prendere forma».
Un’altra domanda ha riguardato la sua responsabilità di essere alla guida una nave di 1.300 milioni di cattolici, con continui problemi seri sulla sua scrivania. Molti si aspettano oggi grandi cambiamenti… È tanta responsabilità sulle sue spalle, non perde il sonno?
«Il sonno non l’ho mai perso. È una grazia: arrivo alla sera così stanco che dormo. Grazie a Dio, non sono caduto nella tentazione dell’onnipotenza, di credere di poter risolvere tutto. Certo, da buon gesuita, mi sveglio prestissimo per sfruttare maggiormente il tempo…».
Lei – ha insistito l’intervistatore – ha molto coraggio nel proporre questi cambiamenti. Non le è mai venuto in mente di lasciar perdere qualche sogno troppo rischioso?
«Certo, e la prima reazione è un no. Ma poi chiedo consiglio, e vedo se si può fare o no. Bisogna misurare fino a che punto si può andare oltre il limite e fin dove no. Si prova una certa impotenza, ma penso che sia un bene, perché impedisce di credersi un dio o un essere onnipotente. Sono i limiti che la storia e la vita impongono. Ad esempio, non ho ancora osato mettere fine alla cultura di corte in curia».
Amo stare con la gente
Di fronte a proposte che una parte della Chiesa non è preparata ad accogliere ha sottolineato che bisogna insistere sulla formazione e soprattutto sul saper uscir fuori.
«In Argentina, sentivo un po’ di allergia quando vedevo pastori che si guardavano l’ombelico, con lo sguardo ripiegato su sé stessi. Penso a un vescovo, un grande teologo, ma come pastore era una nullità. Lanciava sempre messaggi di tipo: «Attento, bisogna dire la messa così… fare questo o quest’altro. I poveri sacerdoti erano soggetti al governo di quell’uomo. Ci sono pastori che non sono pastori».
Molto interessante, al termine dell’intervista, quanto Francesco afferma circa lo stile di vita che ha scelto per il suo pontificato, ovvero quello di rimanere il più possibile vicino alla gente comune, senza preferenze o privilegi.
«Dopo essere stato eletto ci fu un grande banchetto. Ero già preparato. Ricordo cosa è successo. Dopo aver parlato alla gente, dopo aver pregato per il papa precedente, sono uscito e c’era un ascensore pronto, tutto e per solo per me. Ma ho detto “Vado con gli altri”. E, quando sono uscito, c’era pronta una limousine. E ho detto ancora: “Vado in autobus assieme agli altri”. Fu allora che mi resi conto che era avvenuto un cambiamento delle cose mi aspettavano. Dopo il banchetto, ho chiamato il nunzio in Argentina e gli ho detto: “Dica che nessuno venga”, perché immaginavo che i vescovi volessero venire, e ho suggerito che i soldi per il biglietto fossero dati ai poveri. Poi ho chiamato Benedetto XVI per salutarlo. All’inizio non ha risposto, perché stava guardando la televisione, ma, quando sono riuscito a parlargli, ho notato che era contento. La mattina dopo non riuscivo a mettermi il colletto della talare, non so perché. Sono uscito e c’era il vescovo emerito di Palermo, e gli ho detto: “Aiutami”. “Sì, certo!”, mi ha risposto. Così pure quel giorno sono sceso a mangiare in sala da pranzo assieme a tutti gli altri. E lì iniziò la vita comune che continuo a condurre oggi. Non ho cambiato il mio stile di vita e questo mi ha aiutato. È stata un’intuizione del momento. Con questa naturalezza vivo le cose e le racconto».

Note su papa Francesco
Flavio Lazzarin
La profezia di Francesco non si rivela solamente in ciò che quotidianamente ci dice, ma emerge soprattutto nel fatto che il papa non smette di parlare. Evidentemente è cosciente di vivere in un’esposizione costante, che riserva ai suoi pronunciamenti l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, divisa tra assensi incondizionati, feroci dissensi o mute, maggioritarie, paludi indifferenti o opportuniste.
Decide di comportarsi secondo l’ispirazione della sua biografia, con le sue grandezze e i suoi limiti, e appare così agli occhi di molti come un originale e indisciplinato latino-americano.
Credo, però, che questa apparente disattenzione agli esiti delle sue frequenti esternazioni, al contrario, attacchi intenzionalmente e deliberatamente la fissità dogmatica e dottrinale delle teologie malate, che poco o niente riescono a dire agli uomini e alle donne di oggi, in questo tempo di crisi.
È frutto della Provvidenza dello Spirito la lotta di papa Francesco, che pare intendere i segni dei tempi e la crisi di un edificio millenario che ormai fa acqua da tutte le parti. E sceglie di affrontare la crisi della civilizzazione occidentale – e del cristianesimo con cui l’Occidente è tessuto – con la radicalità resa necessaria dalle tensioni teologiche e politiche che segnano questa stagione della storia.
Egli si comporta come se non fosse papa, come se non fosse un Capo di Stato, come se non esistesse la Curia. Con il suo comportamento si rifiuta di ripetere il copione secolare del pezzo fondamentale dell’ingranaggio istituzionale, sempre più distante dal Vangelo di Gesù.
Le cose, però non sono così semplici e la dialettica carisma-istituzione continua e continuerà ad accompagnare il cammino dei credenti.
È ovvio che i meccanismi ecclesiastici condizionano Francesco insieme ai nemici tradizionalisti che lo perseguitano. La contraddizione è inevitabilmente presente nella sua vita: non vive come un sovrano, ma, in contromano rispetto al cammino sinodale, è condotto a comportarsi come un sovrano monarchico, assoluto, solitario, indiscutibile. Il più delle volte vince la libertà carismatica, ma il peso dell’istituzione si fa sentire sempre, perché – che ci piaccia o no – è un aspetto ontologico costitutivo nella vita della Chiesa.
Avevamo, però, certamente bisogno, dopo la stagione di Giovanni XXIII e del Concilio, superata dalle successive restaurazioni, di una primavera carismatica. Ma, appunto, come per Francesco di Assisi, che ispira Giorgio Bergoglio, questa primavera del carisma, prima o poi si spegne, regolata dai canoni del diritto canonico e dalle reinterpretazioni moderate, ma sempre traditrici, degli stessi discepoli del carismatico, che, come il Santo di Assisi, vede tramontare e morire la profezia prima della sua stessa morte.
Può sfiorire la profezia, ma per chi legge la storia a partire dalla Croce, resta comunque la chiamata a comporre minoranze abramitiche, che, guidate dall’Agape, nonostante la loro piccolezza e irrilevanza, affrontano e vincono martirialmente gli inferni della storia.
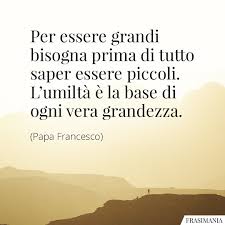
BIOGRAFIA
DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
Il primo Papa giunto dalle Americhe è il gesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, 76 anni, arcivescovo di Buenos Aires dal 1998. È una figura di spicco dell’intero continente e un pastore semplice e molto amato nella sua diocesi, che ha girato in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus.
«La mia gente è povera e io sono uno di loro», ha detto una volta per spiegare la scelta di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo. Ai suoi preti ha sempre raccomandato misericordia, coraggio e porte aperte. La cosa peggiore che possa accadere nella Chiesa, ha spiegato in alcune circostanze, «è quella che de Lubac chiama mondanità spirituale», che significa «mettere al centro se stessi». E quando cita la giustizia sociale, invita a riprendere in mano il catechismo, i dieci comandamenti e le beatitudini. Nonostante il carattere schivo è divenuto un punto di riferimento per le sue prese di posizione durante la crisi economica che ha sconvolto il Paese nel 2001.
Nella capitale argentina nasce il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti piemontesi: suo padre Mario fa il ragioniere, impiegato nelle ferrovie, mentre sua madre, Regina Sivori, si occupa della casa e dell’educazione dei cinque figli.
Diplomatosi come tecnico chimico, sceglie poi la strada del sacerdozio entrando nel seminario diocesano. L’11 marzo 1958 passa al noviziato della Compagnia di Gesù. Completa gli studi umanistici in Cile e nel 1963, tornato in Argentina, si laurea in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel. Fra il 1964 e il 1965 è professore di letteratura e psicologia nel collegio dell’Immacolata di Santa Fé e nel 1966 insegna le stesse materie nel collegio del Salvatore a Buenos Aires. Dal 1967 al 1970 studia teologia laureandosi sempre al collegio San Giuseppe.
Il 13 dicembre 1969 è ordinato sacerdote dall’arcivescovo Ramón José Castellano. Prosegue quindi la preparazione tra il 1970 e il 1971 in Spagna, e il 22 aprile 1973 emette la professione perpetua nei gesuiti. Di nuovo in Argentina, è maestro di novizi a Villa Barilari a San Miguel, professore presso la facoltà di teologia, consultore della provincia della Compagnia di Gesù e rettore del Collegio.
Il 31 luglio 1973 viene nominato provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Sei anni dopo riprende il lavoro nel campo universitario e, tra il 1980 e il 1986, è di nuovo rettore del collegio di San Giuseppe, oltre che parroco ancora a San Miguel. Nel marzo 1986 va in Germania per ultimare la tesi dottorale; quindi i superiori lo inviano nel collegio del Salvatore a Buenos Aires e poi nella chiesa della Compagnia nella città di Cordoba, come direttore spirituale e confessore.
È il cardinale Quarracino a volerlo come suo stretto collaboratore a Buenos Aires. Così il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo nomina vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno riceve nella cattedrale l’ordinazione episcopale proprio dal cardinale. Come motto sceglie Miserando atque eligendo e nello stemma inserisce il cristogramma ihs, simbolo della Compagnia di Gesù. È subito nominato vicario episcopale della zona Flores e il 21 dicembre 1993 diviene vicario generale. Nessuna sorpresa dunque quando, il 3 giugno 1997, è promosso arcivescovo coadiutore di Buenos Aires. Passati neppure nove mesi, alla morte del cardinale Quarracino gli succede, il 28 febbraio 1998, come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel Paese, gran cancelliere dell’Università Cattolica.
Nel Concistoro del 21 febbraio 2001, Giovanni Paolo II lo crea cardinale, del titolo di san Roberto Bellarmino. Nell’ottobre 2001 è nominato relatore generale aggiunto alla decima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, dedicata al ministero episcopale. Intanto in America latina la sua figura diventa sempre più popolare. Nel 2002 declina la nomina a presidente della Conferenza episcopale argentina, ma tre anni dopo viene eletto e poi riconfermato per un altro triennio nel 2008. Intanto, nell’aprile 2005, partecipa al conclave in cui è eletto Benedetto XVI.
Come arcivescovo di Buenos Aires — tre milioni di abitanti — pensa a un progetto missionario incentrato sulla comunione e sull’evangelizzazione. Quattro gli obiettivi principali: comunità aperte e fraterne; protagonismo di un laicato consapevole; evangelizzazione rivolta a ogni abitante della città; assistenza ai poveri e ai malati. Invita preti e laici a lavorare insieme. Nel settembre 2009 lancia a livello nazionale la campagna di solidarietà per il bicentenario dell’indipendenza del Paese: duecento opere di carità da realizzare entro il 2016. E, in chiave continentale, nutre forti speranze sull’onda del messaggio della Conferenza di Aparecida nel 2007, fino a definirlo «l’Evangelii nuntiandi dell’America Latina».
Viene eletto Sommo Pontefice il 13 marzo 2013.