La mia voce matura..ovvero teologia del quotidiano attraverso piccoli grandi testimoni di fede..germogli di novità

Essere cuori pensanti
Uno speciale percorso.. attraverso lo sguardo di donne e uomini cogliendo la grazia che ha illuminato la loro esistenza facendone ragione di vita, dono per gli altri e una proposta di vita per tutti noi!
Il Poeta raccoglie i dolori e sorrisi e mette assieme tutti i suoi giorni in una mano tesa per donare, in una mano che assolve perché vede il cuore di Dio. I fiori del Poeta sbocciano per vivere molto a lungo per le vie della grazia.
Alda Merini
"Penso che lo farò: «mi guarderò dentro» per una mezz’oretta ogni mattina, prima di cominciare a lavorare: ascolterò la mia voce interiore. Sich versenken, «sprofondare in se stessi». Si può anche chiamare meditazione; ma questa parola mi dà ancora i brividi. E del resto, perché no? Una quieta mezz’ora dentro me stessa. Non è sufficiente muovere braccia, gambe e tutti gli altri muscoli nel bagno, ogni mattina. Un essere umano è corpo e spirito. E una mezz’ora di esercizi combinata con una mezz’ora di «meditazione» può creare una base di serenità e concentrazione per tutto il giorno. Non è però una cosa semplice, quella stille Stunde, «ora quieta»; bisogna impararla. Prima è necessario spazzare via dall’interno tutte le insignificanti preoccupazioni, i detriti. In fin dei conti, persino in una testolina così piccola c’è sempre una montagna di distrazioni irrilevanti. É vero che ci sono anche sentimenti e pensieri edificanti, ma il ciarpame è sempre presente. Sia questo, dunque, lo scopo della meditazione: trasformare il tuo spazio interiore in un’ampia pianura vuota, senza tutta quell’erbaccia che impedisce la vista. Così che qualcosa di «Dio» possa entrare in te, come c’è qualcosa di «Dio» nella Nona di Beethoven. E anche qualcosa dell’«Amore», ma non quella sorta di amore di lusso in cui ti crogioli di buon grado per una mezz’ora, orgogliosa dei tuoi sentimenti elevati, bensì amore che puoi applicare alle piccole cose quotidiane."
Etty Hillesum
Ernesto Balducci..l'uomo del dialogo

E’ necessario un mutamento culturale… Il passaggio da una civiltà che aveva assunto la competizione come molla del suo stesso sviluppo ad una civiltà dell’apertura dell’uomo all’uomo… della collaborazione… della solidarietà… (Se vuoi la pace prepara la pace, atti del convegno nazionale di Testimonianze 1981)
Accettando la propria finitezza… L’uomo trova il primo senso di sé nel trascendere se stesso per mettersi al servizio dell’umanità… Dalla consapevolezza della necessità di questa transizione nasce il nuovo umanesimo… Il tratto essenziale del nuovo umanesimo è la fede nell’uomo e precisamente la fede nella possibilità di abbandonare l’età delle guerre… La fede dell’uomo non è dunque una virtù mistica, è una virtù razionale, vorrei dire laica… (L’uomo planetario)
Così si prefigura un pacifismo di nuovo tipo… la pace… Non va pesata sulla fede religiosa(o altra)… Ma su ciò che negli uomini è comune, sulla loro natura razionale, la cui voce è la coscienza.… (Se vuoi la pace prepara la pace, atti del convegno nazionale di Testimonianze 1981)
L’etica si rivela per quello che è, la vera religione naturale… con la quale dovranno misurarsi le cosiddette religioni positive… L’organo della nuova religione naturale, destinata ad accomunare gli uomini di ogni credenza è, per usare una bella espressione di Gandhi, la “piccola silenziosa voce della coscienza”. La voce della coscienza è la voce dell’uomo nascosto che abita, come principio di unificazione trascendente, dentro la molteplicità dell’uomo edito, con le sue morali, le sue religioni, le sue ideologie.
Nella nostra cultura si è soliti considerare la coscienza come il pronunciamento pratico della ragione, tenendo in ombra la sua vera prerogativa che è di creare, sulla spinta inesauribile del trascendimento, risposte nuove a situazioni nuove
E. Balducci, La terra del tramonto, pag. 172-174

Il senso del nostro credere
Ernesto Balducci – da “Il mandorlo e il fuoco” vol. 3^ anno C
…La realtà della Resurrezione noi dobbiamo proporla con forza ogni giorno nel nostro cammino. E saremo costretti a farlo nella misura stessa in cui quelli che sono i relitti delle tradizioni religiose, saranno dissolti e noi rimarremo con davanti agli occhi nessun segno sacro della realtà di Gesù e avremo la necessità di riscoprirla nella sua misteriosa presenza. Se vi dicono: Cristo è qui, è là, non ci credete, Egli disse prima di lasciarci. Perché il Cristo si vede ovunque, ma non è in nessun posto in modo limitativo. Ecco allora il problema che oggi mi sollecita, anche per ragioni di esperienze comuni che stiamo vivendo. In un tempo di tale disgregazione in cui non solo la nostra realtà sociologica di credenti sembra abbandonata ormai alla deriva, ma la stessa società tradizionale nei suoi rapporti costitutivi sembra colpita da necrosi, e la ferocia ci invade ed occupa quotidianamente le cronache pubbliche come fatto più importante, in un tempo simile che senso ha parlare di Gesù risorto? È una soddisfazione privata? È un modo con cui – in un tempo di ferocia – ci creiamo il giardino delle idilliache soddisfazioni che ci consentono, almeno la domenica, di assentarci dalla competizione feriale? Che cos’è la nostra fede? Un’isola? un convento? un giardino segregato? Se così fosse saremmo già fuori del mistero del Cristo. Il quale, non ci dimentichiamo, ha vissuto una passione pubblica (è stato ucciso e condannato, come ci ricorda la Scrittura di oggi, pubblicamente, secondo la Legge) ed è risorto dando testimonianza di Sé a coloro che Dio aveva prescelto perché fossero gli araldi del grande evento. Cioè il Gesù della Resurrezione non è un idolo per una setta; i suoi eventi toccano le nervature della storia; sono, di loro natura, pubblici, universali; e perciò il suo mistero si racconta sulle pagine dell’esperienza pubblica e collettiva. La religione (la chiamerò così per quanto il termine perde già di legittimità) che ci lega al Cristo, non è una religione settoriale, che sta accanto alle nostre occupazioni profane, per darci, poi, un complemento che riguarda la vita dell’al di là. La fede in Cristo coinvolge la totalità dei nostri rapporti. Ebbene, come troverò io il modo di vivere questa fede in un tempo come questo? Più volte abbiamo fatto riferimento, nelle nostre riflessioni domenicali, ad alcune emergenze umane sia individuali che collettive, in cui è possibile cogliere – secondo quel nesso che è «il genio del cristianesimo – delle possibilità concrete di verificare la nostra fede cristiana e di proporla. Non già con messaggi altisonanti, non già con riti religiosi collettivi, ma attraverso i tramiti stessi dell’essere uomini; attraverso i modi stessi del nostro partecipare all’opera comune della costruzione di una città meno disumana di questa. Io credo che il primo riflesso di questa fede nel Gesù della Resurrezione, è la passione per la vita, il discernimento delle forze della vita in mezzo alla civiltà della morte. Sempre di più questo compito si fa pressante. […] Il discernimento della vita non è una passione qualsiasi per la difesa della vita ecologica o biologica. Può essere anche questo ma dobbiamo stare attenti a non portare su di noi il peso di un passato in cui eravamo come appiattiti nella logica delle cosi dette leggi naturali, che poi non si sa mai che cosa siano. La passione per la vita è una passione promotrice, una passione che discerne i valori. E intanto mira a rompere quel nodo che strozza la vita a dimensioni collettive: la subordinazione dell’uomo alla logica dell’avere, del possesso, del produrre. È un luogo comune ma i luoghi comuni nascondono spesso una intuizione collettiva. In questo caso la intuizione rende la coscienza impaziente ed a volte furiosa! Nelle stesse ondate giovanili che mettono a soqquadro il nostro ordine, dobbiamo riconoscere con occhio intuitivo, la passione delusa per una società in cui vivere sia possibile. I cristiani invece di fare le loro reiterazioni religiose, le loro retoriche di circostanza, si impegnino in questa costruzione di una società in cui la vita sia al primo posto. È importante che ciascuno di noi, nella diversità delle sue collocazioni, ricerchi, secondo questo criterio, il senso della propria vocazione…
Ernesto Balducci – da “Il mandorlo e il fuoco” vol. 3^ anno C

Ernesto Balducci, un mistico
di Lodovico Grassi
Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Ernesto Balducci, 30 dalla sua morte. E oggi, come mai, le sue parole di pace, fratellanza, convivenza, integrazione e accoglienza risuonano come fossero state pronunciate in questi giorni, in un’attualità che supera i confini del tempo.
Che Balducci sia stato un mistico, confessore della fede cristiana, oltre che indagatore dell’esperienza religiosa universale, è il filo conduttore e la chiave interpretativa imprescindibile per comprendere, pur rifuggendo da ogni interpretazione e riduzione di carattere «spiritualistico», la profonda unità della sua vita e della sua opera.
Il cristiano del futuro
«Il cristiano del futuro sarà mistico o non sarà». Così più volte l’ultimo Rahner, di cui il Leggere Karl Rahner (1) ripercorre l’itinerario teologico e spirituale vissuto nel segno di questa affermazione.
Ecco, Balducci uomo e cristiano del futuro «L’uomo del futuro o sarà uomo di pace o non sarà» è stato un mistico (2).
E qui si apre il discorso su Balducci confessore della fede, mistico e teologo dell’esperienza mistica, oltre che indagatore a tutto campo dell’esperienza religiosa universale.
Un discorso delicato e difficile, ma imprescindibile e fondamentale per la comprensione della sua vita e della sua opera (3).
Chi gli è stato vicino o lo ha avvicinato – negli spazi della comunicazione liturgica o di quella personale e spirituale – può testimoniare che abitava in lui un fuoco segreto capace di divampare all’esterno (nella predicazione, nella meditazione e nel colloquio, ma anche, con sprazzi improvvisi, nelle conferenze, nei dibattiti e negli scritti d’intervento), per poi tornare a rinchiudersi nella cella del cuore, nel centro della sua persona. Un’esperienza di fede ad alto grado di intensità e di coinvolgimento esistenziale. Per avvertire e discernere questa esperienza – di cui Balducci ha parlato e scritto direttamente rare volte – si presuppone (e in questo senso il discorso è «delicato») il dono della fede; ma (e in questo senso il discorso è «difficile», ma non impossibile) anche una razionalità aperta e non dogmatica – si pensi al Bergson de Les deux sources – può raccoglierne gli indizi e le manifestazioni, perlustrandone la fenomenologia con attenzione e rispetto. In questo senso il «registro antropologico» che Balducci ha applicato a Francesco d’Assisi potrebbe essere, in modo analogico, applicato a Balducci. Non è un caso, né un eccesso di simpatia spirituale, che Benedetto Calati abbia potuto dire, nel contesto di una celebrazione eucaristica, che la vera autobiografia di Balducci è il suo Francesco d’Assisi. Non la parallela «storia di un’anima», ma l’espressione di una sintonia, di un’affinità elettiva, spirituale e profetica, l’affermazione della stessa radice dell’esperienza mistica: la fede nel Dio di Gesù Cristo, nella Parola consegnata alla Scrittura (norma normans), accolta, vissuta e annunciata nello Spirito.
«Notte oscura» e radicalità della profezia
«… L’indefessa missione di annunciatore della Parola nel contesto dell’eucarestia è stato il filo conduttore della mia vita che non si è mai spezzato» (4).
Con questa «tesi» non si vuole certo operare una impossibile riduzione spiritualistica della complessità, ricchezza e molteplice fecondità di uno straordinario itinerario umano, culturale e politico, ma indicarne la radice, il segreto, la condizione di tenuta, senza di che non si capisce fino in fondo nulla, né delle coraggiose aperture dell’inizio né degli ultimi estremi coinvolgimenti, né della stessa laicità progressivamente conquistata e irremovibilmente proclamata e vissuta.
Quell’itinerarium mentis in hominem che acutamente è stato indicato come chiave interpretativa e specificità della ricerca e dell’azione, della testimonianza pubblica, culturale, teorica e pratica di Balducci, è sotto questo profilo il passaggio attraverso una radicale via «purgativa» senza soluzioni di continuità con una via «illuminativa» ed una via «unitiva» di particolare intensità.
La notte dell’Occidente è anche una «notte oscura», la svolta antropologica ha come premessa non l’appiattimento ma la radicalità della profezia, l’uomo planetario non è il punto d’arrivo o la meta ideale di una transizione storica senza fondamento, la pace non è solo opus justitiae humanae:
«Ci tengo a testimoniare che lo svolgimento del discorso sulla pace viene a coincidere, materialmente, anche se non sempre formalmente, con l’attualizzazione della profezia evangelica. Insomma, sebbene mi trovi, per usare una qualifica ormai desueta, in zona laica, non mi sposto di un capello dal mio asse evangelico. Più che di una transizione alla laicità, come a volte mi è avvenuto di dire, si tratta di una immersione della laicità nella profezia, di una iscrizione della razionalità comune dentro il cerchio di un orizzonte che ha misure ben più vaste di quelle della ragione; è lo stesso orizzonte dell’uomo possibile, su cui batte la stessa luce che, nei momenti di preghiera, illumina il mio occhio contemplativo. La mia è, dunque, per usare l’espressione di un Padre greco, una fuga immobile» (5).
Dagli scritti degli anni 50 e 60 alla theologia crucis e alla teologia negativa presenti anche ne La terra del tramonto, il «filo conduttore» si evolve, innerva scansioni, rotture e discontinuità in senso forte – non necessariamente in direzione di un continuo «superamento» –, ma resta sostanzialmente intatto. Non so se Balducci avesse un «memoriale» come quello di Pascal; ciò di cui sono sicuro è che egli ha vissuto almeno quella stessa esperienza.
L’esperienza religiosa
Gli scritti del 1954 e del 1962, che sono meno noti, ci parlano di un Balducci statu nascenti e insieme già indagatore maturo dell’esperienza religiosa.
L’esperienza religiosa (6) è il titolo di un volumetto di poco più di 100 pagine, ma densissimo e significativo, in cui Balducci riscrive – salvando la maggior parte del testo e cancellando, per ragioni presumibilmente editoriali, le ricchissime note – un saggio intitolato L’anima e l’esperienza religiosa (7).
In AER Balducci mostra, nelle note e nella bibliografia di riferimento, di essere aggiornato sui principali studi relativi al tema; in ER implicitamente rivela, per la parte aggiunta e anche solo per variazioni di linguaggio o di una sola parola, la maturazione teologica maturata a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 attraverso la lettura e talvolta la conoscenza personale dei teologi europei più rilevanti e incisivi nella stagione conciliare.
In apparenza rapsodico ed eclettico, Balducci segue una sua linea che lo porta ad assimilare e trasfigurare con un metabolismo veloce ma non arbitrario: è vero che sempre meno ama citare le fonti (per «noncuranza» e malcelata disistima nei confronti dello stile accademico), ma ciò va letto, mi pare, come assunzione in proprio della responsabilità di quello che dice, senza appropriazioni indebite e per rispetto delle originalità a cui la sua indiscutibile originalità si è alimentata ed è divenuta capace di volare da sola (ma sono frequenti in tutto il suo iter di originalissimo «saggista» espliciti riconoscimenti di debito ed espressioni di gratitudine).
Nella sua molteplice attività di oratore famoso e richiesto, di conferenziere, di scrittore, di annunciatore della Parola nel contesto eucaristico, Balducci dispiega i suoi doni eccezionali di intelligenza, di intuizione creativa, di eloquio spontaneo e rigorosissimo (non ha mai, se non costretto, trascurato la preparazione immediata pur avvalendosi di una sempre più vasta preparazione remota) e, soprattutto, il suo carisma di uomo di fede totalmente consegnato a Dio e allo Spirito creatore che soffia quando e dove vuole. Di tutto questo Balducci è stato consapevole, con timore e tremore che la sua aisance in ogni contesto non riusciva sempre a coprire. In questo Balducci è rimasto sostanzialmente fedele ai criteri messi a punto negli anni della formazione a Roma: se il «metodo» allora quasi ossessivamente cercato con ripetuti propositi è ormai diventato elemento del suo vivere, parlare, scrivere, agire, resta la sofferta dialettica tra l’umiltà trepida (e in continua attesa: praestolari cum silentio!) e la consapevolezza di una vocazione eccezionale e di una missione specifica da compiere nel mondo.
In AER e in ER Balducci si pone come studioso e anche, in qualche modo, storico diacronico e sincronico dell’esperienza religiosa universale. Non è, e sa di non esserlo, «neutrale». Anzi, rivendica per il credente una particolare abilitazione a parlare di esperienza religiosa e di mistica.
È bene, a questo punto, lasciargli la parola.
«Il soggettivismo religioso disconosce il dogma ed il comandamento per lo stesso motivo per cui disconosce la struttura razionale della fede. Ogni volta che un gruppo di uomini professa una religione di carattere nettamente determinato, non mancano mai credenze collettive il cui valore formale non è il sentimento di chi le accoglie ma la divina autorità che le impone. E la psicologia più acuta concorda con l’etnologia nel metter in rilievo l’importanza della lettera per lo stesso sviluppo dello spirito religioso, la sua efficacia, vorrei dire maieutica e dinamica. Le pagine di Blondel a tale riguardo sono indimenticabili. Se la religione è amore, essa è piuttosto amore effettivo che amore affettivo, né basta, per essere religiosi, sentire le cose di Dio, ma occorre volerle. Volerle, si capisce, così come il Dio creduto si è degnato di imporre: la sua imposizione per la coscienza religiosa è gaudioso privilegio di cui essa non saprebbe fare a meno» (8).
«Nessuna metafisica può esaudire i voti più segreti che agitano lo spirito umano e da cui essa stessa prende le mosse. (…) Non è forse questo il motivo per cui le dimostrazioni logiche dell’esistenza di Dio non bastano a provocare l’adesione intellettuale, nonostante la loro oggettiva validità? Forse esse presuppongono come preambolo una specie di cognizione immediata ed oscura dell’Assoluto in noi. Nessuna dialettica è capace di persuadere invincibilmente della realtà dello spirituale. In rapporto allo slancio della nostra natura, le argomentazioni metafisiche non sono che linee direttive, trame sottili d’orientamento: solo l’esperienza le può riempire di un contenuto reale, introducendo la persona vivente in contatto con Dio, secondo le norme che la ragione riesce ad anticipare» (9).
In AER e in ER Balducci percorre in lungo e in largo, con dovizia di citazioni nonostante la relativa brevità dei testi, l’esperienza religiosa cristiana e non, quella dei «mistici» e quella dei «comuni» cristiani, enunciando i criteri di discernimento di ogni autentica esperienza della mistica cristiana (10), ribadendo più volte «che la natura e la Grazia, nella loro ideale dimensione, sono l’una radicata nell’altra, in piena e prestabilita armonia» (11), indicando, come cristiano partecipe, in modo imperfetto ma realmente incoativo, della loro esperienza, che nel volto dei mistici «scopriamo il nostro volto futuro, l’anticipazione di un’esperienza che diventerà normale quando avremo deposto il peso ed il limite della nostra mortalità» (12).
La lezione di Blondel
Il trait d’union più forte di AER e ER con il primissimo Balducci della formazione romana è da rintracciare senz’altro nella lezione del Blondel, soprattutto de L’Azione, a cui il giovane Balducci aderisce con convinzione ed entusiasmo per la sua valenza liberatoria.
Nel suo diario (1943) scrive: «Belle pagine sull’efficacia della pratica sulla volontà (IX 205-210)
a) “l’azione è una parte integrante dell’intuizione, la vivifica e la illumina e avvia la volontà verso i suoi fini, col definirne a poco a poco e con l’attrarne l’ideale”
b) “Mediante l’azione l’intenzione morale s’insinua nelle nostre membra, fa battere il nostro cuore e cola la sua propria vita nelle nostre vene…”
Non credo opportuno soffermarmi qui a sviluppare questi concetti poiché dovrò tra breve considerare su lo stesso argomento altre pagine, sempre del Blondel, di sì meravigliosa novità e bellezza che alla prima lettura non ho saputo tenermi dal saltare di gioia nella mia camera. Una grande luce si è fatta nell’anima mia (5 gennaio 1943)».
In Blondel Balducci trova insieme il capovolgimento delle sue convinzioni intellettuali (gennaio 1943) e la conferma della giustezza delle sue aspirazioni spirituali più profonde: «”La bellezza ha un incanto che va ben oltre e ben al di sopra di chi la sente e di chi ne è rivestito… È un sentimento che per la sua stessa ampiezza e per il suo irradiamento diventa un’angoscia e un mistero; quasi che, in ciò che amiamo, la nostra ammirazione fosse rivolta a un lontano e più possente amore, di cui la bellezza conosciuta sarebbe un puro simbolo inadeguato” (Blondel X 40).
O Cristo Cristo sei tu la misteriosa bellezza cui si volge il mio amore? Non sento forse io una insoddisfazione anche quando ammiro?
Tutto che fa vibrare l’anima mia o Cristo è un riflesso di te Bellezza eterna. Ed è in te che io potrò compiere l’armonica sintesi tra verità-Bellezza e amore (10 gennaio 1943)».
E ancora: «Ed eccomi alle pagine più interessanti del libro del Blondel (X, 265-279).
Quante volte mi ha turbato il pensiero che nella nostra religione il soprannaturale scende nei particolari della vita pratica con segni materiali! Credere che, sotto la determinazione particolare dei dogmi, dei riti, e delle pratiche il trascendente sia immanente senza nulla perdere della sua infinità mi sembra a volte alquanto superstizioso. Ebbene, il Capitolo del B.[londel] Valore della pratica letterale ha dissipato ogni mio turbamento (13 gennaio 1943)».
Aggiungiamo una nota significativa: nell’originale francese del 1893 (Balducci aveva a disposizione nel 1943 solo una traduzione italiana), alla settima pagina del Capitolo citato, e precisamente a p. 411, il titolo corrente suona così: «la lettre vivifiante et libératrice» (espressione che non compare nel testo, ma certamente blondeliana) e costituisce la chiave di lettura di tutto il capitolo e, in qualche modo, dell’intero capolavoro di Blondel (13).
Con questo «sigillo» chiudiamo una riflessione destinata a più sviluppi proprio nell’odierna congiuntura teologica rispetto alla quale la lezione di Balducci, e la sua anagrafe, non è irrilevante.
La spada in pugno
Un intreccio fecondo, dunque, quello di Balducci, fra l’esperienza (e la teologia) della fede e l’impegno culturale e politico nel mondo, la cui tempestività e la cui valenza profetica si possono misurare a partire non solo da alcuni esempi testuali e fattuali, ma dalla continua attività itinerante di conferenziere e dallo stabile esercizio pastorale nella comunità di residenza (e oltre) e dal 1965 soprattutto nella comunità di Badia Fiesolana.
Balducci uomo della ricerca spregiudicata, del confronto continuo con la quotidianità politica e culturale, dell’impegno per un futuro migliore dell’umanità fino all’utopia dell’uomo planetario, era dunque saldamente radicato in una fede che costituiva per lui il segreto di tutto. Il senso della vita, del suo destino personale e della sua missione nel mondo erano legati a questo nucleo: Balducci non amava esibire la sua fede, piuttosto la occultava, ma anche il non-credente percepiva che dietro quell’intelligenza straordinaria palpitava una adesione a Cristo appassionata e irrinunciabile. Si pensi alle pagine intense in cui Balducci descrive il suo incontro con Mazzolari e l’emozione provata nel servirgli la messa e nel leggere, giovanissimo, un suo libro (Compagno Cristo): «In quel momento – confessa Balducci – sentii che un fuoco cresceva dentro di me e che mi veniva messa in pugno una spada che non mi sarà più lecito riporre nel fodero».
Purtroppo alcuni hanno frainteso l’impegno degli ultimi anni della vita di Balducci, come se si fosse dimenticato della dimensione ecclesiale o addirittura avesse messo in secondo piano la fede in favore di un «piatto umanesimo». La Chiesa era per lui lo spazio vitale, come la sua comunità religiosa; solo che egli la intendeva come eucaristia, in un senso molto più ampio e vitale della struttura puramente giuridica.
Dalle religioni alla religione
Parlando di sé una volta Balducci confidò: «Sono partito dalla religione e ora vi ritorno dopo un lungo periplo». Il giovane Balducci parte dai testi classici della teologia tradizionale, però, facendo tesoro della lezione di Blondel, comincia a leggerli in maniera diversa. Recupera, ad esempio, quella tensione verso l’assoluto che è insita nella natura umana e che si esprime attraverso la religione. In questa fase fede e religione sono agglutinate. Ci vorrà del tempo prima che incontri Barth e Bonhoeffer, il primo critico radicale della religione, il secondo teso ad esprimere i contenuti e i concetti biblici in modo mondano. Allora la distinzione fede-religione si fa più netta, anche se bisogna ammettere la difficoltà di una fede pubblica che non si esprima in forme in qualche modo religiose. Il Balducci dell’ultimo periodo riscopre la religione scoprendo le religioni. Dove si riscontra questa svolta? Ne fa fede soprattutto L’uomo planetario, in cui pone il cristianesimo come una religione accanto alle altre. In quest’opera Balducci mette sotto inchiesta le religioni e le accusa di non aver superato la «barriera» dello stato di diritto, quella sociale e infine quella della pace. Di fronte al tradimento delle chiese, è stato proprio l’illuminismo a riprendere i valori cristiani fondamentali; eppure l’ispirazione cristiana originaria non si è mai spenta e continua a fermentare sotterraneamente la cultura occidentale.
Balducci critica la modernità non per un pregiudizio antimoderno, ma in nome dei valori giusti che essa ha veicolato. Comunque «il ritorno alla religione» significava per Balducci un mettersi nella condizione esistenziale di un non credente, come uomo accanto ad altri uomini perché nessuno sa se la sua fede è autentica e anche il credente sente l’esigenza di chiedere: «aiuta la mia incredulità».
Come un testamento spirituale
Altrove (14) ho avuto modo di dire che per me L’uomo planetario è l’opera più matura e più mistica. Anche la conclusione «non sono che un uomo», di cui Balducci non poteva non ricordare l’anagrafe neotestamentaria (Atti 10, 25-26: Pietro che dice al centurione prostrato «Alzati, anch’io sono un uomo»), è un momento di teologia negativa, una conclusione forte che riassume tutto un itinerario. La terra del tramonto scandisce le «figure» storiche del cammino umano ed è opera tragica pur nell’intenzione prolettica evidenziata nel sottotitolo (Saggio sulla transizione). Emerge qui l’epifania dell’Altro. L’Altro, un orizzonte profetico è, insieme a La terra del tramonto, come un testamento spirituale, tra la rivoluzione della memoria e l’istanza della Cosmopoli (Il sogno di una cosa!). Le due ultime opere di Balducci risentono del ritmo più che umano della inesauribile sua disponibilità ad accorrere dovunque fosse chiamato a scrivere articoli e interventi, a parlare e a confortare. È nello stesso tempo di questa eroica produzione che Balducci, invitato, pochi mesi prima della morte, dal suo padre provinciale (e amico fraterno) a fare gli esercizi spirituali, risponde: «Vengo molto volentieri perché la cosa che mi interessa di più ora è la spiritualità».
L’ultimo Balducci
Ma la vera opera conclusiva di Balducci è la pubblicazione postuma delle ultime omelie (15). In queste omelie, come sempre in Balducci, è presente, non sempre in modo esplicito, il riferimento alla storia e all’attualità. Esse fanno parte del vissuto etico-politico dell’ultimo Balducci, quello degli anni 1989-1991: gli anni del crollo del muro di Berlino e del comunismo; gli anni della prima guerra del Golfo che lo vide coinvolto a più livelli in prima persona e lo vide sperare nel «primo vagito» dell’ONU (speranza dell’uomo di pace, non del pacifista) e patire la sconfitta del «rantolo di morte», dei documenti (e delle strutture di pace) emersi dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e ora galleggianti sulla melma nera della guerra.
La prima omelia, del 1 dicembre 1991 (pp. 13-20) ha come titolo «Il sogno di una cosa». Significativa è la conclusione: «Nell’arco della mia vita questo è il momento più deludente perché sono cadute molte speranze, non importa se mal riposte. A me interessa il sogno dei popoli, delle persone, dei poveri e se quel sogno va deluso la storia è priva di senso, siamo dentro il dominio della menzogna. Ma invece – ecco dove una fede che è insieme teologale e morale mi sorregge – questo sogno non finirà. Ne vedo i segni da ogni parte del mondo, vicino a me lontano da me. Non sono però i segni su cui chiede attenzione l’organizzazione dell’informazione che fa parte della dissipazione pubblica onnipotente (…). Siamo dentro una società che ci spreme nel midollo per far venir fuori bisogni impensabili in quanto essa vive sui nostri bisogni e quindi ci impedisce di prendere contatto con noi stessi (…). Non è vero che siamo progrediti perché il progresso va misurato sul consenso interiore e sulla realizzazione di questo sogno di una cosa che è il regno della giustizia sulla terra, come dice Geremia: “Egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra”. No, quel giorno non è venuto, è ancora lontano, dobbiamo stare con la testa alzata per vedere i segni. Ogni attimo è l’attimo in cui squilla il segnale della vicinanza dell’adempimento se abbiamo orecchi da intendere».
La prima omelia dovrebbe essere letta sinotticamente con quella dell’1 gennaio 1992 (pp. 59-67), che ha per titolo «Le speranze ferite». Balducci tentato dal pessimismo? Forse, ma più opportuno evocare l’ottimismo tragico del suo amato Mounier.
L’ultima omelia, quella della Pasqua (del 19 aprile 1992) ha per titolo «Le pietre dei sepolcri». Avviandosi alla conclusione Balducci evoca sorprendentemente il diavolo e cioè la menzogna di cui dobbiamo liberarci: «La logica della crocifissione è capovolta, è diventata logica di dominio. Da questa premessa è stato possibile lo sterminio degli indios, più terribile ancora dei forni crematori. Tutto questo lo dimentichiamo. La nostra fede religiosa si libera dai brutti ricordi, li emargina per vivere nella soddisfazione di sé. Ma così noi non troveremo la fede nella resurrezione (…). Noi sappiamo che significa resurrezione per l’umanità, significa che la gran parte degli uomini esca dal potere del diavolo. Io non voglio dire i nomi del diavolo, ne ho tanti in mente, comunque sono nomi che indicano il calcagno posato sulla testa del povero, la bocca tappata di chi ha verità da dire, la dimenticanza, nell’euforia pubblica, di quelli che non possono partecipare al nostro banchetto, perfino nella società opulenta. Leggevo che nell’Europa del benessere ci sono trenta milioni di poveri sotto il livello minimo della vita. Chi si ricorda di loro? Liberarsi dal diavolo vuol dire liberare anche noi stessi, liberare da questa menzogna; cioè, per ripetere le parole simboliche di Paolo, significa “celebrare questa festa non con il lievito di malizia e di perversità ma con azzimi di sincerità e di verità”. Non voglio dire altro».
1 A. Raffelt, H. Verweyen, Leggere Karl Rahner, gdt 301, Queriniana, Brescia 2004, pp. 145-149.
2 Per un orientamento ampio e universale sulla mistica si vedano: voce mistica in Dizionario critico di teologia, a c. di J.-Y. Lacoste – ed. italiana a c. di P. Coda –, Borla – Città Nuova, Roma 2005; voce mistica in Teologia, dizionario a c. di G. Barbaglio, G. Bof, S. Dianich, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2002;
voce mistica in Enciclopedia delle religioni, a c. di A. M. Di Nola, Vallecchi, Firenze 1970-1975.
3 Per questa comprensione si veda il Cerchio che si chiude, intervista autobiografica a c. di L. Martini (d’ora in poi CCSC). Ma del compianto e sempre presente Luciano Martini si veda l’opera La laicità nella profezia. Cultura e fede in Ernesto Balducci, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2002, assolutamente fondamentale e tuttora unica.
4 E. Balducci, CCSC, op. cit. p. 144
5 E. Balducci, CCSC, p.153.
6 E. Balducci, L’esperienza religiosa, Borla Editore, Torino 1962: d’ora in poi ER.
7 E. Balducci, L’anima e l’esperienza religiosa, pubblicato nel volume collettaneo a cura di M. F. Sciacca, L’anima, Morcelliana, Brescia 1954, d’ora in poi AER.
8 E. Balducci, ER, pp.24-25.
9 E. Balducci, ER, pp. 32-33; in AER, p. 246, Balducci cita Maritain in nota e, nella nota precedente, rinvia sul punto a Tommaso d’Aquino: «L’ultimo passo della nostra conoscenza di Dio è nel conoscere che non lo conosciamo», In Boëtium de Trinitate, I, qu. 4, a. 1.
10 E. Balducci, ER, pp.79-80.
11 Ivi, p.104.
12 E. Balducci, ER, p.104; AER, p.261.
13 M. Blondel, L’action, 1893.
14 Un mistico un po’ particolare, colloquio con L. Grassi a c. di A. Rossi, «L’altrapagina» n. 5, maggio 2002, pp. 23-24.
15 E. Balducci, Il tempo di Dio, Ultime omelie (Avvento 1991 – Pasqua 1992), Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole (Firenze), 1996.
Padre Giovanni Vannucci..la libertà del Vangelo
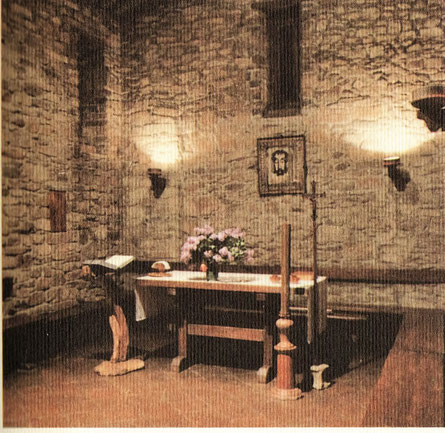
Il sogno di padre Giovanni si può leggere ancora oggi sulla soglia delle Stinche: «In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e, libero da costrizioni, potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace, di riflessione per ogni viandante che vi giunge, un posto dove l’ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo»

Una tenda vi basti a riparo
dalle bufere e Dio ritorni vagabondo
a camminare sulle strade
a cantare con voi i salmi del deserto
Giovanni Vannucci

Aprirsi all'abbraccio divino
“Tra noi e Cristo c’è uno spazio di silenzio. E allora dobbiamo andare a lui profumandoci di silenzio. Immergendoci in questo silenzio raggiungere Cristo attraverso questo spazio di deserto, di silenzio, di solitudine, che non è terreno: è uno spazio di anima”. (G.V.)
Di fronte al diluvio universale di questa epoca, diluvio di parole e di immagini, è necessario costruirsi un’arca di silenzio per incontrare se stessi, e, nella profondità di sé, aprirsi all’abbraccio divino.
“Il silenzio è quello spazio in cui il divino non è più invocato, ma presente nel cuore”. La preghiera è l’attività specifica dell’uomo che cerca di comprendere il silenzio, che è aldilà delle cose, dell’uomo, delle parole, dei riti, delle formulazioni dottrinali, e che conferisce un senso e un valore al tutto.
In questo senso la preghiera costituisce l’attività più vera e incisiva dell’uomo. "Sentitevi, al mattino e alla sera, nell’ora da voi scelta, come creature che salgono verso lo Spirito con atto di perfetto culto. Fate tacere tutte le voci che vengono dalla terra e dal sangue; e compiendo l’atto di totale offerta di voi allo Spirito vi sentirete invasi lentamente da una forza nuova che darà calore e alimento a tutta la vostra vitalità, anche a quella fisica. Insistendo in questo esercizio, lentamente ma infallibilmente, raggiungerete la pacificazione di voi stessi. Rientrando nell’esistenza, guarderete le creature con i sensi purificati, avrete nuove capacità mentali, il vostro giudizio sulle realtà terrene sarà più esatto e più preciso, perché le osserverete dal punto di vista dell’eternità. Sentirete, ad esempio, come la vostra parte irascibile viene gradatamente riordinata, troverete l’elemento positivo di tutte le vostre passioni, e soprattutto incomincerete ad apprendere cosa significa amare”
(Fraternità di Romena, Perché pregare?, Anno XIV n°3/2010)

IL RISORTO
di Giovanni Vannucci o.s.m.
Estratto da: “LIBERTA’ DELLO SPIRITO”, Centro di Studi Ecumenici Giovanni XXIII, 1967
Completezza del culto e, direi, base fondamentale di tutta la vita ecclesiale è la resurrezione. Adesso, perché ho sentito la resurrezione proprio nella stesura indistruttibile del culto, come base e come sintesi, ho compreso che le cose hanno altra dimensione, altra misura, altra proporzione.
E' in base alla resurrezione che viene fondata la nuova vita dell’umanità. Per questo San Paolo dice: "Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, stolta la nostra predicazione" . La resurrezione è certezza : in quanto tu credi, senti la presenza di colui che è la vita imperitura. Dux vitae mortuus regnat vivus - il re della vita che è stato ucciso è ritornato a regnare vivente.
E' perché Cristo è risorto che si giustifica l’esistenza della Chiesa, della sua predicazione e quindi la richiesta del sacrificio e quindi la comunicazione della fede. Altrimenti,- fede in chi, in che cosa, e perché ? Quindi senza la resurrezione il cristianesimo sarebbe la religione più squallida. Il senso della resurrezione deve guidarci tutti i giorni, ogni volta che andiamo in chiesa dobbiamo sentire di andare a dialogare col Risorto, con colui che morto una volta, regna vivo.
Oltre questo, ogni volta che io compio un atto umano di relazione coi fratelli, di servizio comunitario, di donazione, di fatica, ogni volta devo sentire il Risorto, per non cader in un atto fatalistico, in un atto disperato. Ecco perché la Pasqua è il centro di tutta quanta la liturgia cristiana. Noi siamo qui perché il Cristo raffigurato in croce comunica a noi la sua resurrezione, altrimenti ne nascerebbe una religione dell’autodistruzione , una religione del pessimismo.
.
La duplicità dell’esistenza
Ma direi anche nel senso sociale e non solo nel senso culturale. Sopporto la vita perché c’è una resurrezione, rinuncio perché c’è una resurrezione. Ecco perché i santi riescono ad essere beati anche nel pianto: perché partecipano già alla gioia del Risorto anche se nel contempo sono dei sofferenti. La nostra esistenza è una composizione, una sintesi di dolore e di gioia. Di dolore in quanto partecipa al temporaneo, al caduco, al transitorio e quindi ogni passaggio da una fase all'altra è sempre un fatto di dolore: nascere soffrire morire, lavorare, faticare e intendere è sempre una fatica, un dolore, una sofferenza, ora di carattere fisico, ora di carattere etico morale, ora di carattere spirituale: tale è l'esistenza. Ma nel contempo l’esistenza è ancorata a questo atto di fede nel Risorto; ed avendo la comunione col Risorto, la realtà che può essere tante volte anche tragica, si trasforma in uno stato di beatitudine, per cui è già beato colui che piange; è gaudente colui che soffre; è sorridente colui che è perseguitato. In ciò sta il senso della duplicità dell’esistenza.
Il vero culto cristiano sintetizza questo dualismo in un atto unico; la formula antica dice: "Predicate la mia morte, annunziate la mia resurrezione, attendete il mio ritorno”. Ma è un dato unico, non è che siano tre verità. Cosicché, staccare la morte dal momento della resurrezione è avere il senso tragico della morte, il senso che tutte le cose finiscono con la morte, il senso del distacco doloroso. Ecco allora il ”disperatamente posano”, "sconsolati piangono”. Nessuno crede a quegli sconsolati, perché quella è una verità solo parziale, che poi fonda la retorica del dolore, la retorica della scompostezza. I cristiani invece, che in antico non staccavano mai il senso della resurrezione dal senso della morte, non facevano che cantare: ”Oggi è stata uccisa la morte, non uccisa la vita”. Mors mortua tunc est . Allora appunto morì effettivamente la morte, perché il Cristo risorse. Il duce della vita, morto, regna vivo. Morto vivo: abbiamo due aggettivi che compongono la sintesi dell’unica verità che è il Cristo stesso.
.
Fondamento sacramentale e umano
Questo è il valore, il senso della resurrezione. E’ soltanto in quanto tu credi che il Cristo è risorto, che puoi andare alla comunione; non puoi andare a mangiare un cadavere, vai a ricevere la vita. E’ in quanto tu credi che Cristo è risorto, che nel nome suo tu puoi battezzare un morto alla vita, perché viva in Dio. Tutti i sacramenti traggono la loro vitalità dal fatto che Cristo è risorto. Ma la validità stessa della parola, la validità dei nostri comunicati, cioè del nostro costume, della nostra vita, è valida se ha in se stessa la partecipazione col Cristo risorto. Soltanto attraverso il prisma della resurrezione tu puoi giudicare bene le cose. Allora la tua predicazione non è stolta. E' soltanto dentro a questa visuale che tu puoi sentire i rapporti umani, stabilire il senso dell’amicizia, stabilire la solidità di una famiglia, la gioiosità del vivere, o meno. E’ soltanto lì che prende senso la parola. Se no, sarebbe una stoltezza.
Vedete quindi questa incombenza. Questa gaudiosa incombenza del Risorto. Ora il fatto è reale. Abbiamo visto il Signore, dice il Vangelo. Ecco che è comparso, vi precede, si è presentato sulle sponde del mare, lo ha visto una moltitudine, si è accompagnato sulla strada di Emmaus.
Questo che è stato comunicato per provvidenza speciale e in maniera particolare ai discepoli, costituisce tuttavia, in maniera misteriosa, l’anima la ragion d’essere, la forza per cui la Chiesa non verrà mai meno: la presenza del Risorto. Da allora il Risorto può apparire in qualunque punto: sulla via di Emmaus, sulla via di Damasco, a san Francesco come a tutti i santi, cioè attraverso tutta la realtà della Chiesa.
.
Testimoni d’immortalità
Si sottrae alla vista fisica, quaranta giorni dopo, quando avrà trasmesso ai discepoli la realtà della sua resurrezione. Da allora i discepoli, la Chiesa, devono annunciare al mondo la certezza che Egli è risorto. Si è sottratto alla vista degli occhi fisici, perché il mondo veda attraverso noi che è risorto, e rimanga poi nell’attesa precisa del suo ritorno: la parusia.
E’ attraverso la Chiesa che deve essere comunicata la fede del Risorto al mondo: "Predicate la mia morte, annunziate la mia resurrezione, attendete il mio ritorno”. Sono tre momenti della stessa realtà, di un'unica verità; la quale, se voi la inserite dentro la vostra parabola che va dalla nascita alla morte, voi vedete subito che questa nascita e questa morte non è un caso e neanche una parabola finita in se stessa, ma continuerà. Cioè si nasce per vivere immortali, si nasce per comunicare una immortalità e una resurrezione; e cioè semplicemente per comunicare attraverso noi una vita eterna allo stesso cosmo. Quindi noi siamo qui per essere gli immortali nel tempo e nello spazio. Siamo qui a portare, attraverso il nostro viaggio che passerà per la morte, tutto il cosmo stesso nella pienezza della resurrezione. Difatti l’ultimo dogma del cristianesimo è proprio la resurrezione della carne. Non resurrezione dell'anima, perché l’anima non muore; non resurrezione degli spiriti, perché gli spiriti sono immortali, ma resurrezione della carne, cioè del corpo, del cosmo. Quindi siamo i testimoni della «comunicabilità della vita eterna di Dio nel cosmo.
Ma questo deve essere tradotto in una concezione di vita, in una pienezza, in un modo di vivere preciso, per cui gli altri, guardandoci, possano dire: - Perché sono così gaudiosi ? Come mai sono così calmi ? Perché son sempre equilibrati e mai disperati ? - Più che lo sforzo di portare in noi la morte di Cristo, dovrebbe esserci lo sforzo di portare la sua resurrezione, perché la morte è già in atto. Dal momento della nascita è - nel senso fisico - un cominciare a morire, se prendiamo il tempo come cifra definitiva e assoluta.
.
Risorgiamo nel tempo
La Resurrezione fonda il dogma della mia resurrezione. Perché se è risorto Lui, risorgeremo anche noi. Ecco il secondo momento della resurrezione: la resurrezione temporale rispetto a noi, cioè il tradurre in me nel tempo la resurrezione di Cristo: e comporta un modo diverso di giudicare rispetto alle cose, agli avvenimenti, a me stesso.
Se credo nella resurrezione di Cristo, di che ho paura? Se ci credo, che cosa mi può turbare? Se penso realmente alla resurrezione di Cristo, a cosa posso attaccarmi? Su che cosa devo piangere? E' sulla resurrezione che si fonda la gioia del sofferente, del martire, del santo. La morte stessa non fa paura, il dolore, la rinuncia, quella che si chiama solitudine, che poi vera solitudine non è.
Mentre è proprio perché non pensiamo alla resurrezione di Cristo che noi concepiamo la vita come fine a se stessa, quindi prigioniera. La fede nella resurrezione di Cristo fonda, anticipa nel tempo la mia resurrezione finale del corpo. Allora questa realtà verrà comunicata a tutta la terra e tutti sapranno quello che ha fatto il Signore e tutta la storia verrà consumata nel ciclo provvidenziale che Dio stesso ha iniziato con la creazione: il consummatum est di Cristo. Tutto è compiuto. Quando avverrà questo, ci sarà non già una distruzione, perché la Bibbia non predica mai la distruzione - la terra non sarà distrutta - ma cieli nuovi e terre nuove.
Quindi il nostro cammino non è affatto un cammino verso la morte, non è affatto un cammino verso il nulla: è un cammino verso il tutto. E' un andare verso la vita. La morte è un fatto di per sé gioioso, anche se la natura sente un distacco. . .
.
L'abito pasquale
Tre cose derivano dal senso della resurrezione. Che noi già fin da ora siamo in comunicazione col Risorto e quindi abbiamo in noi la radice non per evitare, ma per risolvere, ricomporre, ricondurre ad un senso di gioia tutti i nostri dolori, tutte le nostre ansie. Poi abbiamo il senso gioioso della vita, anche se continueremo a piangere, a sentire il dramma dell’esistenza. Infine la fede nella realtà della resurrezione e perciò la familiarità con la morte.
In ogni giorno della vita dovremmo avere questo abito pasquale, e allora potremo incontrare il Cristo risorto nella realtà dei fratelli, perché è attraverso la Chiesa che deve essere comunicata la resurrezione di Cristo. E' per questo che egli si sottrae, e dopo aver comunicato se stesso risorto, ha detto: "Ora andate e insegnate". Ci verrà detto all'ascensione: "Che state guardando in cielo? Tornate fra di voi, comunicate la realtà e la pienezza del Risorto". Ecco perché il cristianesimo è la religione della gioia, anche se è la religione del crocifisso. Perché il crocifisso è risorto!

Padre Giovanni Vannucci
«Vi siete ricordati di aprire il pollaio?». Sono queste le ultime parole di padre Giovanni Vannucci, la mattina del 18 giugno 1984, mentre lo stanno caricando sull’ambulanza a seguito del devastante infarto che lo porterà alla morte. Sembra la frase di una mente confusa, invece sono le parole che forse più di altre rappresentano la vita, il pensiero e la fede di quest’uomo coltissimo (docente di ebraico e Sacra scrittura, lettore assiduo e onnivoro: la sua biblioteca conteneva più di 12 mila volumi) approdato con il tempo alla semplicità dei santi.
Con le sue scelte spesso controcorrente e che gli attirarono severi giudizi da parte dell’allora Chiesa istituzionale, precorse di quasi un ventennio lo spirito del Concilio. Uomo della Parola e del silenzio, animo mistico eppure immerso nella vita quotidiana, sacerdote aperto all’incontro con ogni uomo e donna di qualsiasi estrazione, provenienza o credo religioso, a padre Giovanni per anni non fu perdonata la grande libertà di pensiero e di azione che gli aveva donato il Vangelo.
Nato a Pistoia il 26 dicembre 1913, secondogenito di una famiglia numerosa, Vannucci decide di entrare, nel 1926, nel convento fiorentino dei Sette Santi Fondatori (Servi di Maria). Dopo gli studi e la professione solenne – il 13 ottobre 1936 –, si dedica all’insegnamento dell’esegesi biblica e della lingua ebraica per dieci anni. Nello stesso periodo frequenta il Pontificio Istituto Biblico e l’Ateneo pontificio «Angelicum».
I lunghi studi non lo allontanano però dalla vita concreta. Anzi, in là con gli anni amerà dire ai novizi: «Voi potete conoscere a memoria tutti i manuali di pedagogia, di filosofia e di morale, e magari poi non riuscite a trattare concretamente con gli uomini che vengono a chiedervi un aiuto, un consiglio. Potete avere un bagaglio di nozioni teoriche immense, ma che diventano assolutamente inutili se in voi manca l’attenzione, l’apertura totale alla vita, al mistero dell’esistenza». Per lui, infatti, conoscenza e cultura hanno un unico scopo: aprirsi all’amore. «Bisogna conoscere per amare di più», suole ripetere. Negli studi e nell’insegnamento manterrà sempre «l’animo del cercatore di Dio – scrive Massimo Orlandi nel bel volume Giovanni Vannucci custode della luce, edizioni di Romena –, poco interessato alle speculazioni e alle teologie cerebrali e invece immerso nella Parola, per svelarne il senso simbolico e liberarne la luce». Uno stile che preoccupa non poco i suoi superiori che gli negheranno più volte il permesso di avviare forme comunitarie innovative e originali.
Nella ricerca di risposte per il suo animo inquieto, bisognoso di «verità e vita», padre Giovanni approda a Campello, nelle colline umbre. Si tratta di un eremo fondato vent’anni prima da sorella Maria, che vi abita insieme ad altre donne. «Maria – scrive ancora Massimo Orlandi – ha scelto la via dell’eremo non per creare un nuovo Ordine ma, al contrario, per liberare la sua esperienza di religiosa dai limiti imposti da strutture e barriere confessionali».
La libertà che respira in questi luoghi sarà decisiva per Vannucci che qui si sente «nascere una seconda volta». «L’eremo – confiderà riferendosi a Campello – è stato uno dei doni più grandi che il Signore mi ha concesso, la terra dove il sogno e la missione del monachesimo trovano un compimento che aiuta a sperare e a vivere». Qui padre Giovanni sperimenta l’ecumenismo «della base», quello semplice, concreto, che lo porterà a dire, avanti con gli anni: «Le religioni sono come i raggi di una ruota: tutti portano verso il centro». A Campello abita, infatti, anche una sorella anglicana e si mantengono contatti con fratelli protestanti e di altre confessioni. Siamo nel 1948, e l’apertura di Maria non può ancora essere compresa: vive pertanto una condizione di emarginazione all’interno della Chiesa, che però non la spegne. Da quelle colline lei tiene rapporti con personaggi del calibro di Gandhi e Albert Schweitzer: «L’eremo ci tiene in comunione con i santi, con i grandi, con i poveri e i derelitti, con le stelle, con i fiori, con l’universo. È come una scala dalla terra verso il cielo» scrive. Lo stile appreso a Campello segnerà padre Giovanni per la vita.
Nel frattempo la situazione di Vannucci a Roma si fa sempre più delicata. «Il suo spirito libero e innovatore, l’attenzione profonda ai miti di tutte le religioni – ricorda ancora Orlandi – lo pongono, per le autorità ecclesiastiche, nella zona d’ombra che si avvicina all’eresia».
In questo periodo padre Giovanni scriverà: «Soffriamo perché vediamo che tutta la nostra attività non incide nella storia degli uomini. C’è troppa separazione tra monaci e popolo». Mosso da questa convinzione, decide di abbracciare l’esperienza della neonata comunità di Nomadelfia. Fondata da don Zeno Saltini, quest’ultima è socialmente strutturata per poter vivere concretamente il Vangelo: non esiste proprietà privata né denaro e vi è un’apertura totale delle famiglie all’accoglienza di figli in affido. Nel 1950, con altri sei confratelli, Vannucci decide così di trasferirsi in Maremma, dove la comunità ha aperto una sede. «Non è una defezione – appunterà in quel periodo – ma è il portare alle sue estreme conseguenze la nostra vocazione iniziale. Nomadelfia costituisce un esempio vivente di un perfetto accordo della vita umana col Vangelo e del cristiano con la storia del tempo nel quale vive».
Anche questa esperienza, però, è destinata in breve a concludersi. Nell’estate del 1951 il Sant’Uffizio obbliga i religiosi a rientrare «sotto l’obbedienza dei superiori». Una ferita profonda, ma che non domerà lo spirito di Vannucci.
Rielaborato il dolore, dopo qualche anno è di nuovo in campo. Chiede infatti ai superiori di poter avviare una nuova forma di vita comunitaria: una fraternità dedita alla preghiera e al lavoro, ma aperta all’accoglienza. La scelta ricade sull’eremo di San Pietro alle Stinche, nel Chianti, dove padre Giovanni può ritirarsi, complice anche l’ormai mutato clima ecclesiale post-conciliare (siamo nel 1967).
Padre Giovanni trascorrerà alle Stinche il resto della vita. Si rifiuterà sempre di scrivere una regola per la sua comunità: quello che propone è uno stile di vita. L’eremo, nel suo progetto, non è una via di fuga, ma un luogo in cui posare il capo, scaricare i pesi troppo gravosi, riempirsi gli occhi, la mente e il cuore di bellezza, e ripartire. Chi arriva non deve giustificare la sua presenza, ma solo condividere la semplicità della vita dei fratelli. È la libertà dei figli di Dio.
Card Martini..Profeta del novecento

All'alba ti cercherò
Signore, provoca anche noi!
Passa in mezzo a noi, dovunque siamo,
sia che ci troviamo tra la folla,
sia che ci troviamo nel luogo della preghiera,
sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana!
Fa' che non ci sia differenza tra l'una e l'altra,
che non abbiamo a rinnegare nella vita quotidiana
colui che sul monte vogliamo conoscere.
Fa' che ci sia unità tra i diversi momenti della nostra esistenza!
Signore, attraverso la contemplazione di te che risvegliandoti dal sonno e risorto dalla morte mi dai fiducia,
sciogli, ti prego, i miei timori, le mie paure, le mie indecisioni,
i miei blocchi nelle scelte importanti, nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri,
negli atti di coraggio per manifestare la mia fede.
Sciogli i miei blocchi, Signore!
Card Martini

Signore, Tu sei la mia lampada,
Ti prego, Signore
di rischiarare la mia lampada che è la
preghiera:
preghiera che fa fatica ad accendersi,
che non è splendente come vorrei.
Ti chiedo Signore di rischiararla
e però vorrei con più audacia,
fare mie le parole di Davide: tu sei la mia lampada.
Non voglio quindi preoccuparmi troppo
della mia preghiera nella certezza che tu sei
la mia lampada, il sole dalla mia vita.
Donaci, o Signore Dio nostro, di capire il mistero della preghiera.
Donami di coltivare la terra con umiltà e
semplicità di cuore, a imitazione della Vergine Maria.

Donaci, Signore,
una vera, nuova e più approfondita
conoscenza di te.
Anche attraverso le parole
che non comprendiamo,
fa' che possiamo intuire con l'affetto del cuore
il mistero tuo che è al di là di ogni comprendere.
Fa' che l'esercizio di pazienza della mente,
il percorso spinoso dell'intelligenza
sia il segno di una verità
che non è raggiunta semplicemente
coi canoni della ragione umana,
ma è al di là di tutto
e, proprio per questo, è la luce senza confini,
mistero inaccessibile e insieme nutritivo
per l'esistenza dell'uomo,
per i suoi drammi e le sue apparenti assurdità.
Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi,
di conoscere le sofferenze dell'umanità,
di conoscere le difficoltà
nelle quali si dibattono molti cuori
e di ritornare a una sempre nuova
e più vera esperienza di te. Amen.

Carlo Maria Martini: Chiesa e postmodernità
Francesco Cosentino
Lo scorso 31 agosto è stato celebrato l’ anniversario della morte del cardinale Carlo Maria Martini. Una memoria che non si spegne, ma continua ad ardere nel cuore della Chiesa proprio come il fuoco di quella Parola di Dio di cui egli fu instancabile studioso, maestro e annunciatore. Sarebbe naturalmente impossibile racchiudere in poche parole la ricchezza di un profilo e di una spiritualità, che hanno fortemente segnato la Chiesa e il cattolicesimo italiani.
Affascinato dalla Parola di Dio, vero faro della sua esistenza sacerdotale ed episcopale, egli fu una figura sobria e austera, un comunicatore semplice ma mai banale, e soprattutto un uomo capace di leggere e interpretare la vita, i problemi e gli aspetti della società con un discernimento intelligente, aperto, sereno e lungimirante. Per lui, la fede era il grande rischio della vita e non una passiva consolazione, e ciò lo rese affascinante ed empatico anche agli occhi di molti non credenti, toccati dal suo stile e dalla sua visione.
Vorrei soffermarmi, però, su un tema che mi sembra particolarmente attuale, trattato dal cardinale Martini in un articolo pubblicato da Avvenire il 27 luglio 2008 dal titolo “Quale cristianesimo nel mondo postmoderno”.
Martini cerca di spostare il baricentro del giudizio dominante dell’ambito ecclesiale e teologico che, purtroppo, ancora oggi, appare piuttosto risentito nei confronti del mondo moderno, facendo emergere tutta la nostra difficoltà a far pace con la perdita di spazio e di rilevanza della fede.
Emergono talvolta da più parti, infatti, alcuni rigurgiti polemici, rigidi moralismi, valutazioni negative, atteggiamenti rancorosi e lamentosi e un’apologetica che il grande teologo francese de Lubac definirebbe aggressiva e difensiva.
Secondo Martini, invece, ci troviamo in un momento di crisi della fede e in mondo pieno di problemi e di sfide, ma, tuttavia, «non vi è mai stato nella storia della Chiesa un periodo così felice come il nostro». Infatti, continua il cardinale, «la nostra Chiesa conosce la sua più grande diffusione geografica e culturale e si trova sostanzialmente unita nella fede, con l’eccezione dei tradizionalisti di Lefebvre».
Non solo: «Nella storia della teologia non vi è mai stato un periodo più ricco di quest’ultimo. Persino nel IV secolo, il periodo dei grandi Padri della Cappadocia della Chiesa orientale e dei grandi Padri della Chiesa occidentale, come san Girolamo, sant’Ambrogio e sant’Agostino, non vi era un’altrettanto grande fioritura teologica. È sufficiente ricordare i nomi di Henri de Lubac e Jean Daniélou, di Yves Congar, Hugo e Karl Rahner, di Hans Urs von Balthasar e del suo maestro Erich Przywara, di Oscar Cullmann, Martin Dibelius, Rudolf Bultmann, Karl Barth e dei grandi teologi americani come Reinhold Niebuhr, per non parlare dei teologi della liberazione (qualunque sia il giudizio che possiamo dare di loro)».
Partendo da questa visione positiva, ci si può inoltrare nel complesso tempo postmoderno senza indulgere alla rassegnazione lamentosa o al risentimento.
Al cardinale non sfugge la problematicità della visione postmoderna della vita e della società, che si configura come una mentalità di opposizione nei confronti del modo in cui abbiamo concepito il mondo fino ad ora e che promuove un’istintiva preferenza per i sentimenti, per le emozioni e per l’attimo presente, invece che per i grandi progetti e ideali.
Naturalmente, in questo clima si fanno strada il rifiuto o un certo giudizio negativo nei confronti della morale, un sentimento anti-istituzionale che penalizza anche la Chiesa, nonché ciò che Martini chiama «il rifiuto del senso del peccato e della redenzione».
Questi aspetti potrebbero facilmente gettare lo spirito del cristiano nello scoraggiamento oppure orientarlo verso un atteggiamento ostile e controversista. Al contrario, nello spirito ignaziano che gli era proprio, il cardinale Martini afferma che occorre un vero discernimento spirituale, capace di osservare la realtà con gli occhi di Dio e di cogliere perciò il grano buono nel mezzo della zizzania.
A ben guardare – afferma sorprendentemente – «forse questa situazione è migliore di quella che esisteva prima. Perché il cristianesimo ha la possibilità di mostrare meglio il suo carattere di sfida, di oggettività, di realismo, di esercizio della vera libertà, di religione legata alla vita del corpo e non solo della mente. In un mondo come quello in cui viviamo oggi, il mistero di un Dio non disponibile e sempre sorprendente acquista maggiore bellezza; la fede compresa come un rischio diventa più attraente. Il cristianesimo appare più bello, più vicino alla gente, più vero».
La lettura è degna di attenta riflessione. La crisi di un certo cristianesimo sociologico, la perdita di rilevanza pubblica della Chiesa e la riduzione del suo potere sociale, così come la mentalità “liquida” che presiede le visioni e l’agire dei nostri contemporanei non rappresentano un “luogo” totalmente negativo per la fede cristiana; al contrario, la crisi diventa e può essere un’occasione per riscoprire un cristianesimo nuovo, che non si instaura più per un influsso sociale o per tradizione culturale, ma si situa nel cuore della gente grazie alla freschezza e alla novità del Vangelo, e diventa attrattiva per il fatto di mostrarsi come una sfida, un rischio, una possibilità di realizzare una vita umana qualitativamente differente.
Insomma, la crisi di un cristianesimo tradizionale e sociologico potrebbe indurre alla riscoperta di una fede viva, fondata sulla Parola, radicata nell’esperienza spirituale e, certamente, più consapevole, più responsabile e più adulta.
Non è superfluo ricordare che Benedetto XVI ebbe a fare la stessa analisi parlando ai cattolici di Germania nel 2011, ricordando loro che «in un certo senso, la storia viene in aiuto alla Chiesa attraverso le diverse epoche di secolarizzazione, che hanno contribuito in modo essenziale alla sua purificazione e riforma interiore… Liberata dai fardelli e dai privilegi materiali e politici, la Chiesa può dedicarsi meglio e in modo veramente cristiano al mondo intero, può essere veramente aperta al mondo». Anni addietro, l’allora professor Ratzinger aveva già parlato di una “Chiesa minoranza”.
In tale direzione, Martini esorta il lettore citando san Paolo: «Esamina tutto con discernimento; conserva ciò che è vero; astieniti dal male» (1Ts 5,21-22). In questo esercizio, il cardinale afferma che, nel tempo postmoderno, la fede è una vera e propria sfida, per affrontare la quale servono quattro attitudini, che vale la pena non solo di enumerare, ma anche di meditare citando le sue stesse parole:
«Non essere sorpreso dalla diversità. Non avere paura di ciò che è diverso o nuovo, ma consideralo come un dono di Dio. Prova ad essere capace di ascoltare cose molto diverse da quelle che normalmente pensi, ma senza giudicare immediatamente chi parla. Cerca di capire che cosa ti viene detto e gli argomenti fondamentali presentati. I giovani sono molto sensibili a un atteggiamento di ascolto senza giudizi. Questa attitudine dà loro il coraggio di parlare»;
«Corri dei rischi. La fede è il grande rischio della vita. “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 16,25)»;
«Sii amico dei poveri. Metti i poveri al centro della tua vita, perché essi sono gli amici di Gesù che ha fatto di se stesso uno di loro»;
«Alimentati con il Vangelo. Come Gesù ci dice nel suo discorso sul pane della vita: “Perché il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo” (GV 6,33)».
Si tratta di un vero e proprio programma spirituale e pastorale, che non si preoccupa degli spazi da occupare e dei trionfi sociali da raggiungere, ma di sviluppare una spiritualità capace di generare luce nel mondo e di aprire strade al Vangelo; per dar vita a queste quattro attitudini, infatti, Martini propone quattro esercizi: la lectio divina perché è la Parola di Dio che nutre la vita e apre all’incontro con Dio; l’autocontrollo, perché saziare tutti i desideri senza discernimento può portare alla noia e alla sazietà; il silenzio, perché «dobbiamo allontanarci dall’insana schiavitù del rumore e delle chiacchiere senza fine, e trovare ogni giorno almeno mezz’ora di silenzio e mezza giornata ogni settimana per pensare a noi stessi, per riflettere e pregare»; infine, l’umiltà, cioè «non credere che spetti a noi risolvere i grandi problemi dei nostri tempi. Lascia spazio allo Spirito Santo che lavora meglio di noi e più profondamente. Non cercare di soffocare lo Spirito negli altri, è lo Spirito che soffia. Piuttosto, sii pronto a cogliere le sue manifestazioni più sottili».
Anche in un tempo difficile, indifferente e per certi versi ostile alla fede e alla Chiesa, Dio continua a bussare. Tante persone, anche inconsapevolmente, sono inquietate da domande diverse e dal desiderio di vincere il grigiore della routine e la staticità delle abitudini. Il Vangelo continua in qualche modo a suscitare stupore e la figura di Gesù crea ancora scompiglio. Ciò che manca, forse, è un cristianesimo, una Chiesa e dei cristiani capaci di quello sguardo e di quelle attitudini, che il cardinal Martini ha voluto ricordarci.
Non è un caso se questo invito, oggi, in una nuova stagione ecclesiale ricca di sorprese, ci viene proposto da papa Francesco. Proprio il pontefice ha affermato: «la nostra missione di battezzati, di sacerdoti, di consacrati, non è determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano, ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare cambiamento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù, in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le sofferenze e le speranze… Penso che la preoccupazione sorge quando noi cristiani siamo assillati dal pensiero di poter essere significativi solo se siamo la massa e se occupiamo tutti gli spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la capacità che abbiamo di “lievitare” lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare apparentemente benefici tangibili o immediati. Perché essere cristiano non è aderire a una dottrina, né a un tempio, né a un gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con Gesù Cristo».
Su questa strada, tracciata profeticamente da Carlo Maria Martini, siamo ancora in cammino.

Card. Martini: il silenzio che apre all’ascolto e sfocia nel dialogo
Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, segnala i punti di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di Ambrogio dal 1979 al 2002
“La passione per l’evangelo, la parresia, l’invito a uno stile di Chiesa sinodale, la lotta per la giustizia e il perdono, l’attenzione ai poveri”: sono questi i tratti che avvicinano - oltre ovviamente alla scuola ignaziana - due gesuiti come Jorge Mario Bergoglio e Carlo Maria Martini. Così come non mancano le differenze: nel “temperamento”, nella formazione e nel “curriculum ecclesiastico”. È Marco Vergottini, teologo, a lungo collaboratore dell’allora arcivescovo di Milano, a segnalare i punti di contatto nella figura e nel pensiero dell’attuale pontefice e del biblista che fu sulla cattedra di Ambrogio dal 1979 al 2002. Di Martini si ricorda il terzo anniversario della scomparsa, avvenuta il 31 agosto 2012: in tale occasione ha visto la luce il volume “Martini e noi”, curato da Vergottini, con 111 testimonianze di “cardinali, vescovi, intellettuali, teologi, giornalisti e soprattutto uomini e donne che sono stati segnati dal rapporto con le sue parole, con i suoi scritti, con la sua persona”.
In dialogo con il suo tempo. Al termine del lungo lavoro attorno al volume, Vergottini riconosce che alcuni tra coloro che raccontano della personale conoscenza col card. Martini, “hanno scoperto o impresso una nuova direzione alla propria vita proprio nell’incontro con lui, nell’ascolto del suo magistero episcopale a Milano durato 22 anni, continuato dalle cattedre di Gerusalemme e Gallarate”. Gli scritti presentati in “Martini e noi” e raggruppati per capitoli, delineano del resto una sorta di indice della biografia martiniana: il credente e la vita spirituale; il biblista e Gerusalemme; il vescovo e la sua Chiesa; l’uomo del dialogo ecumenico e interreligioso; il pastore e le forme della comunicazione; l’intellettuale e la polis. Vergottini, che ha alle spalle diversi studi sul porporato, puntualizza: “Se Martini ha potuto sorprendere la Chiesa di Milano per l’insistenza con cui ha richiamato il primato della dimensione contemplativa, pure egli ha ricercato con intensità, curiosità e audacia - da taluni ritenuta quasi spericolata - di entrare in dialogo con le donne e gli uomini di oggi per incalzarli a riflettere sul senso dell’esistenza e sollecitarli all’incontro con il Padre di tutti, riscuotendo interesse e attenzione nel mondo laico, come nessun’altra personalità del mondo cattolico”.
Silenzio che genera ascolto. Tra le firme del volume, edito da Piemme, figurano il cardinale Ravasi, il priore di Bose Enzo Bianchi, il patriarca ecumenico Bartolomeo I. E poi Cacciari, Cazzullo, De Bortoli, Giorello, Lerner, Mancuso… Tanti gli amici del lungo periodo milanese di Martini. Tra questi proprio Ravasi, nominato da Martini nel 1989 prefetto della prestigiosa Biblioteca Ambrosiana. Nel suo scritto, Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, sottolinea soprattutto un aspetto del cardinale di origine piemontese: “Il silenzio autentico genera l’ascolto che, a sua volta, crea il dialogo. È stato un po’ questo il programma personale ed ecclesiale di Martini che ha sempre alonato le sue parole di silenzio contemplativo, rendendole così incisive ed efficaci e perciò feconde per l’incontro con l’Altro divino e l’altro umano”. Ma “il suo non era solo un silenzio ‘ascetico’, capace cioè di purificare la parola dalla verbosità, dall’enfasi e dalla prevaricazione; era anche un silenzio ‘mistico’ e appassionato perché edificava la comunione attraverso l’ascolto attento della parola dell’altro. Non per nulla i primi interventi ecclesiali pubblici del cardinale erano stati un appello alla vita contemplativa e all’ascolto della Parola sacra”. Il card. Ravasi aggiunge: “Martini nel suo lungo ministero pastorale ha saputo costantemente scendere dal monte del silenzio contemplativo per incrociare le persone in un silenzio di ascolto fraterno che sbocciava nell’incontro, nel confronto, nel dialogo ove identità e differenza si componevano in armonia”.
“Ecclesiastico senza tattiche”. Sull’ascolto torna il biblista Enzo Bianchi, secondo il quale l’aspetto “più impressionante del suo essere uomo, cristiano, vescovo della Parola, emergeva dalla sua grande capacità di ascolto: dialogare con lui era sperimentare di persona cosa sia un orecchio attento e un cuore accogliente, cosa significhi pensare e pregare prima di formulare una risposta… Era da questo ascolto attento, della Parola e dell’interlocutore, che ho visto nascere nel cardinale Martini la capacità di gesti profetici, la sollecitudine per la Chiesa e per la sua unità, la vicinanza ai poveri, il farsi prossimo ai lontani, il dialogo con i non credenti. In lui coglievo una delle rare figure di ecclesiastici senza tattiche, né strategie, né calcoli di governo, ma quella vita di Cristo e in Cristo che aveva posto come chiave di lettura dell’esistenza di ogni battezzato e del suo ministero pastorale”.
Primo Mazzolari...il mondo si muove se noi ci muoviamo

Vivere è camminare, salvarsi è camminare… Il cristiano è un pellegrino.
Se uno rifiuta la solidarietà del camminare, cioè lo sforzo di vivere con gli uomini e per gli uomini, tradisce la propria vocazione d’uomo…
Il cristiano che si ferma e si chiude invece di camminare rischia smarrire la coscienza della cattolicità.
Le strade cristiane nel mondo si tracciano camminando con integrità di fede, con passione d’apostolato, con audacia di carità
"Il mondo si muove se noi ci muoviamo, muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera incomincia con il primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima goccia d'acqua l'amore col primo pegno.
Ci impegniamo perché noi crediamo nell'amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta a impegnarci perpetuamente."
Don Primo Mazzolari

Ci impegnamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegnamo
senza pretendere che altri s'impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.
Ci impegnamo
senza giudicare chi non s'impegna,
senza accusare chi non s'impegna,
senza condannare chi non s'impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s'impegna.
Ci impegnamo
perché non potremmo non impegnarci.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia,
più forte di noi stessi.
Ci impegnamo per trovare un senso alla vita,
a questa vita, alla nostra vita,
una ragione che non sia una delle tante ragioni
che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore.
Si vive una volta sola
e non vogliamo essere "giocati"
in nome di nessun piccolo interesse.
Non ci interessa la carriera,
non ci interessa il denaro,
non ci interessa la donna o l'uomo
se presentati come sesso soltanto,
non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee,
non ci interessa passare alla storia.
Ci interessa perderci
per qualche cosa o per qualcuno
che rimarrà anche dopo che noi saremo passati
e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
Ci impegnamo
a portare un destino eterno nel tempo,
a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare,
verso l'amore.
Ci impegnamo
non per riordinare il mondo,
non per rifarlo su misura, ma per amarlo;
per amare
anche quello che non possiamo accettare,
anche quello che non è amabile,
anche quello che pare rifiutarsi all'amore,
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore
c'è insieme a una grande sete d'amore,
il volto e il cuore dell'amore.
Ci impegnamo
perché noi crediamo all'amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci perpetuamente.

Chiamati alla Speranza
Primo Mazzolari
Quanta disperazione nei cuori
per le difficoltà della vita,
per l'incomprensione degli altri,
per quello che vediamo attorno a noi,
per le ingiustizie che si compiono
e di cui tante volte siamo vittime!
Sperare in Dio
non è come sperare negli uomini,
che non possono neppure sorreggere
il nostro desiderio
e la nostra piccola fiducia.
Sperare vuol dire resistere
a quello che ogni giorno vediamo
di brutto nella vita.
Che cosa vuol dire questo,
se non ci fosse dietro Qualcuno
che prende il posto della nostra tristezza?
Sperare vuol dire guardare al di là
di questa breve giornata terrena;
vuol dire pensare
ad una giornata che viene,
perché Dio si è impegnato
a far camminare il mondo nella giustizia,
perché il male non può trionfare,
perché Cristo
ha preso l'impegno del bene;
e voi sapete che Cristo
lo ha difeso in questi secoli
nonostante tutte le nostre bestemmie

Si cerca per la Chiesa
un prete capace di rinascere
nello Spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza paura del domani
senza paura dell’oggi
senza complessi del passato.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non abbia paura di cambiare
che non cambi per cambiare
che non parli per parlare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri
di lavorare insieme
di piangere insieme
di ridere insieme
di amare insieme
di sognare insieme.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di perdere senza sentirsi distrutto
di mettere in dubbio senza perdere la fede
di portare la pace dove c’è inquietudine
e inquietudine dove c’è pace.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che sappia usare le mani per benedire
e indicare la strada da seguire.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza molti mezzi,
ma con molto da fare,
un uomo che nelle crisi
non cerchi altro lavoro,
ma come meglio lavorare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che trovi la sua libertà
nel vivere e nel servire
e non nel fare quello che vuole.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che abbia nostalgia di Dio,
che abbia nostalgia della Chiesa,
nostalgia della gente,
nostalgia della povertà di Gesù,
nostalgia dell’obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non confonda la preghiera
con le parole dette d’abitudine,
la spiritualità col sentimentalismo,
la chiamata con l’interesse,
il servizio con la sistemazione.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di morire per lei,
ma ancora più capace di vivere per la Chiesa;
un uomo capace di diventare ministro di Cristo,
profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita.
Si cerca per la Chiesa un uomo.
(don Primo Mazzolari)

Don Mazzolari: «Adesso è l’ora dei laici»
di Giorgio Campanini
Il prete di Bozzolo e la sua profezia ancora attuale
Riflettere sul laicato nella Chiesa di oggi alla luce dell’insegnamento di don Primo Mazzolari può apparire a prima vista il tentativo di operare un confronto inattuale, considerati i profondi mutamenti intervenuti nella storia della Chiesa nella seconda metà del Novecento, a partire da quell’evento conciliare che alla sua morte, nel 1959, cominciava soltanto a profilarsi all’orizzonte. Come tutta la vita della Chiesa, così l’insieme delle problematiche riguardanti il laicato appare, a partire dal Vaticano II, profondamente mutato. Ma se il Concilio è apparso, sotto molti aspetti, un avvenimento «rivoluzionario», tuttavia si trattava di una «rivoluzione» da lungo tempo preparata dagli spiriti più vigili della Chiesa dell’Ottocento e del Novecento (per l’Italia basti pensare soltanto a Rosmini e a Bonomelli, a Sturzo e allo stesso Mazzolari). Sotto questo aspetto, riandare alla riflessione mazzolariana sul laicato (e operare una rilettura di essa nei nuovi orizzonti post-conciliari) appare tutt’altro che inopportuno, sia per cogliere meglio il senso dell’evento conciliare, sia per affrontare i problemi che, anche dopo di esso, rimangono aperti.
In una lettera del 1933 all’allora presidente della Gioventù femminile di Azione cattolica della diocesi di Cremona (solo di recente pubblicata), così Mazzolari si esprimeva: «Ella mi scrive: so che non guarda con simpatia al nostro movimento femminile. Non è la più esatta traduzione del mio animo. Nutro invece una simpatia profondissima e di vecchia data verso l’Ac come idea . Il far posto ai laici nella Chiesa è sempre stata una mia missione, non una convinzione soltanto. Non simpatizzo con la maniera oggi in uso in Italia… Le esperienze e gli avvenimenti cambieranno tante cose. Quando? Non lo so perché non sono profeta: so però che dovrà essere, poiché un’Azione cattolica che clericalizza (la parola è brutta ma il significato che le do in questo momento è inoffensivo) i laici… li sposta dalla loro qualità specifica… per loro imprestare, estraniandoli quasi del tutto dal mondo in cui vivono, una nostra mentalità. Non è un gran guadagno». Questo problema – il rischio, cioè, della «clericalizzazione» del laicato cattolico – rappresenta il filo conduttore della prolungata riflessione di Mazzolari sul rapporto gerarchia-clero-fedeli, dagli scritti degli anni ’30 agli ultimi editoriali di Adesso . Emblematico (ma non unico documento di questa attenzione e di questa preoccupazione) un suo importante scritto del 1937, e cioè la Lettera sulla parrocchia . Questo testo rappresenta, a nostro avviso, quello in cui più schiettamente (anche perché in qualche modo coperto dall’anonimato) egli esprime il suo pensiero su questo tema. Al centro della riflessione mazzolariana sta la ferma convinzione che, in una stagione caratterizzata dalla fine del regime di cristianità, la missione della Chiesa non possa pienamente espletarsi confidando esclusivamente nel trinomio gerarchia-cleroreligiosi, ma si imponga «la partecipazione dei laici alla vita attiva dell’apostolato». Questa attiva presenza laicale nella missione evangelizzatrice della Chiesa è possibile, a giudizio di Mazzolari, a due fondamentali condizioni: in primo luogo la fuoriuscita dai ristretti recinti della vita parrocchiale e l’atteggiamento, da parte del laicato cattolico, di un atteggiamento di lucida e responsabile autonomia. Proprio aprendosi al mondo il laicato cattolico, abbandonando il sicuro rifugio della comunità cristiana, dovrebbe essere in grado di «fare il raccordo tra la parrocchia, che è lo spirito, e le attività della vita moderna»; né costituirebbe un dramma il fatto che questa «fuoriuscita» possa inizialmente provocare qualche tensione («Non importa se, uscendo» il laico «ha sbatacchiato l’uscio»). In secondo luogo l’abbandono, da parte della Chiesa, della pretesa di «controllare direttamente opere e istituzioni che sono di diritto nelle mani della comunità civile», garantendo così ai laici un adeguato spazio di libertà: «I figliuoli, divenuti maggiorenni – avverte – possono pretendere a una certa autonomia ed è dovere della religione d’educarveli invece di contrariarne l’aspirazione o impedirne o ritardarne la preparazione». Perché l’uno e l’altro obiettivo – il superamento della separatezza fra Chiesa e mondo e la promozione di un laicato responsabile – possano essere raggiunti occorre aprire porte e finestre della comunità cristiana: «Non si chiuda né si spranghi il mondo della parrocchia. Le grandi correnti del vivere moderno vi transitino, non dico senza controlli, ma senza pagare pedaggi umilianti e immeritati… L’Azione cattolica ha il compito preciso d’introdurre le voci del tempo nella compagine eterna della Chiesa» e di «gettare il ponte sul mondo, ponendo fine a quell’isolamento che toglie alla Chiesa di agire sugli uomini del nostro tempo». Proprio in vista di questa apertura al mondo, a giudizio di Mazzolari occorre «salvare la parrocchia» (ma qui, come in altri passi dello scritto, è facile intravedere dietro di essa tutta la Chiesa) «dalla cinta che i piccoli fedeli le alzano allegramente intorno e che molti parroci, scambiandola per un argine, accettano riconoscenti». In sintesi, è necessario andare al di là del ristretto numero dei praticanti abituali, formare cristiani aperti al mondo, evitare la «clericalizzazione del laicato», dare fiducia ai fedeli e nello stesso tempo diffidare di coloro che, «docili e maneggevoli», secondo la caustica denunzia mazzolariana, «dicono sempre di sì» e spesso sono apprezzati e valorizzati assai più di coloro che, dotati di maggiore spirito critico, mettono in discussione la prassi corrente, e dunque «creano problemi». Al fondamento di questa nuova stagione di irradiazione del messaggio evangelico nella storia sta, a giudizio di Mazzolari, una nuova e più autentica «spiritualità laicale», della quale (come egli stesso confessava in un articolo di Adesso «siamo tuttora sprovvisti». Vi era dunque un vuoto da colmare non solo sul piano della prassi, ma anche sotto il profilo dell’elaborazione di una nuova spiritualità del laico, costruita non soltanto sul suo «essere nella Chiesa» ma anche sul suo «essere nel mondo». È, questo, è un problema che – nonostante il Concilio Vaticano II – rimane ancora sostanzialmente aperto.

Crisi. Il cristiano deve viverla così di Primo Mazzolari
Come ritenere estraneo alla religione un fatto come la crisi, che interessa tutti, sconcerta tutti e fa soffrire tutti? Lo studieremo considerandolo sotto tre aspetti: i nostri torti come maestri cristiani di fronte alla crisi; gli effetti materiali della crisi e i nostri doveri come maestri cristiani di fronte alla crisi. Il primo torto è di occuparci della crisi soltanto personalmente. Quando siamo colpiti, mettiamo per esempio da una diminuzione di stipendio, allora, sì, esiste la crisi. Ma se non siamo colpiti personalmente, noi passiamo avanti a tutte le conseguenze della crisi. Con quella spaventosa indifferenza che l’egoismo sa trovare. Il secondo torto è di non occuparci della crisi religiosamente, ossia di non sentire le influenze disastrose che la crisi porta nel mondo religioso. È l’incapacità di vedere tutto in una visuale cristiana. Si è tentati di chiedere: «Ma la crisi non fa bene religiosamente? Se i cristiani parlano sempre di sofferenza, se la considerano come la strada regia per arrivare al cielo, questa crisi tremenda avvicinerà ancor di più a Dio».
Disgraziata opinione di molti cristiani, i quali credono che il soffrire chiami di più la Provvidenza. Ma datemi la vostra esperienza. Quando la nostra gente stava bene, stava più lontano dalla Chiesa? La gente non ama di più la Provvidenza nelle sofferenze: in queste, al contrario, si chiude di più il senso della Provvidenza. Infatti mai come ora si sono sentite tante bestemmie contro di essa. Occuparsi religiosamente della crisi vuol dire saper occuparsi e valutare tutte le influenze che nella pratica della religione può avere un disagio materiale. Terzo torto il non occuparci della crisi socialmente. Si parla tanto di senso sociale. C’è anche la parola di cattolicosociale. Che necessità c’è di aggiungere a «cattolico», «sociale»? Non si può vivere la vita cattolica intera se non in funzione sociale. Se non posso vivere neppure interiormente se non in funzione degli altri, anche il mio sforzo intimo ha una rispondenza nella società. E poiché la strada del Paradiso passa per le anime degli altri, dobbiamo occuparcene come maestre nella scuola dove siamo dinnanzi alle vittime più innocenti della crisi che in essi si manifesta negli aspetti più dolorosi. Altro torto avere giudizi semplicisti sulla crisi. Non vorrei arrivaste alla conclusione: «Il Signore ci ha messo al mondo per soffrire». È un’affermazione cristiana? No. Ci ha messo al mondo per godere e Gesù inizia il Discorso della Montagna con la parola: Beati. Dio ci ha messo nel cuore il bisogno insopprimibile di star bene, di felicità. S’intende solo il bisogno insopprimibile di star bene spirituale? No, anche il bisogno insopprimibile di star bene corporale e l’amore di Dio, concretizzato in tutti i suoi doni materiali, non è che un aiuto e un apporto al nostro benessere. La fecondità della terra, le forze mirabili della Natura, le meraviglie del mondo sono un aiuto dell’amore di Dio al nostro bene materiale. Ma il fattore del nostro benessere materiale non è proprio contrario al fattore del nostro benessere spirituale? Quando siete malati avete la stessa facilità di compire il bene di quando siete sani? Quando si è sani, si serve meglio il Signore, onde noi chiediamo anche la salute a Dio. Far soffrire virtuosamente quelli che soffrono è diverso che parlare di soffrire quando si sta bene: parlare di sofferenza quando non si soffre è facile. Nella vita il pane ha la sua importanza e dicendo il pane significo la soddisfazione di tutti i bisogni materiali della vita. Valorizzare il pane vuol dire l’importanza del Pater che ci fa invocare il pane e ci fa dovere di domandarlo al Padre per ogni giorno. Dimenticando l’importanza del pane arriviamo a non capire bene, a non trattare bene i fratelli, non ci regoliamo nel giudicarli quando li consideriamo nei bisogni materiali. Noi crediamo che le sofferenze intime sieno le più forti e difficili a superarsi, e quasi le desiderabili. Vi sono sì le sofferenze interiori cui ci si inchina, ma vi sono anche delle sofferenze materiali che io metterei al primo posto. Pensate a una mamma che all’ora dei pasti non ha cibo per i figli, o che ha un bimbo malato e non può curarlo; e presso alla mamma pensate il padre che ha l’incertezza del domani, che è senza lavoro né [ha] pane pei suoi; provate a mettere una creatura in queste realtà materiali e troverete che queste sono sofferenze materiali che precedono le spirituali. Io le metto prima perché i bisogni materiali hanno una voce precedente a quella dello spirito. Provate ad aver fame e poi ditemi se avete voglia di pregare. Abbiamo un senso umano nel giudicare le condizioni attuali altrimenti a forza di aver fame ci dimenticheremo di essere uomini. Parlando della crisi si parla anche di castigo di Dio. È un torto parlar troppo facilmente di essa come d’un castigo divino. Il castigo c’è, ma noi cristiani quando parliamo di castigo di Dio negli avvenimenti più importanti, nelle cose più gravi e più difficili a portarsi, dobbiamo andare molto cauti, molto adagio. Individualmente io ho il dovere di riconoscere la mia colpa, ma il ragionamento che faccio per me e che deve nascere dalla mia conoscenza, a chiarimento della mia responsabilità, io non lo devo fare per gli altri. Sono io l’interprete della volontà di Dio? Delle sue intenzioni? È vero, il Signore per chi ha fede si serve di tutto per richiamarci su strade che abbiamo dimenticate, ma io non devo giudicare gli altri perché creerei quello stato di rivolta che è conseguenza di interpretare religiosamente certi avvenimenti e certi fenomeni. Io non posso giudicare peccatore nessuno fuori che me. Un altro torto è quello di credere che nella miseria si possa essere anche moralmente più a posto. La ricchezza è una tentazione ed è cattiva perché è una tentazione, ma la miseria è più d’una tentazione: è tentazione e occasione. Se perde la testa un ricco, non è scusato, ma se la perde un povero, quante scuse ha! La moralità è l’effetto di una condizione normale della vita. L’eroismo, il Signore normalmente non lo chiede, mentre per uno in miseria il minimo sforzo morale è un eroismo. L’uno di bontà di un miserabile è più del cento di bontà d’un benestante. Prima di parlare della cattiveria dei poveri pensiamo che questa cattiveria è superiore e migliore alla nostra bontà perché la nostra poca bontà ci costa così poco. Ancora: torto è il non aver paura dello sconcerto che la crisi porta ad [impoverire?] l’audacia per poterci rimediare, per impedire di cadere alle impalcature che minacciano rovinare in questo momento. Uno dei torti più gravi dei cristiani è di mancare di audacia. Si dimentica che il Signore assiste la sua Chiesa e ciò che alla Chiesa è legato: l’umanità, tesoro della Chiesa. Noi viviamo in un’epoca che non solo nelle parole, ma nei fatti, è rivoluzionaria. Cascano tante cose che noi ieri credevamo indispensabili. C’è della gente che ha lo spavento nel cuore e nella testa. Quello che casca è perché non può stare in piedi, e se casca non deve far spavento anche se rompe le nostre abitudini mentali. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio anche in quegli avvenimenti che sconcertano il nostro modo di vedere. Il servizio dei cristiani, in quest’ora, è staccarsi da ciò che credevano e invece non è durevole. Staccarsi anche da quei concetti d’ordine di cui siamo predicatori. Gli effetti materiali della crisi. Professionalmente: la mancanza di respiro, di agio. L’agio non è necessario, ma quando si è pressati dal fatto materiale e si va a scuola con mille preoccupazioni, il nostro lavoro ne risente assai, perché respiriamo spiritualmente a fatica. In un libro di Ford è confrontato il rendimento del lavoro di un operaio preoccupato con quello d’uno non preoccupato: questo era maggiore. Le maestre sposate, per esempio, hanno un legame famigliare che non le lascia dare tutte se stesse alla scuola. Né questo deve meravigliare. Mi meraviglierebbe al contrario che una mamma si dimenticasse i suoi figliuoli sia pure per alcune ore: una sospensione del sentimento materno è impossibile. Io vivo pei miei affetti, non per il mio lavoro. Quando c’è l’adattamento al lavoro per necessità, il lavoro diventa inamabile poiché non si può abbracciare con tutto se stesso. Moralmente: 1) L’abbassamento del livello professionale in conseguenza dello strozzamento dei posti: questi si contendono, onde si denigrano le persone per poter sorpassarle. 2) La facilità della tentazione. A un certo punto del bisogno si ha come uno stordimento: pare che tutto crolli, che non valga più la pena di tenere fermo ciò che va tenuto fermo anche nel nostro campo morale. Quali sono i comandamenti che hanno tenuto duro? Come si può pensare a una coscienza morale nel popolo, a una rinascita spirituale quand’è appunto il senso morale che ha subito un contraccolpo poiché le necessità d’ogni giorno e la lotta per il vivere sono spaventosi? Se è brutta la lotta per il guadagno, ancora più brutta e spaventosa è la lotta per il vivere; ed ora, se è soppressa la lotta di classe, c’è quella per la vita. La concorrenza e il mangiarsi diventati sistema. È facile dire: bisogna moralizzare la lotta per la vita! C’è della gente che non ha gusto a diventare disonesta, che soffre di diventarlo, e lo deve diventare per le necessità personali più stringenti… Questa responsabilità è legata alla società, non all’individuo, perché non possiamo chiedere all’individuo uno sforzo morale quando la società non fa nulla per aiutarlo. A proposito dei doveri morali dell’altro ricordiamo le parole del Signore: «Voi imponete dei pesi tali sulle spalle altrui, che non sapreste muoverli neppure con un dito». Ossia, pur mantenendo integri i nostri principi morali, dobbiamo tener conto delle situazioni, altrimenti diventeremo capaci di creare la rivolta verso ciò che si deve amare. Oggidì si vede accettare ogni compromesso non solo nel commercio, ma anche nei costumi; ma se si medita su una situazione di miseria, vicina a tutte le tentazioni che la società presenta, vicino a tutto quello che si vede di tanto desiderabile, c’è molto da comprendere e perciò da compatire su certe cadute e certe circostanze. Io non accetto il fatto della caduta, ma devo accettare un’altra maniera di giudicare che è la carità cristiana comprensiva della responsabilità dell’uomo che vede scritto per terra: Non chi è senza peccato, ma chi è senza responsabilità scagli la prima pietra. 3) La difficoltà di credere alla bontà di Dio. Quando ci troviamo dinanzi certi casi disperati, la più bella maniera d’apostolato è tacere. Quando sento certi discorsi o di conforto o di dottrina a chi sta male, mi disgusto. Parole anche buone, ma dette fuori posto, irritano. L’irritazione che danno le prediche, specie di tono disumano, è grande, onde si comprende come, in certi casi, il metter la spada nel fodero è la migliore forma dell’apostolato. 4) Oltre la rivolta verso la religione, che è Provvidenza e non si vede, c’è la rivolta verso i cristiani che stanno bene e danno la tremenda impressione che la religione diventi o stia diventando il rifugio dei benestanti. Oh, i cristiani che stanno bene, onde di loro si dice: «Però lui, però lei…». Si vede che si è religiosi nella speranza che la religione possa servire a mantenere non il cristiano, ma il cristiano benestante; ma cristiano e benestante sono due termini contraddittori. Certe tenerezze per la religione non sono che interesse. Siamo in periodo devozionale e Dio è guardato come un distributore automatico. Spesso si attacca alla religione un grande spirito pagano e il paganesimo non è soltanto dottrinale, ma [è] in efficienza, perché esso vuol dire non fare la volontà di Dio, ma far fare a Dio che vogliamo noi. I doveri: 1) Guardare in faccia la crisi. 2) Non chiudere gli occhi alla realtà. 3) Essere generosi di sincerità e d’intelligenza su ciò che ci sta davanti. Il cristiano che non vede, che non capisce il proprio momento, il cuore del fratello, non sarà mai né un cristiano fratello, né un cristiano apostolo.

Don Primo Mazzolari è nato al Boschetto, frazione di Cremona, il 13 gennaio 1890 da genitori legati alla terra da motivi di lavoro e di attaccamento. Ben presto, nel 1899, la famiglia, che si componeva di due figli, Primo e Peppino, e di tre figlie, Colombina, Pierina e Giuseppina, si trasferì a Verolanuova. Qui Primo Mazzolari rimase ben poco: a dieci anni, seguendo la vocazione sacerdotale, entrò nel seminario di Cremona dove proseguì gli studi fino all’ordinazione che gli venne data da monsignor Giacinto Gaggia il 24 agosto 1912. Dopo pochi mesi fu inviato come vicario a Spinadesco, e subito dopo, richiamato in seminario a Cremona come insegnante di Lettere. Scoppiata la Prima guerra mondiale, vi partecipa con il fervore dei giovani in quel momento. Congedato nel 1920 andò parroco a Bozzolo, provincia di Mantova, ma diocesi di Cremona, dove cominciò ad assumere posizioni di difesa dei diritti dei poveri. Nel 1922 venne nominato parroco di Cicognara, "il paese delle scope". Qui iniziò la sua opposizione al fascismo. Nel 1932 fu inviato nuovamente a Bozzolo e nel 1949 fondò e diresse il periodico "Adesso" la cui pubblicazione fu sospesa nel 1951. Nel 1957 predicò la Missione a Milano, chiamato dal Cardinal Montini. Con l’elezione di Giovanni XXIII entrò nella chiesa una ventata nuova e le idee di don Primo ebbero piena cittadinanza. Il 5 febbraio 1959 venne ricevuto in udienza privata da Papa Roncalli: l’accoglienza che egli ebbe dal Pontefice, che lo definì "Tromba dello Spirito Santo della Bassa Padana", lo ripagava di ogni amarezza sofferta. Morì il 12 aprile 1959 nella casa di cura San Camillo di Cremona. Nell'udienza generale del 1° aprile 2009, Papa Benedetto XVI ha affermato: "Il cinquantesimo anniversario della morte di don Mazzolari sia occasione opportuna per riscoprirne l'eredità spirituale e promuovere la riflessione sull'attualità del pensiero di un così significativo protagonista del cattolicesimo italiano del Novecento", auspicando inoltre "che il suo profilo sacerdotale limpido di alta umanità e di filiale fedeltà al messaggio cristiano e alla Chiesa, possa contribuire a una fervorosa celebrazione dell'Anno Sacerdotale". Il 2 aprile 2015 la Congregazione per le Cause dei Santi ha concesso il nulla osta per avviare la causa di beatificazione. Papa Francesco il 20 giugno 2017 ha visitato la sua tomba a Bozzolo. Il 18 settembre 2017, nella cattedrale di Cremona, ha avuto luogo l'insediamento del Tribunale diocesano, che sancisce l'apertura della fase diocesana della causa di beatificazione.
Le origini contadine
Primo Mazzolari nacque al Boschetto, una frazione di Cremona, il 13 gennaio 1890, figlio di Luigi e di Grazia Bolli. Il padre era un piccolo affittuario, che manteneva la famiglia con il lavoro dei campi. Primo fu il primogenito, poi vennero Colombina, Giuseppe (Peppino), Pierina, Giuseppina. Nel 1900, spinta dalla necessità di trovare migliori condizioni di lavoro e di vita, la famiglia Mazzolari si trasferì a Verolanuova, in provincia e diocesi di Brescia. Due anni dopo, terminate le scuole elementari, Primo decise di entrare in seminario. Fu scelto, per la vicinanza dei parenti, il seminario di Cremona, città dove era allora vescovo mons. Geremia Bonomelli, uomo celebre per le sue idee cattolico-liberali, di conciliazione con il giovane Stato italiano.
La vita in seminario
Primo Mazzolari rimase nell'istituto cremonese fino al 1912, anno nel quale fu ordinato prete. Per l'occasione egli tornò in famiglia, a Verolanuova e ricevette l'ordine sacro dal vescovo di Brescia, mons. Gaggia, nella chiesa parrocchiale. Il decennio trascorso a Cremona fu molto duro per il giovane seminarista. Non si può dimenticare che quelli erano i tempi della dura repressione antimodernista avviata da Pio X, che comportò nei seminari l'irrigidimento della disciplina, la cacciata dei professori ritenuti troppo innovativi e la chiusura ad ogni forma di dialogo con la cultura del momento. Anche Mazzolari dovette fare i conti con una seria crisi vocazionale, che riuscì a superare grazie all'illuminato aiuto del padre barnabita Pietro Gazzola, in precedenza allontanato da Milano proprio perché sospettato di indulgenze verso il modernismo. Lo stesso padre Gazzola profetizzò al giovane che la sua vita adulta sarebbe stata «una croce».
I primi incarichi pastorali
Divenuto prete, don Primo fu inviato come vicario cooperatore a Spinadesco (Cremona). Qui rimase circa un anno, venendo poi trasferito nella parrocchia natale, S. Maria del Boschetto. Poco dopo, però, nell'autunno del 1913 fu nominato professore di lettere nel ginnasio del seminario. Svolse tale funzione per un biennio, durante il quale utilizzò le vacanze estive per recarsi in Svizzera, ad Arbon, come missionario dell'Opera Bonomelli tra i lavoratori italiani là emigrati.
Era intanto scoppiata la Prima Guerra Mondiale e, nella primavera del 1915, si pose con forza il problema dell'atteggiamento italiano. Don Mazzolari si schierò in quel frangente tra gli interventisti democratici, così come altri giovani cattolici, tra i quali Eligio Cacciaguerra, animatore della Lega Democratica Cristiana e del giornale «L'Azione» di Cesena, a cui Mazzolari collaborò con diversi articoli. Si intendeva sostenere l'intervento militare italiano nella guerra al fine di eliminare per sempre le forme di militarismo simboleggiate dalla Germania e per contribuire ad instaurare un nuovo regime democratico e di collaborazione internazionale in tutta l'Europa.
La prova della guerra
La guerra comportò però subito un atroce dolore per il giovane prete. Nel novembre 1915, infatti, morì sul Sabotino l'amatissimo fratello Peppino, il cui ricordo rimase sempre vivissimo in don Primo. Questi aveva comunque già deciso di offrirsi volontario: fu così inserito nella Sanità militare e impiegato negli ospedali di Genova e poi di Cremona. Il timore di sentirsi ‘imboscato' spinse però don Mazzolari a chiedere il trasferimento al fronte. Così nel 1918 fu destinato come cappellano militare a seguire le truppe italiane inviate sul fronte francese. Rimase nove mesi in Francia. Rientrato nel 1919 in Italia ebbe altri incarichi con il Regio Esercito, compreso quello di recuperare le salme dei caduti nella zona di Tolmino. Nel 1920 seguì un periodo di sei mesi trascorso in Alta Slesia insieme alle truppe italiane inviate per mantenere l'ordine in una zona che era stata forzatamente ceduta dalla Germania alla neonata Polonia. Tutte le testimonianze concordano nel raccontare dell'impegno e della passione umana con cui don Primo seguì in questi vari frangenti i suoi soldati.
Il periodo di Cicognara
Smobilitato nell'agosto 1920, don Mazzolari chiese al suo vescovo (mons. Giovanni Cazzani) di non tornare all'insegnamento in seminario, ma di essere destinato al lavoro pastorale tra la gente. Dall'ottobre 1920 al dicembre 1921 fu delegato vescovile nella parrocchia della Ss. Trinità di Bozzolo, un paese in provincia di Mantova, ma dipendente dalla diocesi di Cremona. Da qui fu trasferito come parroco nel vicino paese di Cicognara, a due passi dal fiume Po, dove rimase per un decennio, fino al luglio 1932.
A Cicognara don Primo si fece le ossa come parroco, sperimentando iniziative, riflettendo, annotando idee e, soprattutto, cercando forme nuove per accostare tutti coloro che si erano ormai allontanati dalla Chiesa. Il paese, infatti, aveva una forte connotazione socialista. Don Mazzolari cercò in vario modo di valutare positivamente le tradizioni popolari contadine, come la festa del grano e dell'uva, ma non trascurò di commemorare i caduti in guerra e le ricorrenze patriottiche. Durante l'inverno faceva la scuola serale per i contadini e istituì la biblioteca parrocchiale. L'avvento del fascismo lo vide fin dall'inizio diffidente e preoccupato, senza celare la propria intima opposizione. Già nel 1922 egli scrisse, a proposito delle simpatie di certi cattolici verso il nascente regime, che «il paganesimo ritorna e ci fa la carezza e pochi ne sentono vergogna». Nel novembre 1925 rifiutò di cantare solennemente il Te Deum dopo che era stato sventato un complotto per attentare alla vita di Mussolini. Egli preferiva infatti mantenersi su un piano esclusivamente religioso, tanto che perfino nel 1929 si differenziò dall'atteggiamento entusiastico di tanti vescovi e preti, non andando neppure a votare al plebiscito indetto da Mussolini dopo la firma dei Patti Lateranensi. Rifiutava intanto l'esaltazione acritica della guerra e del militarismo e respingeva ogni spirito settario e partigiano. Così, pur evitando di prendere posizioni di aperte rottura, don Primo fu presto considerato un nemico agli occhi dei fascisti e anzi un vero e proprio ostacolo alla ‘fascistizzazione' di Cicognara, e la notte del primo agosto 1931 lo chiamarono alla finestra e spararono tre colpi di rivoltella che fortunatamente non lo colpirono.
La ‘promozione' a Bozzolo
Nel 1932 don Primo fu trasferito a Bozzolo in concomitanza con la fusione delle due parrocchie esistenti. Nell'occasione egli scrisse un piccolo opuscolo, Il mio parroco, per salutare i suoi parrocchiani, vecchi e nuovi. A Bozzolo don Mazzolari iniziò poi a scrivere in modo regolare, così che gli anni Trenta furono per lui molto ricchi di opere. Nei suoi libri, egli tendeva a superare l'idea della Chiesa come ‘società perfetta' e si confrontava onestamente con le debolezze, le inadempienze e i limiti insiti nella stessa Chiesa. A suo parere ciò era necessario per poter finalmente presentare il messaggio evangelico anche ai ‘lontani', a coloro cioè che rifiutavano la fede, magari proprio a causa dei peccati dei cristiani e della Chiesa. Negli scritti di don Mazzolari era inoltre presente l'idea che la società italiana fosse da rifondare completamente sul piano morale e culturale, dando maggiore spazio alla giustizia, alla solidarietà con i poveri, alla fratellanza. Idee simili lo costrinsero inevitabilmente a fare i conti con la censura ecclesiastica e con quella fascista.
Nel 1934 don Mazzolari pubblicò La più bella avventura, basata sulla parabola del figliuol prodigo, ma questo testo fu condannato l'anno dopo dal Sant'Uffizio vaticano, che giudicò «erroneo» il libro e ne impose il ritiro dal commercio. Ubbidiente, don Primo si sottomise. Il Sant'Uffizio non spiegò al povero parroco quali fossero le pagine del libro giudicate erronee: si mosse forse solo su denuncia di qualche cremonese, scandalizzato dal fatto che ambienti protestanti avessero elogiato lo scritto mazzolariano.
Don Primo tuttavia non si scoraggiò. Nel 1938 apparvero così altri suoi testi, come Il samaritano, I lontani, Tra l'argine e il bosco. Quest'ultimo era una raccolta di articoli e scritti vari, da cui emergeva la concezione della parrocchia che don Mazzolari aveva, ma anche la sua capacità di guardare la natura e la realtà della vita di campagna. Nel 1939 fu invece pubblicata La via crucis del povero.
Le opere successive finirono però ancora sotto la scure della censura. Le autorità fascista censurarono infatti nel 1941 Tempo di credere, ritenuto un libro non conforme allo ‘spirito del tempo', quello cioè di un'Italia in guerra. Gli amici di don Primo riuscirono a fare circolare clandestinamente il testo. Nel 1943 tornò invece a farsi sentire il Sant'Uffizio che biasimò l'opera Impegno con Cristo, almeno per la forma utilizzata dall'autore.
Guerra e Resistenza
Nel 1943 alla caduta del fascismo (25 luglio) e all'annuncio dell'armistizio (8 settembre) si aprì la fase più drammatica della storia italiana contemporanea, con la spaccatura del Paese in più parti, l'occupazione tedesca, la nascita della Resistenza e subito dopo della Repubblica Sociale Italiana. Don Primo si impegnò a creare contatti con vari ambienti e personalità cattoliche in vista del domani. Strinse inoltre sempre più rapporti con la Resistenza, così che il suo nome – già inviso da anni ai fascisti – circolò sempre più nelle liste di coloro che erano giudicati nemici del regime di Salò. Nel febbraio 1944 don Mazzolari fu chiamato una prima volta in questura a Cremona per accertamenti; seguì in luglio un vero e proprio arresto da parte del Comando tedesco di Mantova. Liberato e richiesto di restare a disposizione, preferì passare alla clandestinità a Gambara in provincia di Brescia. Lasciò così per qualche tempo Bozzolo, ritornandovi poi di nascosto. Dovette infatti vivere per alcuni mesi completamente segregato, all'insaputa di tutti, al piano superiore della sua stessa casa e solo dopo la Liberazione poté uscire allo scoperto. Testimonianza di quel tempo sono i libri Diario di una primavera e Rivoluzione Cristiana, pubblicati dopo la sua morte.
Il dopoguerra
L'impegno per l'evangelizzazione, la pacificazione, la costruzione di una nuova società più giusta e libera costituirono i cardini dell'impegno di don Mazzolari dal 1945 in poi. Figlio in questo della Chiesa del suo tempo, egli era convinto che solo il cristianesimo potesse costituire un rimedio ai mali del mondo e si fece portatore così dell'idea di una vera e propria ‘rivoluzione cristiana'. I cristiani dovevano essere autentica guida della società, a patto di rinnovarsi completamente nella mentalità e nei comportamenti. Don Primo non perse naturalmente di vista il compito principale della Chiesa, quello dell'annuncio evangelico. Con Il compagno Cristo. Vangelo del reduce (1945) cercò quindi di rivolgersi anzitutto a coloro che tornavano dal fronte o dalla prigionia, per additare loro la via tracciata da Gesù Cristo. Scrisse in quegli anni molti articoli, collaborando tra l'altro ai giornali «Democrazia» e «L'Italia».
Continuò a interessarsi dei ‘lontani', particolarmente dei comunisti. La sua critica del comunismo fu sempre molto dura, come dimostrò il dibattito pubblico con un altro celebre cremonese, Guido Miglioli, ex organizzatore sindacale cattolico ed ex deputato del Partito Popolare, che era approdato alla collaborazione stretta con il Partito Comunista. In ogni caso, come ebbe a dire nel 1949 (l'anno della scomunica vaticana verso i comunisti), lo slogan di don Mazzolari era: «Combatto il comunismo, amo i comunisti».
Dopo le decisive elezioni del 1948, nelle quali appoggiò la DC, don Primo iniziò subito ad ammonire i parlamentari, invitandoli alla coerenza e all'impegno. Un suo articolo portava per esempio un titolo chiarissimo: Deputati e senatori vi hanno fatto i poveri.
La stagione di «Adesso»
Tante speranze di cambiamento andarono presto deluse. Don Mazzolari si rese conto di dover creare un movimento di opinione più vasto e si dedicò allora anima e corpo al progetto di un giornale di battaglia. Il 15 gennaio 1949 uscì il primo numero del quindicinale «Adesso», nel pieno di una stagione in cui si moltiplicavano gli appelli cattolici verso la DC (l'anno dopo, nel 1950, Giorgio La Pira pubblicò L'attesa della povera gente).
Nelle sue pagine il giornale volle toccare tutti i temi cari al suo fondatore: l'appello a un rinnovamento della Chiesa, la difesa dei poveri e la denuncia delle ingiustizie sociali, il dialogo con i ‘lontani', il problema del comunismo, la promozione della pace in un'epoca di guerra fredda. Al giornale collaborarono in molti: da don Lorenzo Bedeschi a padre Aldo Bergamaschi, al sindaco socialista di Milano Antonio Greppi, a tanti preti e laici più o meno noti, come Franco Bernstein, padre Umberto Vivarelli, padre Nazareno Fabbretti, Giulio Vaggi e più tardi Mario V. Rossi.
Intanto don Primo stringeva rapporti sempre più stretti con le voci più libere e critiche del cattolicesimo italiano di quel tempo, dominato dal conformismo e dalla rigidezza nei confronti del mondo contemporaneo: fu così amico del fondatore di Nomadelfia don Zeno Saltini, del poeta padre David Maria Turoldo, del sindaco fiorentino Giorgio La Pira, dello scrittore Luigi Santucci e di molti altri.
Il carattere innovativo e coraggioso di «Adesso» provocò ancora l'intervento vaticano, così che nel febbraio del 1951 il giornale dovette cessare le pubblicazioni. In luglio arrivarono altre misure personali contro don Mazzolari (proibizione di predicare fuori diocesi senza il consenso dei vescovi interessati; divieto di pubblicare articoli senza preventiva revisione ecclesiastica). Si poté ripartire nel novembre dello stesso 1951, ma con la direzione di un laico, Giulio Vaggi. Don Primo collaborò ancora, utilizzando spesso pseudonimi come quello di Stefano Bolli. Proprio alcuni interventi di ‘don Bolli' sul tema della pace provocarono nuove indagini disciplinari. Nel 1950, infatti, si sviluppò un ampio dibattito sulla proposta del movimento dei Partigiani della Pace (a prevalenza comunista) di mettere al bando la bomba atomica e don Mazzolari (che pure aveva accettato l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico) si dichiarò disponibile al dialogo. Insomma, il giornale continuò a vivere pericolosamente. Ancora nel 1954 don Primo ricevette da Roma l'ordine di predicare solo nella propria parrocchia e il divieto di scrivere articoli su ‘materie sociali'.
Gli ultimi anni
Usando sempre il suo caratteristico linguaggio, che puntava direttamente a suscitare l'emozione nel cuore, senza voler indugiare nell'analisi scientifica o sociologica, don Mazzolari pubblicò negli anni Cinquanta altre opere significative.
Nel 1952 uscì così La pieve sull'argine, un ampio racconto fortemente autobiografico, che ripercorreva le vicende e le vicissitudini di un prete di campagna (don Stefano) negli anni del fascismo.
Nel 1955 apparve anonimo Tu non uccidere, che affrontava la questione della guerra. Qui Mazzolari riprendeva un suo scritto inedito del 1941, la Risposta a un aviatore, in cui si era già posto il problema della liceità della guerra. In questo modo il parroco di Bozzolo approdava all'accettazione dell'obiezione di coscienza e pronunciava un durissimo atto di accusa contro tutte le guerre («La guerra non è soltanto una calamità, è un peccato», «Cristianamente e logicamente la guerra non si regge»).
Libri a parte, don Primo spendeva le sue ultime energie per affrontare temi nuovi e conoscere problemi sociali anche lontani: nel 1951 visitò il delta del Po, nel 1952 fece un viaggio in Sicilia, riportandone forti impressioni, e nel 1953 si recò in Sardegna.
Nella Chiesa italiana il nome di Mazzolari continuava intanto a dividere: alle prese di posizione ufficiali, che in pratica lo proscrivevano e lo volevano rinchiudere nella sua Bozzolo, si contrapponevano i tanti amici, ammiratori, discepoli di ogni tipo che si riconoscevano nelle sue battaglie e diffondevano le sue idee in tutta Italia. Lui rimaneva coerente al suo proposito di ‘ubbidire in piedi', sottomettendosi sempre ai suoi superiori, ma tutelando la propria dignità e la coerenza del proprio sentire.
Proprio alla fine della sua vita cominciò a venire qualche gesto significativo di distensione nei suoi confronti. Nel novembre del 1957 l'arcivescovo di Milano mons. Montini (il futuro papa Paolo VI) lo chiamò a predicare alla Missione di Milano, una celebre iniziativa straordinaria di predicazioni e interventi pastorali. Nel febbraio 1959, infine, il nuovo papa, Giovanni XXIII, lo ricevette in udienza in Vaticano, lasciando in don Primo un'intensa emozione.
Ormai però la salute del parroco di Bozzolo era minata e logorata. Don Primo Mazzolari morì infatti poco tempo dopo, il 12 aprile 1959. Anni più tardi, Paolo VI dirà di lui: «Lui aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi. Questo è il destino dei profeti».

La pace a tutti costi
Primo Mazzolari
Ci siamo accorti che non basta essere custodi della pace e neanche uomini di pace nel nostro intimo, se lasciamo che altri ne siano i soli testimoni.
Come cristiani dobbiamo essere in prima linea nello sforzo comune verso la pace.
Davanti per vocazione non per paura.
Quando fa buio la lampada non la si mette sotto la tavola.
Opponendo guerra a guerra, violenza a violenza non si fa' che moltiplicare le rovine. Invece di uno saremo in due a buttar giù, non importa se per ragioni o con animi opposti. Perché non ammazzo chi non è d'accordo con me, non vuol dire che io sia d'accordo con lui. Non l'ammazzo perché sono certo che la mia verità ha tanta verità da superare l'errore dell'altro.
La verità non ha bisogno della mia violenza per vincere.
Il cristiano è contro ogni male, non fino alla morte del malvagio, ma fino alla propria morte, dato che non c'è amore più grande che quello di mettere la propria vita a servizio del bene del fratello perduto.
Vince chi si lascia uccidere, non chi uccide. La storia della nostra redenzione si apre con la strage degli Innocenti e si chiude con il Calvario.
Un cristiano deve fare la pace anche quando venissero meno le ragioni della pace. Al pari della fede, della speranza e della carità, la pace è vera beatitudine, quando non c'è tornaconto o interesse o convenienza, vale a dire quando incomincia a sembrare follia davanti al buon senso della gente ragionevole.
Tutti si battono e si sputano addosso e aizzano gli uomini, i tuoi figli, gli uni contro gli altri.
Tutti si armano pieni di superbia.
Tutti fanno come se la pace e la guerra fossero in loro potere.
Pasolini.."il discepolo amato"

"Morsicato da Gesù Cristo"
Enzo Bianchi
Per il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini molti hanno scritto su di lui ma non ho trovato riferimenti alla sua postura di “morsicato da Gesù Cristo”. Eppure Pier Paolo ha lasciato molte tracce nei suoi scritti, nelle opere cinematografiche e anche, sconosciuta ai più, nella sceneggiatura di un film mai realizzato su Paolo di Tarso. Vale forse la pena che condivida alcuni miei incontri con lui che hanno avuto per me profondo significato.
Incontrai per la prima volta Pasolini nel 1963 su una terrazza della Pro Civitate Christiana di Assisi. Era un pomeriggio di ottobre carico di silenzio e lui aveva un libriccino in mano che leggeva, staccandone sovente lo sguardo fissarlo nel vuoto, per pensare. Mi disse di essere affascinato dal Vangelo, soprattutto dal Vangelo secondo Matteo, e che “non fare un film ma lasciare che il Vangelo stesso fosse un racconto visivo”. Iniziò così la nostra conversazione, della quale annotai subito alcune frasi per non dimenticarle: “Io non credo che Cristo sia Figlio di Dio, perché non sono credente, almeno nella mia coscienza, ma credo che Cristo sia divino: credo cioè che in lui l’umanità sia così alta, così rigorosa e ideale, da andare al di là dei comuni termini dell’umanità”.
Ci rivedemmo ancora a Torino dove mi parlò della sua intenzione di lavorare per un film sull’apostolo Paolo. Diffidando del ritratto che Luca, l’autore degli Atti degli Apostoli, offre di Paolo, Pasolini intendeva utilizzare soltanto la trama degli Atti degli Apostoli e far parlare Paolo solo attraverso i testi delle sue lettere. Per l’apostolo Paolo aveva una passione profonda come per Cristo: una passione in cui carne e sangue erano presenti, mai negati, ma per così dire sovraesaltati. Nel maggio del 1968 scrisse un “Abbozzo di sceneggiatura per un film su San Paolo”, di cui parlammo ancora ad Assisi in Pro Civitate, e la sua preoccupazione era, come disse, che “San Paolo risultasse vivo qui e ora tra noi”. Per questo voleva rendere contemporanee le città e il Mediterraneo di Paolo, e far risuonare le parole dell’apostolo a Londra, Barcellona e oltre Atlantico. Pasolini era affascinato dal Paolo che predicava la croce, lo scandalo per gli uomini religiosi, la follia per gli intellettuali. Vedeva la morte violenta dell’apostolo accadere in una New York di acciaio e cemento, emblema del mondo disumanizzato che è diventato il nostro.
Un giorno del 1969, più oppresso del solito nel condividere con me le forti tensioni di quell’anno così denso di cambiamenti e di violenza, mi confessò: “Anch’io sono caduto da cavallo come Paolo, ma un piede è rimasto nella staffa e così continuo a battere la testa qua e là!”. Mentre mi diceva questo un’inenarrabile tristezza gli saliva al cuore e affiorava sul suo volto scavato. Tre anni fa incontrai ancora una volta a Cadaqués il mio caro amico Enrique Irazoqui (l’attore che interpretò Gesù nel Vangelo secondo Matteo) poco prima che morisse. Insieme ricordammo Pier Paolo, la luce che attraversa la sua tristezza, l’enigma della sua costante e testarda interpretazione di se stesso come inascoltato profeta e come ”povero Cristo”.

Secondo Matteo
A 100 anni dalla nascita di Pasolini
Piero Stefani
Alla 25a mostra del cinema di Venezia (1964) il Leone d’oro fu assegnato a Deserto rosso di Michelangelo Antonioni, con protagonista la compianta Monica Vitti. Dopo l’oro, l’argento, il secondo premio, fu assegnato a Il Vangelo secondo Matteo, pellicola (allora lo si poteva dire alla lettera) dedicata «alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII», morto, come era a tutti noto, nel giugno dell’anno precedente. Gli spettatori invece ignoravano la tragica fine a cui sarebbero andati incontro i due uomini fotografati, seduti uno accanto all’altro, nella sala cinematografica del Lido.
Uno, più alto, indossava un doppiopetto scuro; l’altro, più minuto, uno smoking. Si trattava del presidente del Consiglio in carica, on. Aldo Moro, e del regista del film, Pier Paolo Pasolini. Il primo sarebbe stato ucciso nel maggio del 1978, mentre il secondo sarebbe stato trucidato il giorno dei morti del 1975. Erano lì per vedere un film che, dopo aver dato ampio spazio alla morte in croce, terminava con un sobrio riferimento alla risurrezione di Gesù, evento in cui uno solo dei due illustri personaggi credeva.
A quanto è dato sapere, in un primo momento l’ateo Pasolini si proponeva di terminare la propria opera con la scena della morte di Gesù. Poi ci ripensò. Avrebbe forse potuto fare altrimenti, visto che era suo desiderio «che il mio film potesse essere proiettato nel giorno di Pasqua in tutti i cinema parrocchiali d’Italia e del mondo»? [1] Un ambito quest’ultimo, in un certo senso, simboleggiato, nella sala del Lido, dal cattolico praticante Aldo Moro.
Di certo la pellicola fu in seguito presente in svariati cinema parrocchiali, probabilmente in nessuno di essi fu però proiettata nella domenica di Pasqua. Oggi anche quelle sale appaiono, del resto, mondi altrettanto lontani dal misero squallore dei Sassi di Matera d’allora, principale sfondo di un film che, ai nostri occhi, si presenta pure come vivido documento dell’antica povertà delle genti meridionali.
L’incontro che indusse il regista non credente a progettare e a realizzare Il Vangelo secondo Matteo fu, in sostanza, casuale. In una lettera scritta a Lucio Caruso della Pro Civitate di Assisi nel febbraio del 1963, Pasolini affermò che la prima volta in cui aveva soggiornato là aveva trovato «accanto al capezzale» una copia del «Vangelo: vostro delizioso-diabolico calcolo!». L’esca, per così dire, funzionò.
Dopo vent’anni in cui non l’aveva più preso in mano, Pasolini lesse Matteo «tutto di seguito, come un romanzo» e nell’esaltazione della lettura, la maggiore fra tutte, gli venne subito l’idea di farne un film. Vangelo al singolare. Non so dimostrarlo sul piano documentario, ma tutto lascia ritenere che sul comodino ci fosse un volumetto che conteneva tutti e quattro i Vangeli. Pasolini lesse però solo il primo, Matteo; lo percepì come una totalità in sé compiuta. Anzi, colse quel libro come una presenza; è forse un caso che Pasolini impieghi un’espressione, «accanto al capezzale», di solito usata per chi è vicino a una persona malata?
Come un romanzo
Ci s’imbatte all’improvviso in un testo in grado di essere letto tutto in una volta come un romanzo. Solo una piccola parte dei libri biblici è predisposta a essere assunta in questo modo. Tra essi ci sono certo i Vangeli i quali, nella loro forma letteraria, sono pur sempre delle biografie, per quanto sui generis.
Una delle caratteristiche che li distinguono dai racconti della vita degli uomini illustri presenti nella cultura classica è la mancata descrizione dei tratti fisici del protagonista. Che Gesù abbia un corpo è prepotentemente affermato attraverso la presentazione dei suoi gesti, dei suoi rapporti con le altre persone e, in massimo grado, del suo patire. Mentre l’aver sottaciuto le sue fattezze fisiche ha contribuito a far sì che, nel corso delle epoche, i modi di rappresentare la sua figura risentissero, in maniera determinante, della cultura del tempo.
Gesù Cristo è stato rappresentato ieratico e umiliato, sacerdote composto sulla croce e uomo dei dolori contorto fino alla deformazione, biondo e carezzevole o bruno e vigoroso, col volto trasfigurato o con il viso dai lineamenti puramente umani.
Nella modernità, la soggettività dell’interprete ha acquistato maggior spazio. Sui modi di rappresentare Gesù si proiettano sempre più i convincimenti e i sentimenti dell’interprete. Ciò vale anche per Pasolini, a cominciare dalla scelta di affidare il ruolo di Gesù al diciannovenne studente catalano antifranchista Enrique Irazoqui.
Nel film Cristo diviene portavoce del mondo degli umili, dei poveri, dei malati e, in modo eminente, dei bambini, per questo si contrappone ai potenti. Il contrasto era perciò inevitabile. Fin dal principio si coglie che la decisione di Gesù di schierarsi dalla parte delle vittime lo condurrà a essere lui stesso vittima. Gesù adulto compare per la prima volta quando si fa battezzare da Giovanni al Giordano; la sequenza nel film è contraddistinta da un frammento tratto dalla mozartiana Musica funebre massonica, brano che fungerà da sottofondo a tutta la lunga scena della crocifissione. [2]
Se ci si limitasse a ciò, il discorso si concentrerebbe (come non di rado avvenne negli anni Sessanta) sui limiti e sulla portata del marxismo pasoliniano. Il grande salto ermeneutico e artistico compiuto dal poeta, scrittore e regista fu invece la necessità di dar spazio anche a coloro che credono nel Vangelo: «Vorrei che le mie esigenze espressive, la mia ispirazione poetica, non contraddicessero mai la vostra sensibilità di credenti. Perché altrimenti non raggiungerei il mio scopo di riproporre a tutti una vita che è modello – sia pure irraggiungibile – per tutti». [3]
Occorre però spingersi ancora più in là; in Pasolini vi è qualcosa di più del rispetto, pur autentico, della sensibilità altrui. A essere in gioco è la comprensione stessa del testo. Il regista scrisse di non poter, in quanto ateo, raccontare il Vangelo in modo classico: «D’altra parte però volevo filmare il Vangelo secondo Matteo, cioè raccontare la storia di Cristo figlio di Dio. Dovevo dunque narrare un racconto cui non credevo. Non potevo essere io a narrarlo (...) per poter raccontare il Vangelo, ho dovuto immergermi nell’anima di un credente, Piero della Francesca, per esempio». [4]
«Tu chiami, Cristo, e senza luce»
Lo sforzo ermeneutico di Pasolini non ebbe nulla da spartire con una conversione. Gesù è rappresentato nel film con un volto sempre e solo umano (la Trasfigurazione – Mt 17,1-8 – non viene rappresentata); eppure egli è presentato nel contempo come figlio di Dio. Pasolini, attraverso la lettura filmica delle pagine evangeliche, riuscì a dare maggiore consistenza a un’intuizione poetica da lui avuta più di vent’anni prima nella Domenica uliva, componimento centrale del ciclo Poesia a Casarsa (1942).
In riferimento alla Domenica della Palme vi si legge il verso: «Tu clàmis, Crist, e senza lum» («tu chiami, Cristo, e senza luce»). Secondo Pasolini, queste parole avrebbero potuto costituire la più efficace epigrafe del suo film. L’inatteso incontro con le pagine del primo Vangelo irrobustisce così inquietudini e sentimenti antichi aprendo uno spiraglio verso una nuova luce o forse verso una nuova e più consapevole oscurità.
Nel film, interamente basato (salvo una fuggevole eccezione) su parole contenute nel Vangelo di Matteo, la scelta di assumere Piero della Francesca come testimone della fede trova riscontro fin dalla scena iniziale. In essa la giovanissima Maria è raffigurata in base a un modello iconico che richiama scopertamente la Madonna del parto di Monterchi, meta per secoli di pie visite di donne prossime alla maternità. [5]
Altrettanto non può dirsi per un altro celeberrimo affresco di Piero, il Risorto di Sansepolcro («il Cristo contadino», per dirla con Giorgio Bassani). Nel film non vi è alcuna trionfale uscita dalla tomba; in esso non sventola alcuno stendardo. L’umile risurrezione pasoliniana non avrebbe tollerato una plateale uscita dal sepolcro. In questo senso la fedeltà al dettato evangelico è massima: i Vangeli, a differenza dell’iconografia occidentale, non descrivono mai Gesù che sta uscendo dalla tomba.
Per altri versi invece Pasolini abbandona completamente il testo matteano. La decisione di rendere lo stupefatto volto di Maria di Nazaret specchio indiretto della risurrezione non trova alcun riscontro testuale né nel primo Vangelo, né altrove. Invero nel presentare la vicenda della Passione, il film integra il Vangelo di Matteo con quello di Giovanni. Ciò avviene a motivo della presenza sia di Maria sia del «discepolo amato» i cui occhi riempiono, più volte, da soli, l’intero schermo.
Le immagini comunicano quanto alle parole (non matteane) è precluso dire: «Donna ecco tuo figlio (...) ecco tua madre» (Gv 19,26-27). Le modalità di ripresa suggeriscono l’esistenza di un’identificazione di Pier Paolo con il «discepolo amato», ipotesi potentemente rafforzata dal fatto che il ruolo di Maria anziana fu affidato alla madre del regista, Susanna Pasolini.
NOTE
1 Cf. G. Bertagna, Il volto di Gesù nel cinema, Pardes Edizioni, Bologna 2005, 28.
2 Le musiche nel film provengono da fonti eterogenee: Bach, Mozart, Prokofiev, Missa Luba, spiritual, blues riproposte, in genere, secondo la tecnica del Leitmotiv.
3 Cf. Bertagna, Il volto di Gesù nel cinema, 28s.
4 P.P. Pasolini, Per il cinema. Vol. II. Mondadori, Milano 2001, 2889-2900.
5 La Madonna del parto compare nei film: La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini e Nostalghia di Andrej Tarkovskij (1983), in entrambi i casi collocata lontana da Monterchi.
(Il Regno Attualità, 4/2022, 15/02/2022, pag. 132)

PASOLINI PIER PAOLO (1922-1975)
"Il Cristo, se tornasse, sarebbe lo scandalo" (Pier Paolo Pasolini). Commenta lo storico Alberto Melloni: "Si, perché rappresenta un modo di parlare di Dio che sfugge alle nostre schematizzazioni, che sbriciola i nostri tentativi di rappresentare Dio in una forma fruibile, utile. Il Dio di cui parla Gesù è sempre scandalosamente più buono di come lo vorremmo e, al tempo stesso, sempre scandalosamente più esigente di come a noi farebbe comodo".
Lettera di Pier Paolo Pasolini al Dott. Lucia S. Caruso della Pro Civitate Christiana di Assisi.
febbraio 1963
Caro Caruso, vorrei spiegarle meglio per scritto, quello che le ho confusamente confidato a voce.
La prima volta che sono venuto da voi a Assisi, mi sono trovato accanto al capezzale il Vangelo: vostro delizioso diabolico calcolo! E infatti tutto è andato come doveva andare: l'ho riletto - dopo circa vent'anni (era il quaranta, il quarantuno, quando, ragazzo, l'ho letto per la prima volta: e ne è nato “ L'Usignolo della Chiesa Cattolica ”, - poi l'ho letto solo saltuariamente, un passo qua, un passo là, come succede...).
Da voi, quel giorno, l'ho letto di seguito, come un romanzo. E, nell'esaltazione della lettura - Lei lo sa, è la più esaltante che si possa fare! - mi è venuta, tra l'altro, l'idea di fame un film. Un'idea che da principio mi è sembrata utopistica e sterile, “esaltata ”, appunto. E invece no. Col passare dei giorni e poi delle settimane, questa idea si è fatta sempre più prepotente e esclusiva: ha cacciato nell'ombra tutte le altre idee di lavoro che avevo nella testa, le ha debilitate, devitalizzate. Ed è rimasta solo lei, viva e rigogliosa in mezzo a me.
Solo dopo due o tre mesi, quando ormai l'avevo elaborata - e mi era diventata del tutto familiare - l'ho confidata al mio produttore: ed egli ha accettato di fare questo film cosi difficile e rischioso, per me - e per lui.
Ora, ho bisogno dell'aiuto vostro: di Don Giovanni, Suo, dei suoi colleghi. Un appoggio tecnico, filologico, ma anche un appoggio ideale. Le chiederei insomma (e, attraverso lei, con cui ho maggiore confidenza, alla “ Pro Civitate Christiana”) di aiutarmi nel lavoro di preparazione del film, prima; e poi di assistermi durante la regia.
La mia idea è questa: seguire punto per punto il “Vangelo secondo Matteo”, senza farne una sceneggiatura o una riduzione. Tradurlo fedelmente in immagini, seguendone senza una omissione o un'aggiunta il racconto. Anche i dialoghi dovrebbero essere rigorosamente quelli di San Matteo, senza nemmeno una frase di spiegazione o raccordo: perché nessuna immagine o nessuna parola inserita potrà mai essere all'altezza poetica del testo.
È questa altezza poetica che così ansiosamente mi ispira. Ed è un'opera di poesia che io voglio fare. Non un'opera religiosa nel senso corrente del termine, né un'opera in qualche modo ideologica.
In parole molto semplici e povere: io non credo che Cristo sia figlio di Dio, perché non sono credente - almeno nella coscienza. Ma credo che Cristo sia divino: credo cioè che in lui l'umanità sia così alta, rigorosa, ideale da andare al di là dei .comuni termini dell'umanità. Per questo dico “ poesia ”: strumento irrazionale per esprimere questo mio sentimento irrazionale per Cristo. Vorrei che il mio film potesse essere proiettato nel giorno di Pasqua in tutti i cinema parrocchiali d'Italia e del mondo. Ecco perché ho bisogno della vostra assistenza e del vostro appoggio. Vorrei che le mie esigenze espressive, la mia ispirazione poetica, non contraddicessero mai la vostra sensibilità di credenti. Perché altrimenti non raggiungerei il mio scopo di riproporre a tutti una vita che è modello - sia pure irraggiungibile - per tutti.
Spero tanto che abbiate fiducia in me.
Le stringo la mano, affettuosamente, suo
Pier Paolo Pasolini
Lettera di Pier Paolo Pasolini al produttore Alfredo Bini.
giugno 1963
Caro Alfredo,
mi chiedi di riassumerti per scritto, e per tua comodità, i criteri che presiederanno alla mia realizzazione del “ Vangelo secondo San Matteo ”.
Dal punto di vista religioso, per me, che ho sempre tentato di recuperare al mio laicismo i caratteri della religiosità, valgono due dati ingenuamente ontologici: l'umanità di Cristo è spinta da una tale forza interiore, da una tale irriducibile sete di sapere e di verificare il sapere, senza timore per nessuno scandalo e nessuna contraddizione, che per essa la metafora “divina” è ai limiti della metaforicità, fino 'a essere idealmente una realtà. Inoltre: per me la bellezza è sempre una “bellezza morale”: ma questa bellezza giunge sempre a noi mediata: attraverso la poesia, o la filosofia, o la pratica: il solo caso di “bellezza morale” non mediata, ma immediata, allo stato puro, io l'ho sperimentata nel Vangelo.
Quanto al mio rapporto “artistico” col Vangelo, esso è abbastanza curioso: tu forse sai che, come scrittore nato idealmente dalla Resistenza, come marxista ecc., per tutti gli anni Cinquanta il mio lavoro ideologico è stato verso la razionalità, in polemica coll'irrazionalismo della letteratura decadente (su cui mi ero fermato e che tanto amavo). L'idea di fare un film sul Vangelo, e la sua intuizione tecnica, è invece, devo confessarlo, frutto di una furiosa ondata irrazionalistica. Voglio fare pura opera di poesia, rischiando. magari i pericoli dell'esteticità (Bach e in parte Mozart, come commento musicale: Piero della Francesca e in parte Duccio per l'ispirazione figurativa; la realtà, in fondo preistorica ed esotica del mondo arabo, come fondo e ambiente). Tutto questo rimette pericolosamente in ballo tutta la mia carriera di scrittore, lo so. Ma sarebbe bella che, amando così svisceratamente il Cristo di Matteo, temessi poi di rimettere in ballo qualcosa. Tuo
La crocifissione
“Ma noi predichiamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei, stoltezza per i Gentili. ” .
Paolo, Lettera ai Corinti
Tutte le piaghe sono al sole
ed Egli muore sotto gli occhi
di tutti: perfino la madre
sotto il petto, il ventre, i ginocchi,
guarda il Suo corpo patire,
L'alba e il vespro gli fanno luce
sulle braccia aperte e l'Aprile
intenerisce il Suo esibire
la morte a sguardi che Lo bruciano.
Perché Cristo fu esposto in Croce?
Oh scossa del cuore al nudo
corpo del giovinetto... atroce
offesa al suo pudore crudo...
Il sole e gli sguardi! La voce
estrema chiese a Dio perdono
con un singhiozzo di vergogna
rossa nel cielo senza suono,
tra pupille fresche e annoiate
di Lui: morte, sesso e gogna.
Bisogna esporsi (questo insegna
il povero Cristo inchiodato?),
la chiarezza del cuore è degna
di ogni scherno, di ogni peccato
di ogni più nuda passione...
(questo vuol dire il Crocifisso?
sacrificare ogni giorno il dono
rinunciare ogni giorno al perdono
sporgersi ingenui sull'abisso).
Noi staremo offerti sulla croce,
alla gogna, tra le pupille
limpide di gioia feroce,
scoprendo all'ironia le stille
del sangue dal petto ai ginocchi,
miti, ridicoli, tremando
d'intelletto e passione nel gioco
del cuore arso dal suo fuoco,
per testimoniare lo scandalo.
Pier Paolo Pasolini: cattolici, non adeguatevi!
INEDITO. A trent'anni dalla morte, un dibattito sulla Chiesa in cui lo scrittore non credente propone un ideale di spiritualità che rivaluta la tradizione e la bellezza "popolari" della fede e chiede di non conformarsi alla modernità.
Brani tratti da una tavola rotonda che Giancarlo Zizola organizzò nella sede romana de 'Il Giorno' nel dicembre 1969.
Pasolini: "La domanda è questa: se quello che si esprime attraverso la liturgia è il popolo che voi dite come soggetto, mi pare non arriviamo a una distinzione classista in senso, diciamo, ormai ortodosso e convenzionale della parola. Cioè, quando voi parlate di popolo e borghesia fate una distinzione ancora psicologica o sociologica, ma non sociale e non classista ancora.
Ora, quando voi criticate il borghese, come sarei io ad esempio, che richiederebbe alla messa - almeno in linea
teorica perché in effetti io non vado a messa - il suo mistero, il suo momento estatico, il silenzio o il mistero di una lingua incomprensibile, voi fate un rimprovero massimalistico al borghese; lo chiamate borghese individualista e, in un certo senso, guardate un po' ironicamente questa sua esigenza misticheggiante, che è anche estetizzante. Ma allora vorrei citare una frase di Mircea Eliade che è abbastanza tipica. Egli dice che il popolo vive la ritualità in concreto, completamente, esistenzialmente, corporalmente; il popolo inteso in un senso vago della parola, cioè il popolo come era nelle civiltà contadine, nelle civiltà agrarie, nell'ambito in cui è nata la religione cristiana, vive il rito in concreto e la sua esperienza rituale –dice proprio così- equivale alla più intima esperienza privata, personale dell'uomo moderno. Cioè con questo si istituisce una specie di analogia tra l'esperienza estetica, perché no, di un uomo moderno e l'esperienza religiosa del popolo antico, contadino, preindustriale. Ora, secondo me, questa analogia ha una certa ragione d'essere. Non è che si possa buttar via tacciandola di estetismo e basta. E questa analogia, che si può trovare tra il popolo di oggi, tra l'uomo borghese moderno di oggi e il popolo preindustriale, è un fatto che si ripete oggi nelle chiese, perché in un certo senso il popolo è rimasto quello di allora; in parte è ancora in qualche modo come i preindustriali, vive ancora un'esperienza religiosa di tipo contadino, di tipo magico. E allora le donnette si trovano accanto, alla messa, un borghese colto, estetizzante. Quindi nella messa convivono queste due situazioni che sono analoghe”.
Balducci: “Noi rischiamo sempre di dimenticare che la nostra fede si deve riferire a un convivio, e non ad un banchetto religioso o magico, ma ad un banchetto normale, che conteneva l'intenzione salvifica del Signore.
Secondo me, proprio gli uomini per così dire meno religiosi, si trovano meglio nella liturgia rinnovata. E' una liturgia che domani sarà molto più adatta all'operaio secolarizzato che non al borghese colto, il quale dovrà umiliare la propria religione, il proprio soggettivismo, se vuol essere un credente”.
Marsili: “La liturgia come l'abbiamo fatta finora poteva essere ed è alienante, appunto perché espressione di una religione carica di un atavismo più o meno magico. Nel medioevo tutte le messe erano da morto e certi cattolici arrivavano al colmo dicendo che durante la messa l'anima, per la quale la messa era applicata, veniva liberata dal purgatorio.
Lutero li rimproverava di non fare la messa per i vivi, di non invitare la gente alla cena, ma di fare sacrifici per i defunti. E' in questo senso che oggi dobbiamo distaccarci da questo tipo di liturgia. Bisogna che cominciamo a diventare antitridentini e antimedievali, per fare la riforma. Il medioevo è stata la rovina della Chiesa cattolica, perché è stato la prostrazione della fede, riempita di tutto il magismo nordico. Quando sentiamo Ross definire il medioevo come il tempo delle cattedrali, dico che Ross non ha capito niente, perché quelle cattedrali sono per noi la moltiplicazione del tempio di Gerusalemme. Non deve restare pietra su pietra, arte o non arte che sia...”.
Pasolini: Arte e religione sono due fenomeni coesistenti e strettamente unitari”.
Marsili: “Sì, ma non è più fede, non è più cristianesimo...”.
Pasolini: “Il fatto è che gli edifici delle chiese - arte e religione - erano belli!”
Marsili: “È un altro discorso. Cristo annuncia la distruzione di un tempio e la ricostruzione in sé stesso, proprio per creare una forma nuova alla base della quale c'è solo la conversione. "Convertitevi!": Cristo non lo ha detto ai pagani, ma agli ebrei, che erano attaccatissimi alla religione”.
Pasolini: “Lo so, ma essere antimedievali e antitridentini significa essere alla retroguardia, cioè bisogna trovare qualcosa di più...”.
Balducci: “Per Pasolini, è chiaro, la Chiesa non può vivere solo se ha questa alimentazione "religiosa" . Non può ammettere la distinzione che noi ammettiamo tra fede e religione. Credo che egli ci chieda come
possa domani esistere ancora la Chiesa quando ipotizza il superamento di queste forme religiose”.
Burgalassi: “Ma io proprio come sociologo - a parte il fatto religioso - direi che la Chiesa può esprimere anche in futuro valori di profezia riscoprendo l'uomo.
Pasolini: Ma l'uomo del futuro sarà un uomo alienato…
Burgalassi: La liturgia di oggi, nella misura in cui permette la riscoperta dei valori umani –la spontaneità, la comunità, la comunione, l'amore- guarda al futuro, cioè scopre l'uomo e favorisce la crescita dell'uomo.
Pasolini: Lo scopre nel momento in cui l'uomo sta, come mai è avvenuto nella sua storia, per venire alienato… La nuova liturgia in un certo senso borghesizza il rapporto tra sacerdote e fedele. Mentre prima era un rapporto feudale: la messa in latino era un rapporto feudale tra un popolo preindustriale e una élite di tipo feudale. Quindi la Chiesa era alienante in quanto il sacro era un abituare il popolo alla rassegnazione, al 'memento mor' come dice Marcuse.Adesso invece il rapporto non è più tra feudatari o piccole élites di potenti e un grande popolo di tipo preindustriale, adesso il rapporto è tra piccola borghesia e classe dominante, un borghese di tipo capitalistico e un popolo che si sta rapidamente evolvendo. La liturgia abolendo il latino, dando questa forma di democrazia alla Chiesa, si adegua ai tempi. Io faccio un discorso puramente esteriore, non lo faccio dal l'interno della Chiesa. A questo punto l'unico atteggiamento della Chiesa, se vuole salvare l'uomo attraverso i valori umani di cui voi mi parlate, è l'opposizione totale, radicale alla borghesia, che va verso una trasformazione completamente alienante dell'uomo. E infatti se voi osservate le società borghesi più progredite di quella italiana - per esempio in America - il loro tipo di religiosità è una religiosità completamente alienante. Tutte queste forme di religiosità - per esempio gli hyppies- sono tutte di tipo repressivo e alienante. Ora il futuro immediato, anche in Italia è questo qui”.
Balducci: “Se il compito del Vangelo è quello di liberare completamente l'uomo, allora si tratterà di vedere via via quali sono le forme alienanti e l'importante è che la Chiesa non si allinei”.
Pasolini: Allora questa Chiesa dovrà essere radicalmente, massimalisticamente antiborghese.
Balducci: “Io direi che il momento liturgico dovrebbe essere - una volta realizzato al di fuori degli involucri sacrali che ancora lo inceppano - il momento della massima responsabilizzazione dell'uomo. Per noi la riflessione col mistero del Cristo è una riflessione che non può essere considerata per definizione alienante. Ma se noi crediamo che l'uomo abbia la possibilità, mediante la fede, di trascendere le forze storiche che lo dominano, allora il credente diventa non l'uomo che volta le spalle alla storia per rivolgersi a Dio, ma l'uomo che si pone in faccia alla storia in una situazione di responsabilizzazione massima, che poi viene data dalla parola profetica. In ogni modo tutte le forze che responsabilizzano l'uomo per noi sono forze evangeliche”.
Pasolini: "Anch'io penso che il Vangelo sia uno dei modi di responsabilizzazione autentica… Ma allora come ottenere questo? Perché ad un certo punto l'uomo potrà non essere più in grado di capirvi”.
Marsili: "L'uomo capisce sé stesso, l'uomo capirà sé stesso, capirà il proprio bisogno in quanto l'uomo cerca di superare sempre la situazione attuale”.
Pasolini: “È un' altra osservazione ottimistica, devo dire. Ma facciamo un' osservazione pessimistica: ad un certo punto l'uomo non sarà più in grado di capire sé stesso. Avrà una tale falsa idea di sé, che non sarà più in grado di capirsi.
Da quello che posso presupporre come uno che si interessa un po' di psicologia vedo davanti a me un tipo di società in cui sarà difficile fare un discorso religioso, cioè autentico, perché o sarà incapace di avvertire un discorso religioso perché occupato soltanto dalla soteriologia terrena perché semplicemente non ci sarà più teismo ma neppure antiteismo. E' logico che la società si configuri così... Oppure può darsi che le forme religiose future, che stanno crescendo come dice Paolo VI, siano però del tipo alienante che si diceva”.
Balducci: “Comunque la cosa paradossale è che il più religioso è stato Pasolini”.

Oggi è Domenica,
pei prati con freschi piedi
saltano i fanciulli
leggeri negli scarpetti.
Cantando al mio specchio,
cantando mi pettino.
Ride nel mio occhio
il Diavolo peccatore.
Suonate, mie campane,
cacciatelo indietro!
"Suoniamo, ma tu cosa guardi
cantando nei tuoi prati?"
Guardo il sole
di morte estati,
guardo la pioggia,
le foglie, i grilli.
Guardo il mio corpo
di quando ero fanciullo,
le tristi Domeniche,
il vivere perduto.
"Oggi ti vestono
la seta e l'amore,
oggi è Domenica,
domani si muore".
David Maria Turoldo..uno "scaricatore del porto di Dio"


Quel Dio alla frontiera tra essere e nulla
Trent’anni fa, giovedì 6 febbraio 1992, padre David Maria Turoldo chiudeva la sua esistenza piuttosto unica per intensità, creatività e passione, in una clinica milanese allora gestita dai Padri Camilliani. Quattro giorni prima, nella domenica dedicata dalla Chiesa italiana alla Vita, nonostante i dolori lancinanti inferti dal «mostro», come egli definiva il cancro che si annidava nelle sue viscere, aveva celebrato un’ultima Messa, trasmessa da Rai Uno, suggellando l’omelia con un estremo messaggio di speranza: «La vita non finisce mai!». Anzi, il giorno antecedente alla sua morte aveva ancora intessuto e letto a noi amici un «salmo», ricreando liberamente una delle pagine di quel Salterio biblico che era stato uno dei suoi grandi amori spirituali e poetici.
In quei versi risuonava un tema abissale e supremo che aveva segnato di sangue gli scritti di mistici come Giovanni della Croce o Maestro Eckhart o Angelo Silesio, il Nulla, il Nada, nel quale però sbocciava il fiammeggiare del divino: «Impossibile che sia il Nulla / l’estremo traguardo: / impossibile sarà pensarti / come realmente tu sei, o mio Signore: / sconosciuto Iddio sei tu / nostra unica sorte». Quel germe di luce che, durante la celebrazione funebre del sabato successivo 8 febbraio, il cardinale Carlo Maria Martini aveva idealmente fatto sbocciare nella chiesa milanese di San Carlo al Corso, evocando la «rocciosità» della fede del frate che era vissuto come «Servita di Maria», l’Ordine religioso a cui apparteneva.
Ricomporre la biografia di questo protagonista della storia ecclesiale e culturale del Novecento è piuttosto arduo per la sua debordante ricchezza, varietà e dialettica. Ha cercato di farlo in modo esemplare la storica Mariangela Maraviglia in David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza (1916-1992), un saggio edito nel 2016 dalla Morcelliana. Forse il ritratto simbolico sarebbe da cercare in un’istantanea ideale della folla che nella deliziosa chiesa di Fontanelle a Sotto il Monte Giovanni XXIII si raccoglieva ogni domenica per la liturgia, ascoltando la sua omelia, partecipando ai canti intessuti sui suoi testi, vivendo in profondità l’eucaristia. Oppure si potrebbero fissare in un’altra immagine i volti che nelle sale o nelle piazze seguivano i percorsi ora pianeggianti, ora d’altura, dei suoi discorsi.
A questo punto è necessario introdurre anche un risvolto autobiografico. La mia amicizia con padre David era nata in seguito alla pubblicazione negli anni 1982-1984 di un mio imponente commentario ai Salmi: tre volumi di oltre tremila pagine che Turoldo aveva studiato, riletto e approfondito. Per questo mi aveva cercato ed era iniziata una consuetudine durata poi per anni. Nel pomeriggio di ogni domenica scendeva dalla sua abbazia di Sotto il Monte, il luogo di nascita di Giovanni XXIII , a casa dei miei familiari a Osnago (Lecco), ove io mi recavo, dal Seminario in cui allora insegnavo, per il mio impegno pastorale del fine settimana. Ed era in quelle ore che parlavamo a lungo, che egli mi leggeva i suoi testi, che accoglieva con un’umiltà assoluta anche le mie riserve, che ci si inoltrava lungo i sentieri di altri libri biblici che io allora stavo commentando, come Qohelet e il Cantico dei cantici, destinati a diventare materia di altre sue riflessioni o poesie. Era, così, nata la sua nuova versione poetica dei Salmi Lungo i fiumi… accompagnati dal mio commento, un testo riedito almeno una quindicina di volte fino al 2012 e riproposto in questi giorni dalla San Paolo in una nuova edizione, da me rivista e arricchita, col titolo I canti nuovi.
Di quei pomeriggi, che mi resero padre David amico e interlocutore intimo, c’è una testimonianza curiosa che è anche la “sorpresa” estrema che egli volle farmi. Infatti alla sua opera postuma, edita da Rizzoli nel 1992, Il dramma è Dio (egli, però, aveva scelto come titolo Il dramma è di Dio) aveva apposto una lettera a me destinata ma che aveva voluto rimanesse segreta fino al momento della pubblicazione del libro. La lessi, perciò, quando ricevetti l’opera stampata ed egli era morto da un paio di mesi. Eccone il testo, datato «Festa dell’Ascensione 1991», che ho spesso avuto occasione di citare.
«Gianfranco, mi perdonerai di chiamarti sempre così: amico delle mie — delle nostre — domeniche. È per riconoscenza di questa amicizia e di quei nostri conversari, nell’atrio della tua casa, smentendo che quella sia l’ora del “demone meridiano” (tanta invece era la serenità e la gioia di quei nostri amati colloqui); è per sdebitarmi, dico, del dono di una così ricca amicizia che ora ti dedico questo lavoro… convinto che mi perdonerai di aver osato apparire come un invasore del tuo campo biblico. Ma tu sai che non è vero. Tu più di altri sai con quanto timore e tremore mi accosto a questi abissi; e quanto mi conforta il rispetto verso di voi, insostituibili interpreti. È poi noto che scrivo soprattutto per gli amici…; per gli amici antichi, quelli della resistenza per l’“Uomo”: presenze che sempre evoco nelle mie dediche, al fine di continuare appunto a “resistere”».
Da queste righe emerge in modo nitido il nesso intimo tra amicizia e fede, tra dialogo e ricerca sulla Parola di Dio, tra poesia e confessione. Proprio come aveva scritto in modo lapidario nella prefazione al saggio Il grande male il suo amico Carlo Bo: «Padre David ha avuto da Dio due doni: la fede e la poesia. Dandogli la fede, gli ha imposto di cantarla tutti i giorni». E si potrebbe aggiungere «in tutti i luoghi», dalle zolle della sua nativa Coderno in Friuli fino nei sotterranei della lotta antifascista, tra gli echi delle volte del Duomo di Milano ma anche nella familiarità calda di Nomadelfia, dall’Annunziata di Firenze a S. Maria delle Grazie a Udine, dal monte Berico al Senario, dall’amatissimo ritiro per nulla eremitico di Sotto il Monte alle sale, alle aule, alle piazze vocianti, dai luoghi di un esilio forzato indotto dalle autorità ecclesiastiche, come il Canada lontano e sterminato o l’Austria, la Baviera, la Svizzera, l’Inghilterra e persino gli Stati Uniti, fino ai piccoli centri, fino appunto al villaggio bergamasco o pugliese.
La sua figura imponente e sanguigna («questo vichingo», come lo soprannominarono i Fiorentini), dalla quale fuoriusciva una voce da cattedrale o da deserto, vanamente temperata dall’invincibile sorriso degli occhi chiari, aveva proprio nella Parola biblica il suo alimento vitale. «Servo e ministro sono della Parola», si era autodefinito, consapevole che ormai tutto il suo essere si era trasformato in «una conchiglia ripiena» dell’eco di quella parola infinita come il mare. A lui era profondamente caro il verso di un altro suo amico, unito nella fede e nella poesia, Clemente Rebora: «La Parola zittì chiacchiere mie». Per questo il suo affettuoso ammiratore, interamente ricambiato, il citato cardinale Martini, nella presentazione del volume Opere e giorni del Signore, aveva comparato padre Turoldo a Efrem Siro ( IV secolo) e al bizantino Romano il Melode ( VI secolo), straordinari autori di omelie bibliche cantate.
Forse bisognerebbe in modo sistematico e rigorosamente critico rileggere l’immensa produzione poetica turoldiana proprio inseguendone la filigrana biblica. È noto, infatti, che il flusso letterario e spirituale di questo «cantore delle dense ore di Dio» copre l’intera sequenza delle Sacre Scritture, dalla Genesi, con l’irrompere della creazione dal grembo del nulla, fino all’Apocalisse e al suo sospiro finale del Maranathà, «Vieni Signore», passando soprattutto — come si diceva — attraverso l’amatissimo Salterio. La pagina turoldiana è come un intarsio di citazioni, allusioni, ammiccamenti, evocazioni bibliche: il suo è lo spartito della Parola suprema orchestrata in parole.
Le sue due opere finali sono le più potenti, ancorate anch’esse alla Bibbia, sia pure in una forma originale e inedita. Sono Mie notti con Qohelet e i Canti ultimi, questa seconda raccolta da considerare come il suo testamento e forse il suo capolavoro. In essa ritorna il tema lacerante del Nulla mistico: «Dio e il Nulla — se pure l’uno dall’altro si dissocia… / Tu non puoi non essere / Tu devi essere, / pure se il Nulla è il tuo oceano». Questo groviglio di luce e di tenebra ha la sua raffigurazione emblematica nel Cristo crocifisso («Fede vera è il venerdì santo / quando Tu non c’eri lassù») e padre David ne è stato attratto come da un gorgo avvinghiante.
Già lo era stato in molte liriche precedenti. «E Tu, Tu, o Assente, mia lontanissima sponda… Mio Dio assente lontano… Ma Lui, Lui sempre lontano, invisibile… La tua assenza ci desola… All’incontro cercato nessuno giunge… Notte fonda, notte oscura ci fascia — nera sindone — se tu non accendi il tuo lume, Signore!… Ma tu, Signore, sei bianca statua di marmo nella notte… Un Dio che pena nel cuore dell’uomo…». Negli ultimi scritti, però, Turoldo si mette in viaggio verso questa Gerusalemme capovolta in modo deciso, pellegrino del Nulla e del Tutto. Passa in mezzo a silenzi astrali, scivola nel «cratere» del Dio incandescente, naviga «nei fiordi della speranza» e percorre «tunnel sottomarini» in cui baluginano luci giallastre, inseguito sempre dallo sguardo di Dio «come di un falco appollaiato sul nido».
Ed è proprio alla frontiera tra essere e nulla che Turoldo incontra Dio, come Giacobbe dopo la lotta al fiume Jabbok o come Giobbe dopo il lungo grido tenebroso. Su quella linea di demarcazione non c’è un Dio imperatore impassibile e onnipotente, bensì un Dio sofferente, perché «ogni creatura ti muore tra le braccia nel mentre che si forma e si fiorisce». Un Dio che, nel creare, ha sperimentato il Nulla, il suo antipodo, «Tua e nostra frontiera», e che in Cristo ha bevuto il calice della morte.
Sono note le tensioni con le istituzioni ecclesiastiche che segnarono la vicenda di p. Turoldo, certamente da ricostruire nel contesto di quel periodo storico pieno dei fermenti del Concilio Vaticano II , tenendo conto della sua passione vigorosa e anche del suo ripetuto desiderio di non cercare né dissenso né consenso ma solo un senso profondo e autentico. D’altronde, il suo sguardo — simile a quello di altri suoi amici come don Mazzolari, don Milani, don Zeno, padre Balducci, padre Camillo De Piaz — si proiettava oltre, verso un futuro che solo successivamente si è delineato, sia pure in forme sempre contrastate e contrastanti. A questo proposito vorrei segnalare un curioso ricordo che non ho mai avuto occasione di rivelare. Un giorno, durante uno dei nostri dialoghi — eravamo negli anni ’80 — padre David aveva esclamato: «Mi piacerebbe che un Papa scegliesse come nome quello di Francesco d’Assisi».
Concludendo questa memoria essenziale, si deve comunque riconoscere che la radice dell’impegno di padre Turoldo è stata sempre l’incarnazione del cristianesimo. Una presenza viva che si attestava spesso sulle frontiere più roventi o nei territori più disabitati da presenze religiose. I rischi di queste incursioni erano evidenti e sono a tutti noti. Ma padre David ha sempre tenuto alta la fiaccola della speranza cristiana, convinto che Cristo è con noi «vagabondo / a camminare sulle strade, / a cantare con noi / i salmi del deserto». Convinto anche che la meta ultima della storia è trascendente, là dove «le lettere del divino Alfabeto / saranno in fiore per il Cantico Nuovo».
E nei nostri giorni spesso superficiali è ancor più necessario far risuonare la voce di questo frate e poeta che inquieta la pigra pace delle coscienze col fuoco di quell’Alfabeto che risuona dal roveto ardente.
Gianfranco Ravasi

Amore, che mi formasti
a immagine dell'Iddio che non ha volto,
Amore che sì teneramente
mi ricomponesti dopo la rovina,
Amore, ecco, mi arrendo:
sarò il tuo splendore eterno.
Amore, che mi hai eletto fin dal giorno
che le tue mani plasmarono il corpo mio,
Amore, celato nell'umana carne,
ora simile a me interamente sei,
Amore ecco, mi arrendo:
sarò il tuo possesso eterno.
Amore, che al tuo giogo
anima e sensi, tutto m'hai piegato,
Amore, tu m'involi nel gorgo tuo,
il cuore mio non resiste più,
ecco, mi arrendo, Amore:
mia vita ormai eterna.
David Maria Turoldo

Non so quando spunterà l'alba
non so quando potrò
camminare per le vie
del tuo paradiso
non so quando i sensi
finiranno di gemere
e il cuore sopporterà la luce.
E la mente (la mente!)
già ubriaca, sarà
finalmente calma
e lucida:
e potrò vederti in volto
senza arrossire.
(Padre David Maria Turoldo)
Rosarita de Martino..storia di una chiamata

Rosarita De Martino ha vissuto la sua prima giovinezza (dal 1948 al 1960) a Canolo (RC) in un clima culturale ricco di fermenti religiosi e politici ispirati ai racconti di Guareschi. Si è diplomata nell’Istituto Magistrale di Locri (RC) nel 1960.
Ritornata a Catania, patria dei suoi genitori nel 1962, ha iniziato ad insegnare nella scuola Maria Montessori di Catania, dove, per ben 38 anni, ha profuso la sua passione di educatrice, realizzando un dinamico rinnovamento professionale e spirituale, che la poetessa racconta nel libro autobiografico “Storia di una chiamata".
Ha partecipato a diversi concorsi letterari nazionali, dove ha conquistato i primi posti. Le poesie vincitrici sono state pubblicate in diverse antologie e nella rivista letteraria “Il Convivio”.
Rosarita ha scritto inoltre un libro edito “Incontro- Vangelo in versi”.

MELODIA ETERNA
Ti cerco, o Dio,
nell'ordine dell'universo
e nella bellezza fiorita.
Attonita capto
Tua presenza amica
nel suo sguardo
ridente,
nella musica verde
del bosco,
nel silenzio melodico
del cuore.

LAMA DI LUCE
… e sollevo bianco velo
di pace.
Musica silenziosa
m’ inonda,
solitudine sonora
mi placa.
Volteggio
in prato di speranza.
Improvvisa, attesa
lama di luce
mi inebria.
Mi avvolgo
in manto
di preghiera

Pensieri,
simili a fili di seta,
corrono,
scintillano,
si accavallano.
E io trattengo,
nelle mie fragili mani,
lo scattante gomitolo
della vita.
Rosarita De Martino

Travaglio
Grovigli di pensieri
si impigliano
in vuoto di parole
trascinandomi
in fiumi di paure.
Precipito. Grido.
Imploro.
Appare
improvvisa
la diga sicura
di mia fede
fanciulla.
E mi ritrovo
o Signore
fra le tue braccia:
accoglienti
come ieri,
come oggi,
come sempre!
Rosarita De Martino

L’ARPA DEL TEMPO
Canta di me bimba
che corro lieta
nel vento della gioia.
Mia madre,
lunga treccia bionda,
trepida mi raggiunge.
Fiero della sua divisa,
mio padre mi regala
sguardo d’amore.
Studentessa solerte
salgo antiche scale
con peso di cultura.
Ma domande eterne
pungolano mia vita.
Improvvisa lama di luce
appare lì sul lago
di Gambarie.
Ecco Tue risposte attese
spengono la mia sete.
E fede esplode
in onde di preghiera
Oggi china mi trovo
sui banchi della scuola.
Ridenti bimbi,
figli non miei,
intenti sono
a ricamar parole,
speranze nuove
per il domani della storia
Teilhard de Chardin..ogni minima azione ricolma di Dio

"Caro amico, tu vuoi rivalorizzare il tuo lavoro umano che ti sembra svalutato dalle prospettive e dall'ascetica cristiane. Ebbene, hai solo da riversarvi la meravigliosa sostanza della buona volontà. Purifica la tua intenzione, e ogni minima azione sarà ricolma di Dio."
Teilhard de Chardin

Si vorrebbe insegnare a vedere Dio dappertutto: vederlo nel punto più segreto, più consistente, più definitivo del Mondo. Ciò che è racchiuso e proposto è dunque solo un atteggiamento pratico o forse in modo più preciso, un’educazione degli occhi …
Ognuno di noi ha come compito la divinizzazione dell’intero Universo.
P. Teilhard de Chardin

A chi dispiega adeguatamente la vela al soffio della Terra, si rivela una corrente che lo costringe ad inoltrarsi sempre più in alto mare. Più le aspirazioni e le azioni d'un uomo sono nobili, più questi diventa avido di fini grandi e sublimi da conseguire. Ben presto non gli bastano più la sola famiglia, la sola patria, il solo aspetto remunerativo della sua azione. Avrà bisogno di creare delle organizzazioni generali, di aprire vie nuove, di sostenere delle Cause, di scoprire delle Verità, di nutrire e di difendere degli Ideali. – Così, gradualmente, l'operaio della Terra cessa di appartenere a se stesso. A poco a poco, il grande soffio dell'Universo, insinuatosi in lui attraverso la fessura d'un agire umile ma fedele, lo ha dilatato, sollevato, trascinato.
Teilhard de Chardin

Il cristiano è ad un tempo l'uomo più dedito e distaccato che esiste. Convinto, più di un qualsiasi ‘mondano', del valore e dell'interesse insondabili nascosti nel benché minimo successo terreno, è nel contempo persuaso, alla pari di un qualsiasi anacoreta, della fondamentale nullità di ogni risultato inteso semplicemente come vantaggio individuale (anche universale) all'infuori di Dio. Egli cerca Dio e solo Dio, attraverso la realtà delle creature. Per lui, l'interesse è veramente nelle cose, ma in assoluto subordine alla presenza di Dio in esse. Per lui, la luce celeste diventa tangibile e raggiungibile nel cristallo degli esseri; ma desidera solo la luce; e se la luce si spegne perché l'oggetto è spostato, superato, oppure se ne va, anche la sostanza più preziosa non diventa che cenere ai suoi occhi. Così, ‘sin nel proprio intimo e negli sviluppi più personali che si procura, non cerca se stesso ma il più Grande di sé, al quale sa di essere destinato. Davvero, al proprio sguardo, non conta più; non esiste più; si è dimenticato e perso nello stesso sforzo del perfezionamento. Non è più l'atomo che vive, è l'Universo che vive in lui.
Teilhard de Chardin

Dio al centro dell’universo
Dio nostro,
tu sei al centro di tutto e tutto circondi:
tutto si curva al tuo passaggio:
gioie, progressi, dolori, fallimenti, errori,
opere, preghiere, bellezze,
potenze del cielo, della terra e degli inferi.
E tutto mette la propria energia
a servizio del tuo spazio divino
e da esso tutto è pervaso con potenza.
Tu non distruggi le cose e neppure le forzi:
le liberi, le orienti, le trasfiguri, le animi.
Non le abbandoni, ma ti appoggi su di loro,
e avanzi trascinando con te ciò che in loro è santo.
Donaci la purezza di cuore, la fede, la fedeltà,
perché con questi doni si costruisce la nuova terra,
e si vince il mondo in Gesù Cristo,
nostro Signore.
Amen
T. De Chardin

O sì, Signore la mia opera sarà salvata, a motivo d'una pretesa che Tu stesso hai posto al centro della mia volontà! Voglio, ho bisogno che lo sia. Lo voglio perché amo irresistibilmente ciò che il tuo ausilio permanente mi permette, ogni giorno, di realizzare. Questo pensiero, questo perfezionamento materiale, questa armonia, questa sfumatura particolare d'amore, questa squisita complessità d'un sorriso o d'uno sguardo, tutte queste bellezze nuove che appaiono per la prima volta, in me o attorno a me, sul volto umano della Terra, sono da me prediletti come figli, dei quali non posso credere che moriranno totalmente, nella loro carne. Se credessi che queste cose potrebbero appassire per sempre, avrei forse mai dato loro la vita? Mostra, o Signore, a tutti i tuoi fedeli come, in un senso reale e pieno, «le loro opere li seguono» nel tuo regno: opera sequuntur illos.
Oh! venga il tempo in cui gli Uomini, diventati coscienti dello stretto legame che associa tutti i movimenti di questo Mondo nell'unica opera dell'Incarnazione, non potranno più dedicarsi ad alcun compito senza illuminarlo con la prospettiva precisa che il loro lavoro, per quanto elementare sia, è raccolto e utilizzato da un Centro divino dell'Universo!

Il 10 aprile 1955, al tramonto di una radiosa domenica di Pasqua, moriva a New York padre Pierre Teilhard de Chardin. Aveva da poco redatto ll Cristico, per riaffermare un’ultima volta la visione di un universo convergente in Cristo-Omega e la fede in un Cristianesimo capace di rinnovare il suo straordinario potere di 'panamorizzazione', a beneficio dell’unità del mondo. Alla fine della vita, che presentiva prossima, si era tuttavia reso conto della propria solitudine intellettuale, dell’impossibilità di trasmettere tutto ciò che aveva 'visto', tanto da «non poter citare un solo autore, un solo scritto» che condividesse la 'Diafania' per mezzo della quale il mondo gli appariva meravigliosamente trasfigurato. In una lettera indirizzata a padre Ravier due giorni prima di morire, affermava di essere dolorosamente sorpreso e deluso per aver constatato che i suoi più intimi amici «pensano e pregano ancora in un 'Cosmo' statico, anziché in 'Cosmogenesi'». Eppure fin da principio, quando assieme a loro studiava teologia ad Hastings, li aveva resi partecipi della sua visione, colta come in un lampo che illumina il cielo notturno: «La coscienza d’una Deriva profonda, ontologica, totale dell’Universo». Esiste un’importante relazione di Teilhard de Chardin su L’Homme, devant les enseigne- ments de l’Église et devant la philosophie spritualiste (è del 1911, anno della sua ordinazione sacerdotale), che contrassegna quella repentina presa di coscienza: è un documento inspiegabilmente omesso dai curatori delle opere postume e leggibile soltanto in internet. Esso dimostra che le sue principali idee erano già presenti nella grande intuizione iniziale: non si trattò di un semplice cambiamento di opinione, quanto piuttosto di una radicale modifica del suo stato di coscienza, capace di inglobare in sé il corso dell’intera evoluzione e la grandezza cosmica del Cristo Risorto. Tale stato di coscienza rappresenta una dimensione interiore molto difficile da trasmettere a parole: esige invece, metaforicamente, che le foglie più esterne e recenti di ogni quercia diventino esse stesse consapevoli dei rami e del tronco che le sorreggono, delle radici che le alimentano e del Sole che dà loro energia... Jean Gebser ha definito «integrale » questo nuovo stato di coscienza, verso cui sta lentamente evolvendo l’uomo moderno. Dopo il 1955, gli scritti postumi di Teilhard (gli stessi che aveva redatto per i suoi molti amici, scienziati e religiosi) sono stati raccolti in tredici volumi. In Italia, sono apparsi nel corso di 36 anni, fra il 1968 e il 2004, in ordine non cronologico, alcuni non più in commercio. Queste brevi considerazioni sono più che sufficienti per affermare che, stando così le cose, non è affatto agevole cogliere l’intero pensiero teilhardiano. Quantunque certi aspetti spirituali e cristologici della sua visione siano stati recepiti dalla cultura cattolica, riteniamo che Teilhard de Chardin avvertirebbe anche oggi di sentirsi alquanto solo, per il nostro modo riduttivo d’intendere e interpretare l’evoluzione. Per Teilhard, l’evoluzione include tutti i fenomeni di trasformazione della materia a partire da un atomo primigenio (postulato nel 1927 dal sacerdote cattolico George Lemaître) sino all’unificazione dell’umanità nel Punto Omega. Benché sia noto che dopo il Big bang, in virtù di 'leggi' presenti ab origine nel fenomeno stesso (come ad esempio l’equivalenza energiamassa, espressa da Einstein nella famosa formula E=mc²) siano apparse, in successione, le particelle subatomiche, i protoni, i neutroni, l’idrogeno, l’elio e, più tardi, le prime stelle, in cui si sono formati gli elementi atomici sino al ferro, ecc., tuttavia i dibattiti sull’evoluzione si sviluppano quasi esclusivamente attorno alla materia organica, in modo slegato dall’evoluzione della materia inorganica. Nessuno nega, naturalmente, che ogni evento evolutivo sia stato in qualche modo condizionato dai precedenti e abbia influito su quelli successivi, ma di fatto sembra che sussista un restringimento visivo, se non di 'coscienza del Tutto'. Peraltro la scienza moderna riconosce che la realtà non è fatta di 'cose', ma di 'relazioni', che il senso costruttivo dell’evoluzione, dal Big Bang in poi, è segnato da livelli crescenti di complessificazione, proprio come Teilhard aveva sostenuto, senza essere allora compreso, perché in anticipo di alcune decine d’anni rispetto alla 'teoria generale dei sistemi'. Egli infatti ha per primo rilevato che accanto al processo («in discesa») di disorganizzazione per Entropia, tutta l’evoluzione, inorganica e organica, è attraversata da un ostinato e faticoso processo di organizzazione («in salita») che «fa nascere, per 'corpuscolarizzazione' graduale dell’Energia cosmica, l’infinita varietà degli atomi, molecole, cellule viventi, ecc.» sino alla futura unificazione dell’umanità! Senza dubbio l’evoluzione antropo-sociologica, come prolungamento dell’evoluzione fisico-chimica e biologica, rappresenta la parte più peculiare della visione di Teilhard, ma è anche quella meno considerata e approfondita. Il Passato evolutivo lo aveva soprattutto interessato per spingere lo sguardo verso l’avanti, in vista di una «superumanità» che potrebbe realizzarsi mediante la «simpatia interumana e le forze religiose». La previsione di un futuro così lontano ha probabilmente ridotto l’interesse degli studiosi per i moltissimi scritti che Teilhard ha dedicato al futuro dell’uomo, oppure sono sembrate irrealistiche certe drammatiche previsioni, come questa del 1931: «L’età delle nazioni è passata. Se non vogliamo perire, si tratta ora per noi di rigettare i vecchi pregiudizi e di costruire laTerra». A sessant’anni dalla scomparsa di Teilhard de Chardin, sembra opportuno dedicare molta più attenzione ai numerosi suoi scritti riguardanti la Noosfera, da lui profetizzata nel 1925. Il futuro dell’umanità non è affatto privi di rischi e, dunque, «la costruzione della Noosfera – come egli ha sottolineato – non potrebbe essere semplicemente istintiva e passiva. Ma aspetta da noi una collaborazione attiva e diretta, uno slancio vigoroso fatto di convinzione e di speranza».

Nel ricordo di Henri de Lubac, Teilhard appare come un grande religioso, un credente molto solido e un vero figlio della Chiesa Cattolica, entro la quale ha voluto infatti restare sino all'ultimo giorno della sua vita.
Non fu sempre in linea con l'insegnamento del magistero ma è stato sempre fedele ai dogmi, anche a quelli del peccato originale e dell'inferno. A proposito di quest'ultimo, ad esempio, ha trovato il modo di «spiegarlo» come una realtà che «per la sua stessa esistenza aggiunge al cosmo una gravita, un rilievo che, senza di esso non esisterebbero». Tutt'altro quindi che un semplicistico ottimismo di stampo naturalistico.
Come abbiamo sopra accennato, tutto il pensiero teilhardiano è dominato dalla tensione a un'unità cosmica e dalla preoccupazione di arrivare a Dio attraverso il mondo. Un mondo visto come ambiente divino (Le milieu divin è una sua opera fondamentale), dove quel fenomeno straordinario che è l'uomo (Le phénomène humain, altra grande opera) lavora per portare tutto verso il compimento che è il Cristo totale. Si tratta di una visione grandiosa e affascinante, retta, per dirla con Wildiers, sulla tensione dialettica tra il Senso cosmico e il Senso cristico; dove tutta l'evoluzione porta l'universo a convergere verso il punto Omega, cioè Cristo stesso.
I motivi delle perplessità da parte dei teologi sono legati essenzialmente ai criteri di verifica delle sue affermazioni. Che cosa può fondare la cristicità dell'universo e la convergenza a Cristo? Nel pensiero teilhardiano pare quasi che tali realtà siano in qualche modo insite e rintracciabili nella fenomenologia e confermabili con il procedimento scientifico: mentre è solo sul metodo della fede e non sulla fenomenologia né sul metodo sperimentale che può basarsi una verifica personale delle verità rivelate.
Anche la visione mistica, espressa particolarmente ne L'ambiente divino, si muove in una direzione differente da quella della grande tradizione mistica cristiana. In questa, la natura non è che una delle possibili manifestazioni dello spirito e questo è potenza creatrice incondizionata, in grado di fermentare qualsiasi sostanza in qualsiasi tempo.
In Teilhard invece sembra esserci una identificazione dello spirito col divenire delle forme che incontriamo nella storia evolutiva dell'universo; come pure la potenza spirituale della materia è un «fermento che trasforma la natura ma non potrebbe privarsi della materia che la natura le offre». C'è quindi il rischio di qualche equivoco e riaffiora, come dice Cappelletti, un possibile naturalismo: «purificato da scorie edonistiche ma tuttavia consistente, come ogni altro, nell'impostazione del divenire all'essere, del fenomeno all'idea, del contingente all'assoluto».
Al di là di puntualizzazioni come queste (e altre più specifiche se ne potrebbero fare), la figura di Teilhard de Chardin resta per tutti una grande testimonianza di cristiano in azione.
Negli anni '50 le sue posizioni, pur se in modo conflittuale, hanno avuto un ruolo importante per far decantare il pensiero cristiano e favorire, come egli auspicava, «l'abbattimento della barriera che, da quattro secoli, non aveva smesso di salire fra Ragione e Fede».
Oggi siamo in un contesto abbastanza diverso: dominato da un diffuso materialismo ma anche colpito dalla crisi ecologica e pervaso da una rinnovata attenzione per l'ambiente. Di fronte ad esso sta una cristianità minata dal tarlo della secolarizzazione e timida nel proporre tutta la positività del suo annuncio. La testimonianza di Teilhard può aiutare a disegnare un tipo d'uomo credente e totalmente presente nel suo tempo: non uno che « ama la terra per goderne» ma per « renderla più pura » ; non uno che «aderisce al mondo» ma uno che «pre-aderisce a Dio» e con ciò trionfa sul mondo; non uno che ritiene l'uomo capace di «divinizzarsi chiudendosi in sé», sulla scia del misticismo orientale, ma uno che vede il massimo della persona-lizzazione nella adesione a Cristo.
Jacques Maritain..rivivificare in Cristo

Tutto è canto e poesia...il cuore del suo pensiero
Jacques Maritain
Nulla è perduto di ciò che è stato fatto, tutto è canto e poesia
Per l'uomo e per la vita umana non c'è in verità nulla di più grande dell'intuizione e dell'amore.“
Il religioso perfetto prega così bene che ignora di pregare.
Il Vangelo dell'amore di Dio per l'uomo, il Vangelo della dignità della persona e il Vangelo della vita sono un unico e indivisibile Vangelo. È per questo che l'uomo, l'uomo vivente, costituisce la prima e fondamentale via della Chiesa.
la Chiesa ha insegnato agli uomini ad essere liberi. Oggi forze cieche che da duecento anni le hanno dato l'assalto in nome della libertà e in nome della persona umana deificata, lasciano infine cadere la maschera. Ora si presentano per quello che sono. La loro sete e asservire l'uomo. I tempi attuali, per miserevoli che siano, hanno di che esaltare coloro che amano la Chiesa e amano la libertà. La situazione storica da essi affrontata è definitivamente chiara. Il grande dramma del nostro tempo è il confronto tra uomo e lo Stato totalitario, il quale non è altro che il vecchio e bugiardo dio dell'impero senza legge che esigeva per sé l'adorazione di tutte le cose, La causa della libertà e della Chiesa si incontrano nella difesa dell'uomo.
Il compito principale dell'educazione è soprattutto quello di formare l'uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per mezzo del quale l'uomo forma se stesso ad essere un uomo.
L'educazione dell'uomo è un risveglio umano.
Coloro che credono di non credere in Dio, in realtà poi credono inconsciamente in Lui, perché il Dio di cui negano l'esistenza non è Dio, ma qualcos'altro.

MESSAGGERI DI DIO SULLE VIE DEL MONDO
I coniugi Jacques e Raïssa Maritain
(dal bimestrale di Teologia e di Pastorale eucaristica “La Nuova Alleanza”, gennaio-febbraio 2012)
Jacques Maritain nacque a Parigi il 18 novembre 1882 da una famiglia protestante. Il padre Paul era
avvocato, la madre Geneviève era figlia di Jules Favre, deputato repubblicano, tenace oppositore di Luigi
Napoleone. Jacques frequentò il liceo con vivace intelligenza. Ben presto comprese la necessità di una
educazione capace di mettere a contatto l’intelligenza con il reale mediante la bellezza. Alla Sorbona si
laureò in filosofia e poi in scienze naturali.
In questo periodo conobbe Raïssa Oumancoff, nata a Rostov sul Don in Ucraina nel 1883. La sua
famiglia, dopo alcuni mesi di peripezie, si trasferì nella grande Parigi cosmopolita della fine secolo.
L’ambientamento nella nuova realtà si presentò subito difficile; tuttavia, nonostante i disagi iniziali, Raïssa,
ancora preadolescente, rivelò a scuola una notevole lucidità intellettuale affermandosi rapidamente per le sue
doti singolari e la decisa propensione allo studio. Conobbe ben presto la poesia e la filosofia. L’esperienza di
Parigi significò anche il distacco dal caldo mondo dell’ebraismo ortodosso, praticato soprattutto dagli anziani
della famiglia.
Si aprì una fase di relativismo e di oscurità sul problema di Dio, che caratterizzò la sua esistenza fino
al momento della progressiva conversione alla fede cattolica. Dopo aver conosciuto Jacques, con lui
condivise la crisi intellettuale dovuta alla insoddisfazione dei corsi universitari che, impregnati di scientismo,
irridevano al bisogno dei giovani di trovare la verità. Raïssa, di famiglia ebrea, e Jacques, di famiglia
protestante, a vent’anni diventarono atei e anarchici. Raïssa ai corsi di scienze della Sorbona, frequentava i
giovani anarchici russi, emigrati a Parigi. Così ricordava quegli anni:
“Riflettendo sul male e sul dolore, mi domandai come un Dio onnipotente e buono potesse
permetterne l’esistenza e, abbandonata alle mie sole forze, ho risolto il problema cessando di
credere. La vita mi apparve allora assolutamente vuota e triste ma, persuasa che essa avesse
un senso, non cessai di cercarlo… Piuttosto giovane, credevo a ciò che si diceva intorno a me:
che l’ignoranza, il fanatismo stessero dalla parte della religione, che la ragione stesse dalla
parte della scienza”.
La disperazione era in agguato. Raïssa intuiva, comunque, che senza la verità su Dio, su se stessi e
sul mondo, la vita era assurda. I due giovani, fortemente insoddisfatti, giunsero persino a pensare all’ipotesi
del suicidio; ma dopo aver riflettuto, decisero di dare ancora credito alla vita, nella speranza di poter
approdare alla verità. Si sposarono in Municipio. Il loro incontro divenne un programma di vita. Scrisse
Raïssa:
“Bisognava ripensare insieme l’universo intero, il senso della vita, la sorte degli uomini, la
giustizia e l’ingiustizia della società. Bisognava leggere i poeti ed i romanzieri
contemporanei, frequentare i concerti e visitare i musei… Il tempo passava in fretta, non
potevamo sprecarlo nelle banalità della vita”.
Jacques così descrisse quegli anni di studi universitari:
“La filosofia scientista e positivista dei miei maestri della Sorbona aveva finito per farmi
disperare della ragione. Per un momento avevo creduto di poter trovare la certezza integrale
nelle scienze. Molti pensavano che la mia fidanzata e io saremmo divenuti i discepoli del
materialismo. La cosa più bella per la quale devo ringraziare i miei studi di quell’epoca è
di avermi fatto incontrare, alla Facoltà di Scienza, quella che da allora ho avuto la fortuna di
avere accanto a me in tutti i miei lavori, in una perfetta e benedetta comunione”.
La prima conversione
Fu Charles Peguy a salvare i due giovani, portandoli ad ascoltare le lezioni di Henri Bergson sulla
mistica di Plotino. I Maritain non avevano in mente con chiarezza cosa andavano a cercare. Scrisse Jacques:
“Questa verità, ardentemente cercata, invincibilmente creduta, era ancora per noi una specie
di Dio sconosciuto; le riservavamo un altare nel nostro cuore, le riconoscevamo ogni diritto
su di noi, sulla nostra vita. Ma non sapevamo ciò che essa sarebbe stata, per quale via, con
quali mezzi poteva essere raggiunta”.
E’ allora che due giovani ricevettero risposta alla loro inquietudine intellettuale, apprendendo che è
possibile, per mezzo dell’intuizione, conoscere l’Assoluto, avere certezze sul senso della vita. Ma non era
ancora la fede. Dopo aver letto il romanzo “La donna povera” di Lèon Bloy, i due fecero amicizia con il
vecchio scrittore, il quale, con la sua testimonianza di un cattolicesimo radicale, li portò a credere in Cristo e
nella sua Chiesa.
Bloy scrisse a Raïssa:
“Ora voglio tentare di rispondere alla parte più grave della vostra lettera, dove dite “Io non
sono cristiana, non so che cosa cercare e mi lamento”. Perché continuate a cercare, amica
mia, poiché avete già trovato? Come potreste amare ciò che scrivo, se non pensaste, se non
sentiste come me? Voi non solo siete cristiana, Raïssa, siete cristiana ardente, figlia
amatissima del Padre” (25 agosto 1905).
I Maritain decisero di chiedere il sacramento del battesimo (l’11 giugno 1906) solo dopo aver
rinunciato all’idea di trovare la verità e la felicità intellettuale nella filosofia proposta all’epoca. Grazie alla
lettura dei mistici, compresero che ciò che si sa di Dio è nulla rispetto a ciò che non si conosce di Lui. E’ la
via della teologia apofatica, la teologia del “silenzio”.
La loro conversione ebbe anche una connotazione mariana. Bloy, infatti, li iniziò alla devozione a
Notre Dame de La Salette, convinto della realtà dell’apparizione di Maria nel 1846. Durante il viaggio a
Grenoble per ricevere la cresima, i Maritain salirono in pellegrinaggio al santuario dove si fermarono per
dieci giorni. La sede di verità dei Maritain venne saziata non dallo studio, ma dall’amore per la verità che
dona la saggezza, l’amore perfetto che dona la libertà perfetta. Per i Maritain, il momento del battesimo,
avvio della vita cristiana, ha significato “iniziare a realizzare la loro vocazione alla santità”.
Raïssa scrisse sul suo diario circa la conversione:
“Ogni convertito sperimenta la caduta di Paolo sulla via di Damasco. Il convertito si separa
dal mondo con un duro colpo che gli strappa il legame con se stesso e con gli altri. In un
istante, nel momento di grazia, tutti i valori si inclinano verso di Lui”.
Questa testimonianza evidenzia psicologicamente l’ansia soggettiva di verità che animava i due
giovani: “Vi era in noi questa idea invincibile della verità, questa porta aperta sul cammino della vita”.
La seconda conversione
Nella vita dei due ci fu poi una seconda conversione, importante come e più della prima. Entrambi
laureati in scienze biologiche alla Sorbona, grazie a Bergson si erano già allontanati dallo scientismo
materialistico. Il domenicano H. Clérissac propose a Raïssa di leggere san Tommaso all’inizio del 1909. Così
ne scrisse lei stessa:
“Fu tremando di curiosità e timore che aprii per la prima volta la Summa Theologica. La
scolastica non era, secondo la reputazione corrente, un sepolcro di sottigliezze cadute in
polvere?... Dalle prime pagine compresi la vanità e la puerilità delle mie apprensioni. Tutto
qui era libertà dello spirito, purezza della fede, integrità dell’intelletto illuminato di scienza e
di genio… pregare, comprendere mi erano sola e stessa cosa, l’uno dava sete all’altro e mi
sentivo sempre dissetata”.
Così, l’avventura intellettuale di Raïssa ebbe una svolta decisiva dopo la lettura della Summa
Theologica di san Tommaso. Fu per lei una liberazione, un’inondazione di luce, la scoperta della sua patria.
Qui intuì che
“stabilire la ragione sulla fede… non era indebolirla, ma fortificarla, non asservirla ma
liberarla, non snaturarla ma ricondurla alla purezza della propria natura; come illuminare
colui che avanza a tentoni e che cammina nelle tenebre non è condurlo fuori della propria
strada, ma fargli vedere la via dove si propone di camminare”.
Raïssa si convinse dunque che “una sola forza può ancora opporsi alla follia generale:
l’intelligenza illuminata dalla fede”. Soltanto questa intelligenza - era il suo convincimento - sarebbe stata in
grado di preservare l’umanità dal nichilismo, dallo scetticismo e dall’idolatria, insomma dalle “forze
mostruose” che trascinano il mondo.
Da allora, i due Maritain (insieme a Vera, sorella di Raïssa: una comunanza di vita e di pensiero che
durerà tutta la vita) si impegnarono non solo a diffondere la filosofia di san Tommaso, ma di approfondirla in
tutti i campi del sapere: dalla teologia alla politica, dalla pedagogia al diritto. La conversione al cattolicesimo
condusse Raïssa e il marito Jacques su strade nuove, ricche di scoperte, di esperienze e di impegni, percorse
insieme. L’ispirazione di fondo delle loro scelte era chiara:
“Dobbiamo essere come religiosi di un ordine speciale, la cui regola contempla la vita nel
mondo. Bisogna, per così dire, ingannare il mondo, avendo l’aria di condurre la vita del
mondo. Dobbiamo seguire la via della contemplazione nel mondo”.
Jacques e Raïssa: un comune laboratorio di vita e di fede
Il cammino di fede e lo stile di vita dei due Maritain è ben sintetizzato in un passo del testo famoso
di Jacques, “Umanesimo integrale”:
“Io non agisco in quanto cristiano, ma devo agire da cristiano, impegnando solo me, non
la Chiesa, ma impegnandomi tutto intero, e non amputato o disanimato – impegnando solo me
stesso che sono cristiano, che sono nel mondo e lavoro nel mondo senza essere del mondo, che
per la mia fede, il mio battesimo e la mia cresima, e per piccolo che sia, ho la vocazione di
infondere nel mondo, là dove io sono, una linfa cristiana”.
La linfa che i due Maritain infusero nella realtà può essere evidenziata in alcune tematiche specifiche
della loro esistenza.
a) Fede e cultura
Jacques e Raïssa ebbero un pensiero comune, però tradotto con due diversi linguaggi. Nel rispetto
delle tappe del cammino verso Dio di ciascuna persona, entrambi gli sposi avevano un sentimento forte della
sacralità e del primato della coscienza, che li spingeva oltre le barriere e li avvicinava alla sensibilità
contemporanea.
“In un certo senso Raïssa ha detto tutto nelle sue poesie”, scriveva ad esempio Jacques della moglie,
e lei di lui: “Egli ha creato una filosofia politica, la sola fatta per lottare contro quella di Machiavelli,
universalmente seguita sino al presente dagli uomini di Stato”.
Jacques era consapevole di essere rispettato e supportato da Raïssa, nel suo lavoro, tanto che così
scriveva nel presentare il “Diario” di Raïssa, pubblicato postumo nel 1963:
“Al di sopra di tutto c’era una sollecitudine nei riguardi del mio lavoro filosofico. Nonostante
tutte le pene morali e fisiche e, in alcuni momenti, una quasi completa mancanza di forze, è
riuscita con uno scatto di volontà. E perché la collaborazione che le ho sempre domandato
era per lei un dovere sacro, è possibile rileggere sul manoscritto tutto quello che ho
pubblicato”.
b) Castità e libertà
Dopo sei anni di matrimonio, nel 1912 i due giovani sposi maturarono la decisione di pronunciare un
voto di castità. Questo voto, sconosciuto anche agli amici più intimi, fu la radice nascosta di tutte le attività
culturali, politiche e spirituali che promossero in seguito, ma non una rinuncia. Jacques scrisse:
“Non dico che sia stata una decisione facile da prendere. Essa non comportava nemmeno
l’ombra di un disprezzo per la natura, ma nella nostra corsa verso l’Assoluto e nel nostro
desiderio di seguire a qualunque costo, pur restando nel mondo, almeno uno dei consigli della
vita perfetta, noi volevamo fare spazio per la ricerca della contemplazione e dell’unione con
Dio e vendere per questa perla preziosa beni in loro stessi eccellenti. La speranza di un tale
scopo ci dava le ali.
Noi presentivamo anche, ed è stata una delle grandi grazie della nostra vita, che la forza
e la profondità del nostro mutuo amore sarebbero state accresciute come all’infinito”.
Jacques e Raïssa hanno tenuto fede ad un cammino che si arricchiva col trascorrere del tempo, mutando man
mano le modalità della comunicazione interpersonale, fino a sentire di comune accordo che la loro unità
poteva reggere e continuare a crescere al di là del contatto fisico.
c) Fiducia e stima reciproca
Tutto è stato fatto insieme dai due Maritain, perché insieme sono stati convinti di quando andavano
facendo e vivendo: anzitutto, nella ricerca della verità, e, poi, nella lotta al male. La personalità di Jacques si
andava stagliando all’esterno come la manifestazione filosofica splendidamente visibile di quello stesso
pensiero di cui Raïssa era la radice e l’anima. Non c’era tra loro alcun sentimento di gelosia, di
rivendicazione di titolarità delle opere. Da questa consapevolezza di vivere in un comune laboratorio di
ricerca, scaturiva l’apprezzamento di ciascuno per il lavoro dell’altro.
Grazie a Raïssa, Jacques poté formulare una insolita - per l’epoca - stima del genere femminile, che
era come un’estensione di quella che Jacques provava per Raïssa. Di lei, ad esempio, scrisse: “Raïssa è
sempre vissuta per la verità, non ha mai resistito alla verità. Il suo spirito non ha mai fatto una grinza”. E
lei di lui: “La sua tenerezza per me è scioccante, la sua sollecitudine è senza limiti”.
d) Contemplazione e azione
Raïssa e Jacques hanno camminato radicalmente verso la santità, vissuta attraverso la ricerca della
verità, l’amore coniugale, la contemplazione dell’Assoluto. Bisogna leggere le poesie di Raïssa per poter
entrare nell’intimità di questa avventura meravigliosa, dove lei ha saputo raccordare esperienza mistica ed
esperienza poetica, religione e cultura.
Osservando il loro impegno di animazione della realtà temporale, di primo acchito non ci si
immagina di avere a che fare con due persone votate alla mistica. E proprio a proposito della contemplazione
e dell’accessibilità della vita di preghiera, sarebbe interessante approfondire quel breve lavoro a quattro mani
di Jacques e Raïssa che è “Liturgia e contemplazione” (Borla, 1960).
La stessa scelta del filosofo di ritirarsi presso i Piccoli Fratelli di Gesù a Tolosa, dopo la morte della moglie,
è indice di quanto grande fosse la tensione verso la vita contemplativa. Azione e contemplazione si nutrivano
della speranza cristiana.
Pieno di speranza è stato l’ultimo messaggio di Jacques:
“Verrà un giorno in cui questa grande patria, che è il mondo, ritroverà in buona parte, in
mezzo a mali anch’essi nuovi, secondo la legge della storia del mondo, il fine vero per cui è
stata creata; un giorno in cui una nuova civiltà darà agli uomini, non certo la felicità perfetta,
ma un ordinamento più degno di loro e li renderà più felici sulla terra. Poiché io penso che la
meravigliosa pazienza di Dio non sia ancora esaurita, e che il giudizio finale non avverrà
domani”.
Luigi Guglielmoni - Fausto Negri

Jacques Maritain e la sete di verità
«In fondo tutta l'opera di Maritain è direttamente o indirettamente una rivendicazione a favore della filosofia, una lunga e appassionata apologia della filosofia, e di colpo anche una probante “dimostrazione di filosofia”, che liberamente si afferma per il semplice fatto di vivere e di esistere nella sua opera» Così scrive Vittorio Possenti filosofo dell’Università Cà Foscari nel 1976 sulla Rivista Vita e Pensiero a proposito di Jacques Maritain (Jacques Maritain o la difesa della filosofia: «Approches sans entraves»). E davvero tra le righe dei 60 (e più) libri pubblicati, così come dietro il suo pensiero filosofico, nelle fratture che hanno determinato le sue numerose “conversioni”, possiamo leggere la storia della sua vita.
Jacques Maritain nasce a Parigi nel 1882, in una famiglia protestante, figlio di un avvocato, Paul Maritain e di Geneviève Favre (figlia del politico Jules Favre). Dopo aver frequentato il liceo Henri-IV, inizia a studiare alla Sorbona dove si laurea dapprima in filosofia e poi in scienze naturali. Qui, tra i corridoi dell’Università, incontra Raïssa Oumançoff, immigrata russa di origine ebraica, che diventerà sua moglie. Nel romanzo autobiografico I grandi amici Raissa ricorda il loro primo incontro: «Divenimmo presto inseparabili. [..] Non esisteva niente al difuori di ciò che dovevamo dirci: bisognava ripensare insieme l’universo intero, il senso della vita, la sorte degli uomini, la giustizia e l’ingiustizia delle società. Bisognava leggere i poeti e i romanzieri contemporanei, frequentare i concerti classici, visitare musei di pittura… il tempo passava troppo in fretta e non potevamo sprecarlo nelle banalità della vita. Per la prima volta potevo veramente parlare di me, uscire dalle mie riflessioni silenziose per comunicarle, dire i miei tormenti. Per la prima volta incontravo qualcuno che mi ispirava di colpo una confidenza assoluta; qualcuno che, lo sapevo già da allora, non mi avrebbe mai delusa; qualcuno con cui, su tutte le cose, potevo così ben armonizzare. Un altro Qualcuno aveva prestabilito fra noi, malgrado così grandi differenze di temperamento e di origine, una sovrana armonia».
Inizia così un profondo sodalizio spirituale e intellettuale tra i due, un’avventura di amore e conoscenza mossa da una comune sete di verità che non riesce a trovare risposta nelle lezioni dei docenti della Sorbona imbevuti di relativismo e scetticismo: «Avevamo appena esaminato ciò che ci avevano portato due o tre anni di studio alla Sorbona; senza dubbio un bagaglio abbastanza importante di conoscenze particolari scientifiche e filosofiche, ma quelle conoscenze erano minate alla loro base dal relativismo degli scienziati, dallo scetticismo dei filosofi. Noi non appartenevamo affatto, con i nostri scarsi vent’anni, al gruppo dei seguaci dello scetticismo, che lanciano il loro “che ne so io?” come il fumo di una sigaretta e trovano d’altra parte la vita eccellente. Eravamo, con tutta la nostra generazione, le loro vittime. […] Quest’angoscia metafisica che penetra alle sorgenti stesse del desiderio di vivere, è capace di divenire una disperazione totale e di sfociare nel suicidio. […] È un’angoscia di questa specie che ho vissuto allora; ma essa fu guarita, che mi è difficile, dopo tanta dolcezza e felicità, risentirla nuovamente in tutta la sua amarezza. Senza dubbio altre angosce sono venute, altri dolori, spesso immensi; ma quell’angoscia lì non l’ho più conosciuta. Tuttavia non l’ho dimenticata: non si dimenticano le porte della morte. […]»
Sarà Henri Bergson a strappare Raissa e Jacques dalle angosce del dubbio e della disperazione che li aveva portati alle soglie del suicidio. Bergson in quegli anni (siamo nel 1901-1902) insegna filosofia al Collège de France, nell’edificio a fronte della Sorbona. Un giorno l’amico Charles de Péguy decise di portarli ad ascoltare le sue affollatissime lezioni. I due ne rimasero affascinati. Come scrive Piero Viotto, che fu docente di pedagogia dell’Università Cattolica e uno dei massimi studiosi del filosofo francese, «Bergson, spiegando Platino, fornì loro la chiave per comprendere la possibilità di conoscere la verità, di sperimentare la libertà e di contemplare l'Assoluto» (Bergson secondo Raissa Maritain in Vita e Pensiero 1997-10). Tuttavia, benché affascinati dagli aspetti metafisici dalla ricerca psicologica di Bergson, Jacques Maritain e Raissa divennero ben presto consapevoli della debole fondazione filosofica del pensiero bergsoniano e cominciarono a preoccuparsi dalle conseguenze che i suoi discepoli traevano dalle sue dottrine.
Nel 1904, dopo due anni di fidanzamento decidono di sposarsi, mentre Jacques sta ancora completando gli studi. Di lì a poco la loro vita subirà una nuova svolta. Il 25 giugno 1905, i coniugi Maritain salgono le scalinate che portano alla Basilica del Sacré-Coeur di Parigi alla ricerca di «uno strano “mendicante” che, disprezzando qualsiasi filosofia, vociferava sopra i tetti la verità divina». Quel “mendicante ingrato” era lo scrittore Léon Bloy. Da quell'incontro «cominciò il loro cammino verso il Battesimo, e iniziò pel futuro filosofo lo studio della Verità cristiana di cui egli è nel nostro tempo uno dei più alti, autorevoli, ascoltati assertori» (Francesco Casnati, Bloy, Maritain e l'umanesimo integrale in Vita e Pensiero 1968 - 2).
Durante la lunga convalescenza di Raissa per un ascesso retrofaringeo, il domenicano Humbert Clérissac, consigliere spirituale dei Maritain, la invita a leggere la Summa Theologica di San Tommaso d'Aquino. L’entusiasmo nella lettura contagia il marito, che vede in San Tommaso la conferma di molte sue idee. I due «comprendono che si può giungere all'Assoluto non solo con la fede ma anche con l'intelletto e l'uso corretto della ragione». Scrive Maritain: «Fu dopo la conversione al cattolicesimo che conobbi S. Tommaso; io, che ero passato con tanto entusiasmo attraverso tutte le dottrine dei filosofi moderni e non vi avevo trovato che delusione e grandiose incertezze, provai allora come un'illuminazione della ragione; la mia vocazione filosofica mi veniva restituita in tutta la sua pienezza».
La scoperta della filosofia di San Tommaso mette in crisi la fedeltà a Bergson ma non cancella l’influenza profonda del primo maestro di spiritualismo. Il tomismo, secondo Maritain, è una filosofia progressiva, capace di inglobare nel suo cammino tutte le verità che implicitamente sono presenti nei diversi sistemi filosofici, che si succedono nella storia della cultura e della società. È ciò che emerge dalla raccolta antologica Ragione e ragioni, una serie di testi che coprono tutto l'arco della ricerca filosofica maritatiana, dalla metafisica alla morale, dall'estetica alla politica, dalla teologia alla filosofia della storia. Lo stesso Jacques nel saggio Da Bergson a Tommaso d'Aquino, riconoscendo i rapporti tra le due filosofie, scrive: «Non dico queste cose con non so quale ridicola pretesa di annettere Bergson al tomismo, ma perché egli stesso pensava che io non avevo avuto torto di dire che la sua filosofia conteneva alcune virtualità non ancora sviluppate; e perché è accaduto che, alla fine, ci siamo ritrovati in un certo modo tutti e due nel mezzo della strada, ciascuno avendo camminato senza accorgersene in maniera di avvicinarsi all'altro: lui, verso coloro che, soli, rappresentano, senza tradirla, la fede a cui io appartengo; io, verso la comprensione un po' meno insufficiente dell'umano lavoro di coloro che cercano senza avere ancora trovato». In Theonas. dialoghi tra un sapiente e due filosofi su argomenti di diversa attualità, un volumetto scritto in forma di dialogo, Maritain chiarisce la differenza rappresentata dal pensiero di San Tommaso: «il tomismo non rifiuta gli apporti della filosofia contemporanea, ma vuole garantire l'autenticità del discorso filosofico che si differenzia dalla metodologia delle scienze matematiche e delle scienze sociali, perché si muove a livello della intelligibilità dell'essere ed ha per oggetto non la misura di ciò che cambia, ma la contemplazione di ciò che permane».
«Deciso di fare della filosofia di Aristotele e di San Tommaso il centro del suo insegnamento», nel 1912 Jacques Maritain inizia la propria attività di docente, prima al Collegio Stanislao, poi all'Istituto cattolico di Parigi e al piccolo seminario di Versailles. Dal 1922 al 1939 la casa dei Maritain a Meudon diventa luogo di incontri culturali di filosofi, teologi, scrittori, poeti. Tra gli altri anche il filosofo e giornalista Étienne Borne che, in un’intervista pubblicata nel 1982 su Vita e Pensiero, ricorda così quelle domeniche di studio attorno ad un tema: «Meudon era un'altura dello spirito e un punto di incontri spesso insoliti, dove a volte si annodavano, per gli uni o per gli altri, i fili dei loro destini. […] Non era una torre d'avorio. Ci si teneva in ascolto dei problemi del mondo a una svolta decisiva del nostro secolo: la grande depressione che sembrava suonate a morto per il sistema capitalistico, l'ascesa dei fascismi e del nazismo, la condanna dell'«Action française» e, più in generale, la scoperta da parte della Chiesa del pericolo rappresentato da tutte le forme del paganesimo politico, il consolidamento all'Est, nel silenzio e nel mistero, del sistema comunista. Di fronte al fallimento e al declino delle idee o dei regimi tradizionali, e in primo luogo di quelle e di quelli che si credevano-liberali e progressisti, si trattava di creare degli strumenti intellettuali che permettessero di pensare la crisi nelle sue molteplici dimensioni e di aprire, malgrado gli avvenimenti apocalittici di cui si avvertiva l'approssimarsi, una breccia alla speranza». Nel 1936 Maritain pubblicherà la sua opera più famosa, Umanesimo integrale, il frutto più maturo di questo periodo di grande fermento intellettuale, che susciterà immediate polemiche ma che sarà poi il fondamento su cui si reggerà l'impianto del Concilio Vaticano II: gli importanti insegnamenti sulla Chiesa e il mondo, l’apostolato dei laici e la libertà religiosa recano indiscutibilmente il segno dell’umanesimo integrale di Maritain. Il discorso qui iniziato, la possibilità di una società liberale e democratica, cristianamente ispirata, proseguirà in Cristianesimo e democrazia. Nella prefazione all’edizione italiana del 1977, l’allora rettore dell’Università Cattolica, Giuseppe Lazzati scrive: «È a questa volontà di “pensare la politica” prima di “fare politica” che si offre questo saggio».
Tra il 1935 e il 1937 Jacques Maritain prende posizione contro l’invasione dell’Etiopia, il bombardamento di Guernica, la guerra di Spagna. A causa del nazismo i Maritain si trasferiscono negli Stati Uniti (1940-44) e a New York Jacques insegna nelle università di Princeton e della Columbia, tenendo conferenze in numerose città americane. Nel 1953 Jacques Maritain si ritrova al centro di una polemica dopo la pubblicazione dell’edizione italiana di L’uomo e lo Stato, in cui, diversamente dalle opere precedenti, insiste su un concetto più laico di democrazia come razionalizzazione etica della vita sociale. Le critiche, rivolte in particolare da padre Messineo su «La Civiltà Cattolica» erano forse attese, come si evince dalle lettere scambiate con il filosofo, che se in un primo momento chiede addirittura di bloccare la traduzione, poi vuole assicurarsi che esca. A proposito Guido Aceti risponde in un articolo del 1954 sulla rivista Vita e Pensiero: «non crediamo che compito del pensatore cattolico sia quello di una ripetizione di tesi note, bensì quello di rimeditare e completare queste tesi con la vivacità di una riflessione che se da un lato guarda alla perennità della tradizione, dall’altro non ha meno vivo il senso della presente contingenza storica» (L’uomo e lo Stato in Vita e Pensiero, 1954 - 4; Vita e Pensiero. Cento anni di editoria. Catalogo Storico 1918-2017). Oggi L’uomo e lo stato è considerato il suo capolavoro di filosofia politica, e, secondo il filosofo Paolo Nepi, «L'opera più organica e sistematica» dal punto di vista della riflessione politica maritainiana (La lezione di Maritain, in Vita e Pensiero 1980 - 9).
Nel 1956 esce I grandi amici di Raissa Maritain, felice biografia in cui compaiono i maestri dei due coniugi, da Bergson a Péguy, da Bloy a Georges Rouault (sulla corrispondenza tra Maritain e Rouault vedi anche il saggio di Giovanni Botta Jacques Maritain e Georges Rouault. Una corrispondenza tra estetica e poetica pubblicato nel 2016). Poco dopo, nel 1960, Raissa muore e Jacques decide di ritirarsi a Tolosa presso la Comunità dei Piccoli Fratelli di Gesù, dove rimarrà fino alla morte nel 1973.
Perché rileggerlo oggi? Forse la risposta migliore possono darla le parole della lettera che Papa Giovanni Paolo II nel 1982 ha indirizzato a Giuseppe Lazzati in occasione del Convegno Internazionale in onore del filosofo francese pubblicata sulla rivista Vita e Pensiero: Jacques Maritain, senza farsi illusioni sulle difficoltà del compito e su quanto fosse ancora lunga la strada da percorrere, era convinto del fatto che, se l'Umanesimo dell'Incarnazione deve ispirare il processo di civilizzazione, questo richiede necessariamente grande eroismo e coraggiose iniziative da parte dei cristiani. Molti degli aspetti di questo pensiero che anticipava i tempi divennero più tardi di dominio comune, quali la partecipazione attiva di tutti alla vita socio-politica; il senso acuto della giustizia in un mondo di vergognose sperequazioni; la solidarietà con i poveri, con gli emarginati, con i piccoli di questo mondo; reintegrazione delle masse. Egli era l'uomo del dialogo. Senza compromessi quando la verità era in causa, non fu mai partigiano nella difesa delle proprie idee, specialmente se esse erano opinabili. In questo senso, egli ha lanciato una sfida che merita di essere accolta da chiunque intenda essere leale servitore di una verità che non è sua, perché lo trascende. Verità da scoprire in una ricerca che è, al tempo, stesso, impegno di indagine seria dal punto di vista scientifico, e apertura al superiore apporto della rivelazione, davanti alla quale ci si deve porre in atteggiamento di fede e di amore. In ciò Maritain è stato veramente un maestro. Anche per questo il suo pensiero s'accorda esemplarmente col grande progetto del Magistero della Chiesa per l'era contemporanea: Tutto rivificare e rinnovare in Cristo, avvicinando la fede alla cultura e la cultura alla fede.
(a cura di Erica Crespi)
Raissa Maritain..contemplare l'Assoluto

Se la tua anima, o Poeta, non vive d’entusiasmo e d’amore,
di passione, di pietà, di comprensione,
nulla mi dànno le acrobazie delle tue abilità,
delle tue scaltrezze.

Dolcezza del mondo
Dolcezza del mondo! Fin dove sale e scende nel mio cuore la
tua musica! TI tuo incanto si dà per l'eternità.
Un'ora nel cuore della tua bellezza, un'ora terrestre e reale, -
beatitudine senza ricordo, presente senza futuro, nel tuo amore
impersonale.
Magie della primavera, giardino perenne delle delizie, il cielo è
limpido e terso, una luce dolce sembra discendere dal paradiso.
Rami fioriti delle acacie, degli aranci, dei roseti, dei lillà, -
profusione di piante, fecondità miracolosa del bosco.
Contempla il Bosco e l'Albero della Croce, che reca il suo
Fiore e il suo Frutto eterno!
Più dell'albero è fecondo il cuore, fa maturare il suo frutto nel
silenzio; grappolo sanguinante destinato al torchio.
Vascello fragile e di carne, universo segreto ed aperto, dove la
dolcezza del mondo affluisce con il sangue.
O soavità, pienezza, gioia! quali parole, quali grida vi potrebbero
esprimere?
Voi non parlate che coi battiti segreti di questo cuore che solo
gli angeli della musica possono decifrare e ripetere.
TI mio fervore ha percorso la terra e il cielo, ho creduto di
possedere tutto in quei momenti eterni.
Istanti felici, ora privilegiata che ha racchiuso in sé tutto l'amore
diffuso nel mondo.

Tu sei la Verità
- Tu sei la Sincerità,
Ma ogni uomo è bugiardo.
Ecco che tutto ciò che è in me
Il bene e il male, la menzogna e l'errore,
Ciò che so e ciò che ignoro,
Ti prega e ti scongiura e grida verso di Te!
Se cerco di conoscermi mi perdo nei miei pensieri
Tu solo conosci il nome vero del mio essere.
E se sia degno di odio o d'amore.
Che la tua pietà ci salvi con la grazia,
Tu che operi in noi il volere e l'agire
E che potresti di una pietra
Fare un figlio d'Abramo
Purifica, illumina la mia anima
E fa che sfugga alla potenza del nulla.
R. Maritain

La gloria di Dio
Il riposo è in te - Te che sei l'ineffabile
In te l'inconoscenza assorbe la pienezza
Battito invisibile ̶ sonno vivo
Nel cielo della tua notte domina la certezza
Sostanza impenetrabile ̶ Deità
Al nostro amore voi siete accessibile
Fedele Trinità

Le tre conversioni di Raissa
Il 4 novembre 1960 muore a Parigi un’ebrea russa, Raïssa Oumançoff, i cui libri sono tradotti anche a Tokyo; più conosciuta come moglie di Jacques Maritain, il filosofo con cui ha condiviso un’avventura spirituale, culturale e politica fin dalla giovinezza. Come ha scritto il loro biografo, Jean-Luc Barrè, la vita culturale del secolo ventesimo non ha fatto perno sulla coppia esistenzialista Jean-Paul Sartre e Simone De Beauvoir, ma proprio sulla coppia Maritain, che prima a Parigi, poi a New York, animava incontri culturali con filosofi come Berdiaeff, Gilson, Edith Stein, artisti come Rouault, Chagall, Severini, musicisti come Auric e Lourié; romanzieri come Bernanos, Claudel, Julien Green, Caroline Gordon, Flannery O’Connor, poeti come Cocteau, Reverdy, Max Jacob. Leggendo i suoi scritti autobiografici – I grandi amici e Diario –, possiamo seguirla in questa avventura.
Raïssa, di famiglia ebrea, e Jacques, di famiglia protestante, sui vent’anni diventano atei e anarchici, frequentano le università popolari, si sposano in municipio. Raïssa ricorda: «Riflettendo sul male e sul dolore, mi domandai come un Dio onnipotente e buono potesse permetterne l’esistenza e, abbandonata alle mie sole forze, ho risolto il problema cessando di credere. La vita mi apparve allora assolutamente vuota e triste, ma persuasa che essa avesse un senso non cessai di cercarlo… Piuttosto giovane, credevo a ciò che si diceva intorno a me, che l’ignoranza, il fanatismo stessero dalla parte della religione, che la ragione stesse dalla parte della scienza».
Raïssa si iscrive ai corsi di scienze della Sorbona e frequenta i giovani anarchici russi, emigrati a Parigi. All’università incontra Jacques, «un giovanotto dal viso buono con abbondanti capelli biondi e la barba leggera». L’incontro è subito un programma di vita: «Bisognava ripensare insieme l’universo intero, il senso della vita, la sorte degli uomini, la giustizia e l’ingiustizia della società. Bisognava leggere i poeti ed i romanzieri contemporanei, frequentare i concerti e visitare i musei… Il tempo passava in fretta, non potevamo sprecarlo nelle banalità della vita». Insoddisfatti, giungono alla soglia del suicidio; ma dopo avere riflettuto, decidono di dare ancora credito alla vita, nella speranza di poter approdare alla verità.
È Charles Péguy a salvare i due giovani portandoli ad ascoltare le lezioni di Henri Bergson sulla mistica di Plotino. I Maritain non sapevano cosa andavano a cercare: «Questa verità, ardentemente cercata, invincibilmente creduta, era ancora per noi una specie di Dio sconosciuto».
È allora che i due giovani ricevono risposta alla loro inquietudine intellettuale, apprendendo che è possibile, per mezzo dell’intuizione, conoscere l’Assoluto, avere certezze sul senso della vita. Ma non è ancora la fede.
Dopo aver letto il romanzo La donna povera di Léon Bloy, fanno amicizia con il vecchio scrittore il quale, con la sua testimonianza di un cattolicesimo radicale, li porta a credere in Cristo e nella sua Chiesa. Bloy scrive a Raïssa: «Ora voglio tentare di rispondere alla parte più grave della vostra lettera, dove dite: “Io non sono cristiana, non so che cosa cercare e mi lamento”. Perché continuate a cercare, amica mia, poiché avete già trovato? Come potreste amare ciò che scrivo, se non pensaste, se non sentiste come me? Voi non solo siete cristiana, Raïssa, siete cristiana ardente, figlia amatissima del Padre» (25 agosto 1905).
La conversione dei Maritain ha anche una connotazione mariana. Bloy li inizia alla devozione a Notre-Dame de La Salette, convinto della realtà dell’apparizione di Maria nel 1846.
Poi nella loro vita c’è una seconda conversione, altrettanto importante della prima. Entrambi laureati in scienze biologiche alla Sorbona, grazie a Bergson si erano già allontanati dallo scientismo materialistico. La scoperta della filosofia di san Tommaso fa loro comprendere che il bergsonismo risolve la verità in una intuizione soggettiva, negando all’intelligenza umana la capacità di raggiungere la verità nella sua oggettività. Il domenicano H. Clérissac propone a Raïssa di leggere san Tommaso all’inizio del 1909: «Fu tremando di curiosità e timore che aprii per la prima volta la Summa teologica. La scolastica non era, secondo la reputazione corrente, un sepolcro di sottigliezze cadute in polvere?… Dalle prime pagine compresi la vanità e la puerilità delle mie apprensioni. Tutto qui era libertà dello spirito, purezza della fede, integrità dell’intelletto illuminato di scienza e di genio… Pregare, comprendere mi erano una sola e stessa cosa, l’uno dava sete all’altro e mi sentivo sempre dissetata». Da allora i Maritain si impegnano non solo a diffondere la filosofia di san Tommaso, ma ad approfondirla in tutti i campi del sapere, dalla teologia alla politica, dalla pedagogia al diritto, anche perché comprendono che lo spiritualismo alla Bergson finisce solo per inclinare le coscienze verso il relativismo.
Dopo sei anni di matrimonio, nel 1912 i due giovani maturano la decisione di pronunciare un voto di castità. Questo voto, sconosciuto anche agli amici più intimi, è la radice nascosta di tutte le attività culturali, politiche e spirituali che promuoveranno in seguito, ma non una rinuncia alla coniugalità. Jacques scrive: «Abbiamo deciso di rinunciare a ciò che nel matrimonio non soddisfa solamente i bisogni profondi dell’essere umano, carne e spirito, ma è una cosa buona e legittima in sé stessa, ed abbiamo rinunciato nel medesimo tempo alla speranza di sopravvivere nei figli o nelle figlie. Non dico che sia stata una decisione facile da prendere. Essa non comportava nemmeno l’ombra di un disprezzo per la natura, ma nella nostra corsa verso l’Assoluto e nel nostro desiderio di seguire a qualunque costo, pur restando nel mondo, almeno uno dei consigli della vita perfetta, noi volevamo fare spazio per la ricerca della contemplazione e dell’unione con Dio e vendere per questa perla preziosa beni in loro stessi eccellenti. La speranza di un tale scopo ci dava le ali. Noi presentivamo, anche, ed è stata una delle grandi grazie della nostra vita, che la forza e la profondità del nostro mutuo amore sarebbero state accresciute come all’infinito». Non una scelta anticoniugale, quindi, ma un perfezionamento eroico della vita di coppia.
Quello di Raïssa (e di Jacques) è stato un cammino radicale verso la santità, vissuto attraverso la ricerca della verità, l’amore coniugale, la contemplazione dell’Assoluto. Bisogna leggere le poesie di Raïssa per potere entrare nell’intimità di questa avventura meravigliosa, dove lei ha saputo raccordare esperienza mistica e poetica, religione e cultura
Madeleine Delbrel..scintille del tuo volere!

LITURGIA LAICA..incaricati di respirare nella vita eterna
Tu ci hai condotto stanotte in questo bar che ha nome "chiaro di luna".
Volevi esserci Tu, in noi,
per qualche ora, stanotte. Tu hai voluto incontrare,
attraverso le nostre povere sembianze,
attraverso il nostro miope sguardo,
attraverso i nostri cuori che non sanno amare,
tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo.
E poiché i Tuoi occhi si svegliano nei nostri
E il tuo Cuore si apre nel nostro cuore,
noi sentiamo il nostro labile amore aprirsi in noi
come una rosa espansa,
approfondirsi come un rifugio immenso e dolce
per tutte queste persone,
la cui vita palpita intorno a noi.
Allora il bar non è più un luogo profano,
quell'angolo di mondo che sembrava voltarti le spalle.
Sappiamo che, per mezzo di Te, noi siamo diventati
la cerniera di carne,
la cerniera di grazia,
che lo costringe a ruotare su di sé ,
a orientarsi suo malgrado
e in piena notte
verso il Padre di ogni vita.
In noi si realizza il sacramento del Tuo amore.
Ci leghiamo a Te
Con tutta la forza della nostra fede oscura,
ci leghiamo a loro
con la forza di questo cuore che batte per Te,
Ti amiamo,
li amiamo,
perché si faccia di noi tutti una cosa sola.
In noi, attira tutto a Te…
Attira il vecchio pianista,
dimentico del posto in cui si trova,
che suona soltanto per la gioia di suonare;
la violinista che ci disprezza e offre in vendita
ogni colpo d'archetto,
il chitarrista e il filarmonicista
che fan della musica senza saperci amare.
Attira quest'uomo triste, che ci racconta storie cosiddette gaie.
Attira il bevitore che scende barcollando
la scala del primo piano;
attira questi esseri accasciati, isolati dietro un tavolo
e che son qui soltanto per non essere altrove;
attirali in noi perché incontrino Te,
Te cui solo è il diritto di aver pietà.
Dilataci il cuore, perché vi stiano tutti;
incidili in questo cuore,
perché vi rimangano scritti per sempre.
Tu fra poco ci condurrai
Sulla piazza ingombra di baracconi da fiera.
Sarà mezzanotte o più tardi.
Soli resteranno sul marciapiede
Quelli per cui la strada è il focolare,
quelli per cui la strada è la bottega.
Che i sussulti del Tuo cuore affondino i nostri
Più a fondo dei marciapiedi,
perché i loro tristi passi
camminino sul nostro amore
e il nostro amore
gl'impedisca di sprofondare più a fondo
nello spessore del male.
Resteranno, intorno alla piazza,
tutti i mercanti di illusioni,
venditori di false paure, di falsi sports,
di fase acrobazie, di false mostruosità.
Venderanno i loro falsi mezzi di uccidere la noia,
quella vera, che rende simili tutti i volti scuri.
Facci esultare nella Tua verità e sorridere loro
Un sorriso sincero di carità.
Più tardi saliremo sull'ultimo metrò.
Delle persone vi dormiranno.
Porteranno impresso su di sé
Un mistero di pena e di peccato.
Sulle banchine delle stazioni quasi deserte,
anziani operai,
deboli, disfatti, aspetteranno che i treni si fermino
per lavorare e riparare le vie sotterranee.
E i nostri cuori andranno sempre dilatandosi,
sempre più pesanti
del peso di molteplici incontri,
sempre più grevi del Tuo amore,
impastati di Te,
popolati dai nostri fratelli, gli uomini.
Perché il mondo
Non sempre è un ostacolo a pregare per il mondo.
Se certuni lo devono lasciare per trovarlo
E sollevarlo verso il cielo,
altri visi devono immergere
per levarsi
con lui
verso il medesimo cielo.
Nel cavo dei peccati del mondo
Tu fissi loro un appuntamento:
incollati al peccato,
con Te essi vivono
un cielo che li respinge e li attira.
Mentre Tu continui
A visitare in loro la nostra scura terra,
con Te essi scalano il cielo,
votati a un'assunzione pesante,
inguaiati nel fango, bruciati dal Tuo spirito,
legati a tutti,
legati a Te,
incaricati di respirare nella vita eterna,
come alberi con radici che affondano.

NOI DELLE STRADE
Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito,
ma c'è uno Spirito che soffia in tutti i luoghi.
C'è gente che Dio prende e mette da parte.
Ma ce n'è altra che egli lascia nella moltitudine,
che non «ritira dal mondo».
E' gente che fa un lavoro ordinario,
che ha una famiglia ordinaria o che vive un'ordinaria vita da celibe.
Gente che ha malattie ordinarie, lutti ordinari.
Gente che ha una casa ordinaria, vestiti ordinari.
E' la gente della vita ordinaria.
Gente che s'incontra in una qualsiasi strada.
Costoro amano il loro uscio che si apre sulla via,
come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta
che si è rinchiusa definitivamente dietro di loro.
Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze
che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi
è per noi il luogo della nostra santità.
Noi crediamo che niente di necessario ci manca,
perché se questo necessario ci mancasse Dio ce lo avrebbe già dato.

SPIRITUALITÀ DELLA BICICLETTA...Andate!
“Andate...” dici a ogni svolta del Vangelo.
Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare
anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare.
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano.
Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi
se non in movimento,
se non in uno slancio.
Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare,
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro
finché qualcuno non la inforca
per farla correre veloce sulla strada.
La condizione che ci è data è un’insicurezza universale,
vertiginosa.
Non appena cominciamo a guardarla,
la nostra vita oscilla, sfugge.
Noi non possiamo star dritti se non per marciare,
se non per tuffarci,
in uno slancio di carità.
Tutti i santi che ci sono dati per modello,
o almeno molti,
erano sotto il regime delle Assicurazioni,
una specie di Società assicurativa spirituale che li garantiva
contro rischi e malattie,
che prendeva a suo carico anche i loro parti spirituali.
Avevano tempi ufficiali per pregare
e metodi per fare penitenza, tutto un codice di consigli
e di divieti.
Ma per noi
è in un liberalismo un poco pazzo
che gioca l’avventura della tua grazia.
Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale.
Il nostro cammino si fa di notte.
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina
come uno scatto di segnali.
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare
dello stesso lavoro ogni giorno da fare
della stessa vita da ricominciare
degli stessi difetti da correggere
delle stesse sciocchezze da non fare.
Ma al di là di questa garanzia
tutto il resto è lasciato alla tua fantasia
che vi si mette a suo agio con noi.

PREGHIERA PER RESTARE SVEGLI
O Signore,
che continuamente c'incitasti
a star svegli
a scrutare l'aurora
a tenere i calzari
e le pantofole,
fa' che non ci appisoliamo
sulle nostre poltrone
nei nostri anfratti
nelle culle in cui ci dondola
questo mondo di pezza,
ma siamo sempre attenti a percepire
il mormorio della tua Voce,
che continuamente passa
tra fronde della vita
a portare frescura e novità.
Fa' che la nostra sonnolenza
non divenga giaciglio di morte
e - caso mai - dacci Tu un calcio
per star desti
e ripartire sempre.

Ogni giorno è da vivere
Ogni mattina
è una giornata intera
che riceviamo dalle mani di Dio.
Dio ci dà una giornata intera
da lui stesso preparata per noi.
Non vi è nulla di troppo
e nulla di "non abbastanza",
nulla di indifferente
e nulla di inutile.
È un capolavoro di giornata
che viene a chiederci di essere vissuto.
Noi la guardiamo
come una pagina di agenda,
segnata d'una cifra e d'un mese.
La trattiamo alla leggera
come un foglio di carta.
Se potessimo frugare il mondo
e vedere questo giorno elaborarsi
e nascere dal fondo dei secoli,
comprenderemmo il valore
di un solo giorno umano.
Madeleine Delbrel

Madeleine Delbrel
È stata definita una delle più grandi mistiche del XX secolo e in effetti la vita di Madeleine Delbrêl, di cui papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che ne riconosce le virtù eroiche dichiarandola venerabile, è una corsa verso Dio. Cominciata quando, a 20 anni, rimane folgorata come un novello san Paolo sulla via di Damasco.
Atea dichiarata a 15 anni, a 17 aveva sintetizzato con la inesorabilità tipica degli adolescenti che "Dio è morto... viva la morte". A innescare il cambiamento è la scoperta che il ragazzo di cui si è innamorata, e con cui aveva diviso appassionati discorsi, è entrato nei Domenicani. Per lei inizia un periodo di crisi esistenziale che culmina nella professione di fede che la apre a una vita nuova.
Diplomata assistente sociale e capo scout, si trasferisce nel 1933 con due amiche nell'estrema periferia di Parigi, a a Irvy-sur-Seine. In una realtà in cui il marxismo trionfava grazie anche alle pessime condizioni di vita in cui erano costretti gli operai, Madeleine e le sue amiche danni vita a una intensa opera di apostolato sulle strade, nelle fabbriche e anche nei bar. Un cammino sostenuto dall'idea che è "la strada" ovvero il luogo in cui Dio chiama ad operare "il luogo della santità". Un immergersi in Dio che la rende capace di vedere il grande inganno marxista senza perdere mai di vista le persone che in questa menzogna cadono spinte dalla povertà e dalla miseria in cui sono costrette a vivere. "Dio non ha detto - scriveva - ama il prossimo tuo tranne i comunisti".
Dimensione contemplativa e difesa della dignità degli ultimi e dei più poveri, sono i fari che determinano la sua esistenza. Delbrêl e le sue amiche diventano presto un punto di riferimento per tante persone, che se non condividono la fede (almeno all'inizio), le riconoscono un amore verso il prossimo che travalica ogni differenza. Precorritrici della Chiesa in uscita che si china sulle ferite del mondo, soccorrono, aiutano, portano speranza in un mondo spesso preda della disperazione. Per 30 anni vive e opera nel silenzio senza mancare, però, di avere uno stretto rapporto con le autorità ecclesiali cui è sempre stata fedele e obbediente.
Sostenitrice di un più ampio coinvolgimento dei laici nella Chiesa, morì all'improvviso al suo tavolo di lavoro il 13 ottobre 1964 lo stesso giorno in cui, per la prima volta, un laico prese la parola all'interno del Concilio Vaticano II.
La Conferenza episcopale francese ha aperto la causa di beatificazione negli anni '90. Durante la visita ad limina dei presuli transalpini nel 2004, Giovanni Paolo II, l'ha posta come esempio auspicando che "la sua luminosa testimonianza possa aiutare tutti i fedeli, uniti ai loro Pastori, a radicarsi nella vita comune e nelle diverse culture per farvi penetrare la novità e la forza del Vangelo".
Rainer Maria Rilke.. Poeta della luce

Delle tue vastità fammi guardiano
Fammi ascoltatore attento della pietra, donami di aprire bene gli occhi su quanto i tuoi mari siano soli, lascia che accompagni lo scorrere dei fiumi dall esultanza di una riva e l altra fin dentro il suono della notte lungamente. Manda me nei tuoi deserti territori là dove vanno i grandi venti, dove grossi chiostri, come vesti, si levano d' intorno a vite mai vissute. La voglio fermarmi con i pellegrini e per un sentiero andare che nessuno sa.
Rainer Maria Rilke

Non attender che Dio su te discenda
e che ti dica: sono.
Senso alcuno non ha quel Dio che afferma
l'onnipotenza sua.
Sentilo tu, nel soffio ond'ei ti ha colmo
da che respiri e sei.
Quando, non sai perché, ti avvampa il cuore,
è lui che in te si esprime.
Rainer Maria Rilke

.
Bisogna, alle cose,
lasciare la propria quiete, indisturbata evoluzione
che viene dal loro interno
e che da niente può essere
forzata o accelerata.
Tutto è: portare a compimento
la gestazione
e poi dare alla luce.
Bisogna avere pazienza
verso le irresolutezze del cuore
e cercare di amare le domande stesse
come stanze chiuse a chiave e come libri
che sono scritti in una lingua che proprio non sappiamo.
Si tratta di vivere ogni cosa.
Quando si vivono le domande,
forse, piano piano, si finisce,
senza accorgersene,
col vivere dentro alle risposte
celate in un giorno che non sappiamo.
Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke, nato a Praga nel 1875, figlio sensibilissimo e fragile di un modesto funzionario, fu avviato alla carriera militare: nel 1890, per cause rimaste oscure abbandonò la scuola militare di Mährisch-Weisskirchen. Dopo due anni a Linz, tornò a Praga dove preparò privatamente l'esame di licenza liceale (1895). La sua precoce vocazione letteraria fu incoraggiata dalla madre. Nel 1896-1899 proseguì a Monaco e a Berlino gli studi di letteratura e di storia dell'arte. Fa il suo decisivo incontro con Lou Andreas- Salomé, con lei compie nel 1899 e nel 1900 due viaggi in Russia: incontra Tolstoj, il misticismo e il paesaggio russo. Nel 1900 entra a far parte di una colonia di artisti a Worpswede, presso Brema, dove aveva conosciuto la scultrice Clara Westhoff, che sposò dopo pochi mesi. Il matrimonio fallì presto. Rilke si trasferì a Parigi dove, nel 1905, incontrò lo scultore Rodin, di cui divenne segretario fino al 1906 quando ruppe con lui.
Una nuova grave crisi psicologica, dovuta anche dall'incontro con la filosofia di Kierkegaard, provocò una nuova fase di inquietudine: tra il 1901 e il 1913 viaggia in Europa meridionale e in Africa settentrionale. Nel 1911 è ospite nel castello della principessa von Thurn-und-Taxis, a Duino, presso Trieste. Durante la guerra visse quasi sempre a Monaco. E' poi nel castello di Muzot, nel Vallese, nel 1923. Rilke morì in un sanatorio di Valmont (Montreux, Svizzera) nel 1926, stroncato dalla leucemia, dopo terribili sofferenze.
Opere
Della sua vocazione letteraria Rilke aveva una consapevolezza acuta e precoce. Vedeva in sé stesso una specie di mediatore della grazia. La sua prima raccolta poetica, Vita e canti (Leben und Lieder, 1894), poi ripudiata dall'autore, nel vago lirismo sentimentale mostra un giovane Rilke legato al decadentismo della fine del secolo. A essa seguirono Sacrificio al lari (Larenopfer, 1895), Incoronato di sogno (Traumgekrönt, 1896), Avvento (Advent, 1897).
Decisivo fu l'incontro con Lou Andreas-Salomé, l'intellettuale allora più anziana di lui di quindici anni, che era stata amica di Nietzsche e che sarebbe poi diventata allieva di Freud. In lei Rilke trovò un sostegno umano e artistico. A lei è dedicato un diario tenuto a Firenze durante la primavera del 1898, il cosiddetto "Quaderno di Firenze" (Florenzer Tagebuch, 1942), di grande importanza per la conoscenza della personalità dello scrittore in quel periodo della sua vita, influenzata dall'esempio di Nietzsche. Al 1899 risalgono la raccolta Per la mia gioia (Mir zu Feier), e il racconto lirico Il canto di amore e di morte dell'alfiere Christoph Rilke (Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke), opera che segna l'adesione di Rilke all'ideale neo- romanticista e che costituì il primo grande successo di pubblico di Rilke.
Tra il 1899 e il 1903 Rilke scrisse le tre parti del Libro d'ore (Das Stundenbuch):
Il libro della vita monastica (Das Buch vom mönchischen Leben)
Il libro del pellegrinaggio (Das Buch von der Pilgerschaft)
Il libro della povertà e della morte (Das Buch von der Armut und vom Tode).
L'opera, pubblicata in prima edizione nel 1905 (con frontespizio di W. Tiemann) fonda la fama del giovane Rilke. Essa esprime una religiosità terrestre, che si esplica nella mistica delle cose concrete e nell'esercizio artistico. Il tema è variato con una proliferazione inesauribile di metafore: tale ricchezza fa del libro una delle grandi creazioni verbali del tempo.
Influenzate dalle esperienze del viaggio russo sono le Storie del buon dio (Geschichten vom lieben Gott, 1900-1904), ciclo di racconti «narrati ai grandi per i bambini», nella quale Rilke dà voce alla presenza divina nella vita quotidiana. Il libro delle immagini (Das Buch der Bilder, 1902) che apparve poi in nuova edizione ampliata nel 1906, e che assegna un ulteriore affinamento delle sue qualità poetiche.
La severa concezione dell'arte e la disciplina morale di Rodin, come pure la conoscenza dell'opera di Cézanne (di cui fu allestita una mostra nel 1907), contribuirono a provocare un profondo mutamento in Rilke, evidente nelle Nuove poesie (Neue Gedichte, 1907 e 1908). In quest'opera Rilke cerca di fissare con precisione le immagini delle cose, per restituire alla realtà la pienezza del senso, andata perduta a causa del processo di mercificazione che ha investito la società industriale.
Documentazione artistica, per molti aspetti rivoluzionaria, di una tormentosa condizione esistenziale, quella dell'artista chiuso nella propria interiorità, è il romanzo-dialogo autobiografico I quaderni di Malte Laurids Brigge (Die Aufzeichnungen des Malte Lauridts Brigge, 1910). Il protagonista, un giovane intellettuale inquieto, va a abitare malato e solo a Parigi. Vi sperimenta la paura, la solitudine, la miseria, ma impara a vedere le cose, che mostrano certe parvenze per poi fluire in altre in un flusso continuo. E' attratto dai derelitti, dai dementi, dai miserabili che finiscono con il dare alla città contorni ossessivi e allucinati. Annota in un suo diario sogni e incubi, reminiscenze dell'infanzia, momenti felici e dolorosi. Su tutto prevale il pensiero del la morte e la ricerca di dio.
Rilke iniziò nel 1911 la prima stesura delle Elegie duinesi (Duineser Elegien) a Duino, presso Trieste, ospite nel castello della principessa von Thurn-und-Taxis, che concluse nel 1923 nel castello di Muzot, nel Vallese. Seguirono i Sonetti a Orfeo (Sonette an Orpheus, 1923), e la raccolta postuma delle Poesie estreme (Späte Gedichte) caratterizzate da una limpida serenità. Siamo al culmine della maturità poetica di Rilke, in queste poesie, di grande e tersa audacia formale, Rilke si stacca nettamente dalla cultura della crisi di fine secolo, per approdare a una nuova visione della vita: una visione che considera ancora l'uomo come possibile distruttore del mondo in quanto mercificatore, ma anche come suo possibile salvatore, quando sappia trasferirlo in un invisibile «spazio interiore», identificato e difeso dal verbo poetico. La necessità di preservare da ogni minaccia esterna questo spazio interiore era apparsa a Rilke in tutta la sua drammatica urgenza soprattutto di fronte alla prima guerra mondiale, cui aveva assistito con angoscioso sgomento.
Le nuove dimensioni della forma e del linguaggio esplorate e fissate da Rilke hanno esercitato un influsso determinante sulla poesia della prima metà del XX secolo europeo.
Cristina Campo..la poetessa che cerca la parola perfetta

Cristina Campo..
la passione della perfezione
Per la maggior parte degli italiani Cristina Campo è una sconosciuta ma per un’élite è oggetto di vero e proprio culto. Schiva, antimoderna, consacrata alle lettere, la Campo è destinata a rimanere nell’ombra per aver scritto poco (e mai narrativa) e di difficile approccio anche da un punto di vista commerciale: pubblicata da Adelphi, la Campo rimane pietra miliare del Novecento italiano.
La scrittrice più sconosciuta d’Italia è Cristina Campo al secolo Vittoria Guerrini nata a Bologna il 28 aprile del 1923 e morta a Roma il 10 gennaio 1977. Nata con una malformazione cardiaca non frequentò i suoi coetanei e seguì studi privati maturando un isolamento e una precarietà che si sarebbero rispecchiati nei suoi scritti. Poetessa, scrittrice, saggista e traduttrice, visionaria, icona dell’essenzialità, in vita ha scritto relativamente poco e avrebbe voluto scrivere anche meno (dalle sue stesse parole). Definita “scrittrice assente” era ossessionata dalla passione per la perfezione. Morì a soli 54 anni dopo essere stata una delle più grandi intellettuali del Novecento. Amava scrivere sotto pseudonimo (Cristina Campo è il più celebre ma si firmava anche Puccio Quaratesi, Bernardo Trevisano, Giusto Cabianca, Benedetto P. d’Angelo) e amava giocare con gli amici sul tema della propria identità anagrafica.
Cristina Campo abitò a Bologna (dove nacque), a Firenze e a Roma (dove morì). Visse di letteratura, circondata dai gatti e quando morì molte delle sue carte andarono disperse. Le sue raffinate pagine erano estranee ad una società incapace di leggerle (era tagliata fuori dalla scena editoriale). Si racconta che fosse vivace e molto affascinante con mani piccole e orecchie bellissime ma, nell’impossibilità di avere figli, non si sposò, ebbe amicizie innocenti e un rapporto privilegiato con l’intellettuale Elémire Zolla, studioso delle culture d’Oriente, ch’ella salvò dalla tisi. Durante gli anni romani i due vissero ai due lati del Tevere, poi in due stanze della Pensione Sant’Anselmo e infine in un appartamento su piazza Sant’Anselmo ma la convivenza fu quella di due anime opposte: rigorosa quella di Cristina, disordinata quella di Zolla. La Campo divenne una cattolica fanatica: ispirata da Simone Weil (che le aveva fatto conoscere Mario Luzi) si abbandonò alla mistica e, nell’ultima parte della sua vita, all’ascesi. Zolla difendeva le tradizioni ma non sprofondò mai nel fanatismo. Quando Cristina morì Zolla ne fu devastato: nonostante un documento in cui i due si lasciavano i reciproci scritti, la Campo aveva cambiato idea e i parenti ne avrebbero disperso lettere e carte. Zolla, allora, ritornò a vivere nella Pensione Sant’Anselmo con pochi libri, pochi mobili e tre gatti.
Cristina Campo fu una grandissima lettrice e spaziò da Shakespeare a T. S. Eliot, da Virginia Woolf a Truman Capote, da William Carlos Williams a John Donne, da Gustav Herling a Simone Weil, da Proust a Borges, da Hoffmannsthal a Dante, da Céline a Cechov a Emily Dickinson e tanti altri ancora. Frequentava scrittori e poeti: Alessandro Spina, Corrado Alvaro, Mario Luzi, Benedetta Craveri, Giorgio Bassani, Maria Luisa
Spaziani, Pietro Citati, Guido Ceronetti, Roberto Calasso, Anna Banti, Gianfranco Draghi, Ezra Pound. La sua vita si è compiuta solo grazie alla letteratura. Non è facile sintetizzare l’opera e la personalità della Campo che resta un grande insondabile mistero. Donna in contraddizione cercava la solitudine e temeva le cattive compagnie. Sceglieva le battaglie da combattere e ci si buttava a capofitto: processi, repressioni, stermini, distruzioni fino all’ultima, quella a favore della tradizione liturgica della religione cattolica. Sola, e sempre più isolata, per tutta la vita scrisse tante lettere ad amici e colleghi, in particolare all’amica Margherita Pieracci (curatrice delle sue opere).
In realtà Cristina Campo scrisse moltissimo se si contano i saggi e le traduzioni ma è difficile recuperarli perché mai raccolti in volumi. Esiste invece una ricca e dettagliata bibliografia dei suoi scritti. Ufficialmente l’opera della Campo consta di tre tomi, Gli imperdonabili, La Tigre Assenza e Lettere a un amico lontano: un volume di saggi creativi (s
critti in vari anni), una raccolta di testi poetici (un vero e proprio planctus scritto dopo la morte dei genitori) e un libriccino di lettere. Gli ultimi due sono addirittura postumi e voluti dagli amici editori. Con gli anni sono stati pubblicati altri libri della Campo quasi tutti di natura epistolare (Il mio pensiero non vi lascia, Carteggio, Un ramo già fiorito. Lettere a Remo Fasani, Lettere a Mita, Se tu fossi qui. Lettere a Maria Zambrano, Caro Bul. Lettere a Leone Traverso).
Nel 2002 è uscita la sua biografia, Belinda e il suo mostro (Adelphi) scritta da Cristina De Stefano che racconta tutta la sua storia intensa e vibrante: dall’infanzia bolognese alle amicizie, dagli anni della guerra agli amori, dagli amori alle testimonianze fino alla morte. Come un’indagine poliziesca, la vita della Campo è ricostruita attraverso testimonianze e la rilettura dei suoi testi. E per noi lettori curiosi è l’unica via da percorrere per conoscere la biografia di questa straordinaria artista che, alla continua ricerca della perfezione, ha lasciato tanti frammenti di sé senza mai concepire un’opera maggiore che forse ne avrebbe consacrato il genio.

Devota come un ramo
Devota come un ramo curvato da molte nevi
allegra come falò per colline d'oblio,
su acutissime lamine in bianca maglia di ortiche,
ti insegnerò, mia anima, questo passo d'addio...
Cristina Campo

Amore, oggi il tuo nome
Amore, oggi il tuo nome
al mio labbro è sfuggito
come al piede l'ultimo gradino...
ora è sparsa l'acqua della vita
e tutta la lunga scala
è da ricominciare.
T'ho barattato, amore, con parole.
Buio miele che odori
dentro diafani vasi
sotto mille e seicento anni di lava
ti riconoscerò dall'immortale
silenzio.
Cristina Campo

La neve era sospesa tra la notte e le strade
come il destino tra la mano e il fiore.
In un suono soave
di campane diletto sei venuto…
Come una verga è fiorita la vecchiezza di queste scale.
O tenera tempesta
notturna, volto umano!
(Ora tutta la vita è nel mio sguardo,
stella su te, sul mondo che il tuo passo richiude).
Cristina Campo

Sei poesie tradotte da Cristina Campo
CRISTINA CAMPO TRADUCE FRIEDRICH HOELDERLIN
Poco sapere, ma di gioia molto
ai mortali e' concesso.
O bel sole, perche' me non appaga
- tu, fiore dei miei fiori - nominarti
in un giorno di maggio? So io forse
cosa piu' alta?
Oh fossi piuttosto un fanciullo!
e come gli usignuoli, in canti senza affanno,
la mia gioia cantassi!
CRISTINA CAMPO TRADUCE EDUARD MOERIKE
Scioglie il suo nastro azzurro primavera
nuovamente nell'aria.
Dolci, noti profumi,
rigano di presagi la campagna.
Trasognate viole
chiedono di sbocciare. -
Ascolta: un tocco d'arpa, chissa' dove!
Primavera, sei giunta! E' la tua voce!
CRISTINA CAMPO TRADUCE HECTOR MURENA
Chi puo' guardare due volte
le scarpe di una creatura
qualunque
senza mettersi a piangere?
Dio, col suo sguardo
infinitamente abbattuto
che non si stacca mai
dalle scarpe degli uomini.
CRISTINA CAMPO TRADUCE WILLIAM CARLOS WILLIAMS
L'imperatore impotente
si ottunde a scrivere
poemi in un giardino
e intanto i suoi eserciti
uccidono e bruciano. Ma noi,
poveri e senza amore,
serbiamo qualche intesa
con quella verita' che e' la tristezza
dell'uomo: diciamo -
i tardi fiori, intoccati
dagli insetti e in attesa
solo del gelo.
CRISTINA CAMPO TRADUCE JOHN DONNE
Morte, non andar fiera se anche t'hanno chiamata
possente e orrenda. Non lo sei.
Coloro che tu pensi rovesciare non muoiono,
povera morte, e non mi puoi uccidere.
Dal riposo e dal sonno, mere immagini
di te, vivo piacere, dunque da te maggiore,
si genera. E piu' presto se ne vanno con te
i migliori tra noi, pace alle loro ossa,
liberazione all'anima. Tu, schiava
della sorte, del caso, dei re, dei disperati,
hai casa col veleno, la malattia, la guerra,
e il papavero e il filtro ci fan dormire anch'essi
meglio del tuo fendente. Perche' dunque ti gonfi?
Un breve sonno e ci destiamo eterni.
Non vi sara' piu' morte. E tu, morte, morrai.
CRISTINA CAMPO TRADUCE SIMONE WEIL
Giorno che sorgi puro, sorridere sospeso
Sulla citta' d'un tratto e i suoi mille canali,
Quanto agli umani che accolgono la tua pace
Vedere il giorno e' soave!
Il sonno mai mi aveva colmato
Come stanotte e dissetato il cuore.
Ma il giorno dolce ai miei occhi e' venuto,
Dolce piu' del mio sonno!
Ecco, il richiamo del giorno tanto atteso
Tocca la citta' tra le acque e la pietra.
Un fremito nell'aria ancora muta
Sorge per ogni dove.
Vieni e vedi, citta', la tua gioia ti attende,
Sposa dei mari, vedi, lontano e piu' vicino,
Tanti flutti rigonfi di sussurri felici
Benedirti al risveglio.
Sul mare si distende lentamente la luce.
Tra un attimo la festa colmera' i nostri voti.
Il mare calmo attende. O bellezza sul mare
Dei raggi dell'aurora!
Il poeta contadino Giuseppe Guarisco..vero discepolo della Divina Sapienza

La mia vita
Cenni biografici
Un giorno lontano, 10 maggio 1914, venivo alla luce di questo mondo in una piccola e vecchia casa in contrada Bregadina, a Viadana di Calvisano. Prima di me c’erano già sei fratelli: tre maschi e tre femmine. Là i primi vagìti in una famiglia povera. Le membra strette con larghe fasce.
Raggiunti i due anni la mia famiglia si è trasferita nella cascina “Vaschina sera”. Una cascina senza comodità, con un po’ di terra. Qui ho iniziato le prime fatiche fisiche.
Dopo di me sono nati altri due fratelli: una famiglia di undici componenti. Il lavoro era campi e stalla.
A sei anni ho cominciato la prima elementare. Al mattino mi alzavo presto: prima aiutavo in stalla, alle ore sei andavo a servire la Messa e poi a scuola. La terza elementare l’ho ripetuta tre volte: capivo poco! Naturalmente c’eran solo tre anni di scuola.
Il lavoro della campagna era massacrante. La mietitura del grano si faceva a mano. A otto anni tagliavo il frumento con la falce. Avevo le gambe sanguinanti per i mozziconi degli steli tagliati che pungevano.
La terra veniva lavorata con l’aratro tirato dai buoi. D’estate, per evitare il tormento dei tafani sui bovini, si partiva alle quattro del mattino. La colazione veniva consumata nel campo, seduti per terra.
Vi era la stagione dei “bachi” (“caalér”). Ci si arrampicava sulle piante dei gelsi per procurare la foglia per i bachi da seta.
D’inverno andavamo sulle piante per tagliare la legna con l’accetta.
Il lavoro della campagna camminava di paripasso con gli impegni in parrocchia. Ancora da ragazzo il curato don Pietro Marini mi affidava tanti impegni: catechista, delegato della gioventù di Azione Cattolica e più tardi degli uomini.
A diciotto anni sempre don Pietro ha insistito perché accompagnassi le funzioni in chiesa con l’armonium. Senza andare a scuola di musica mi sono arrangiato da solo… ma che fatica! In principio con brani semplici, poi con canti a più voci. Tante volte sudavo… e sbagliavo! Ma bisognava andare avanti.
Veniva il momento della filodrammatica. A fatica abbiamo messo in moto una compagnia teatrale. C’ero sempre dentro: prima attore, poi suggeritore. A un certo punto, come hobby e passione, mi son messo a scrivere delle farse e delle commedie in dialetto.
Mi sono sempre piaciute anche le poesie. Mi sembrava di avere una vena poetica. Ma poi tante volte mi inceppavo! Venivano a proposito certe parole, ma non ne conoscevo il significato. Comunque ne ho scritte tante, specialmente per gli sposalizi e in altre circostanze. Quando ci riuscivo era per me una grande soddisfazione. Mi è sempre piaciuto l’umorismo! Mi faceva dimenticare il peggio.
Poi venne il momento di partire sotto le armi. A vent’anni partii per il militare. Prima a Cremona, poi a Milano nel terzo Reggimento Artiglieria Celere. Diciotto mesi di servizio. Fui congedato nel 1936.
A casa ripresi tutte le mie attività. Aiutavo nei campi, in stalla, in chiesa e su richiesta anche in Comune a Calvisano come Consigliere. Le convocazioni erano lunghe, con discussioni animate. Tornavo la sera tardi o di notte in bicicletta.
Nel 1937, in gennaio, mi è morta la mamma, Ferrari Giacomina. Il gran lutto ha gettato uno sconforto nella famiglia, specie per il papà Damasceno. Aveva settant’anni. Uomo già logorato dal lavoro dei campi, ha tirato avanti ancora tre anni, cupo e silenzioso.
Nel 1939, avevo accennato al papà che desideravo sposarmi: lui fece una smorfia! Era il primo anno che andavo a morose dalla signorina Ferrari Luigia (Gina). Il papà non era contrario al matrimonio, ma vi erano difficoltà economiche.
Poi nel 1940 fu colpito da un altro dispiacere: con lo scoppio della seconda guerra mondiale, io fui richiamato alle armi l’11 giugno 1940. Ho prestato servizio a Rocca D’Anfo, poi a Sonico in Val Camonica e infine a Sesana di Trieste. Il giorno 23 giugno mi giunse improvviso un telegramma per la morte del papà. Un altro grave lutto.
Nel 1942, comunque, mi feci dare la licenza di un mese per sposarmi. In tempo di guerra era un rischio sposarsi.
Il primo bacio alla mia sposa l’ho dato sul treno, in viaggio di nozze il 5 ottobre 1942.
Nel 1943 il 7 settembre, con l’armistizio, è stata la tragedia. Preso prigioniero dai Tedeschi, mi portarono in Polonia e poi in Germania, sempre fra i reticolati, col tormento della fame, dei pidocchi e del freddo.
Il distacco più amaro fu quello di lasciare la giovane sposa per un viaggio ignoto: qui si apre il mio Diario di prigionia. Un calvario durato 22 mesi.
Al ritorno dalla prigionia ho ripreso il mio lavoro nei campi con pochi “piò” di terra e qualche capo di bestiame: una vita molto stentata.
Tribolando ho formato la mia famiglia. I figli nati sono sei, viventi quattro. Non sono mancati problemi di malanni: parecchie volte c’era il dottore per casa. Io avevo poca salute, perché invalido di guerra. Formare e crescere una famiglia con poca salute e tanto lavoro era preoccupante. Confidavo nella Provvidenza e superavo i momenti difficili con coraggio e col mio carattere sempre di buon umore.
Mentre tribolavo, mantenevo la vena di scrivere farse, commedie e poesie. L’arte dell’umorismo è stata per me un valido aiuto nell’approssimarsi della vecchiaia.
A un certo punto non gliela facevo più a lavorare la terra per l’invalidità fisica. Ho trovato lavoro, come invalido, presso l’industria. Ho lavorato a Brescia, poi a Carpenedolo e infine a Calvisano. Sempre un lavoro serrato fino a 63 anni.
Pensionato con la minima ho continuato stentatamente la mia vita in famiglia e in parrocchia.
Nei miei 85 anni di vita, di cui 57 di matrimonio, voglio ringraziare innanzitutto il Signore che mi ha custodito nei momenti di prova e anche mia moglie Gina che mi ha sempre accompagnato con coraggio, serenità e con le sue instancabili preghiere.
Adesso sono in attesa del giorno finale per entrare in una nuova vita!
Viadana 10 maggio 1999 Gepi

Giuseppe guarisco il poeta contadino
"vero discepolo della divina sapienza"
“Figlio mio custodisci le mie parole e fa’ tesoro dei miei precetti.
Osserva i miei precetti e vivrai; il mio insegnamento
sia come la pupilla dei tuoi occhi (Prov. 7,1-2).
Queste esortazioni che la Sapienza rivolge a chi desidera orientare positivamente la propria vita, possono ritenersi la chiave di lettura delle poesie amorevolmente raccolte per esser date alla stampa con la presente pubblicazione.
Per due motivi o sotto due prospettive convergenti:
da un lato vi si presenta l’esperienza di una persona che, attraverso le vicende della vita affrontate con fede e fiducia, ha saputo legare quelle dolorose e liete con il filo della Provvidenza di Dio “che tutto coordina per il bene di coloro che lo amano”.
E dall’altro vi si scorge come il padre affida ai figli come testamento spirituale, una testimonianza di vita serena e laboriosa, fiduciosa pur nella prova, e come i figli l’accolgono con animo riconoscente, perché vi vedono non tanto una esercitazione letteraria, quanto le pagine di vita scritte giorno per giorno, animate dalla preghiera e illuminate dalla Parola di Dio, per essere offerte con amore a chi, nel susseguirsi dei giorni, lega gioie e dolori per il bene dei suoi figli.
Pur non conoscendo l’autore, scorrendo le sue poesie ora in italiano ora in dialetto, mi sono fatto un’ottima impressione di un uomo saggio, vero discepolo della Divina Sapienza.
Non mi resta perciò che augurare ai figli e nipoti, agli amici e ai conoscenti, di saper fare tesoro della bella testimonianza di fede e di amore che il “poeta-contadino” ha voluto affidare alle poesie amorosamente raccolte nella presente pubblicazione.
Brescia 8 marzo 1999 Vigilio Mario Olmi V. A.

LA POESIA DI GIUSEPPE GUARISCO
(detto Gepi)
"Vera poesia, poesia religiosa, perché la vita è vissuta e vista sotto la luce di Dio, come è ovvio per chi ha scoperto il senso religioso del vivere"
Quella che oggi è Viadana frazione di Calvisano con più di 1250 abitanti, tutti occupati in diverse attività, fino a qualche decina di anni fa non era altro che cascine e piccole contrade sparse nella campagna a nord del territorio di Calvisano. Per secoli la popolazione si era dedicata alla coltivazione dei campi e della pastorizia.
Da sempre a Viadana la gente ha formato una Comunità, per la presenza costante di un sacerdote Il Curato di Viadana, che celebrava e raccoglieva la popolazione nella chiesa dedicata all’Annunciazione. Nella prima metà del secolo scorso il Curato era anche il maestro di scuola dei ragazzi di 1° e 2° elementare maschile.
La scuola, a Viadana, esiste fin dal 1839 per i maschi e dal 1846 anche per le femmine. Nei primi anni del ‘900 venne istituita la classe 3° elementare a Calvisano e nelle frazioni. Al termine dell’obbligo scolastico, non pochi genitori chiedevano alle maestre di far ripetere ai loro figlioli la classe 3°, perchè i loro piccoli potessero frequentare ancora la scuola, ma soprattutto perché i ragazzi e le fanciulle potessero imparare di più, dal momento che le classi 4° e 5° elementare non erano statali ma parrocchiali, funzionanti a Calvisano, presso le Madri Canossiane, e quindi piuttosto lontane dalle abitazioni.
Giuseppe Guarisco scrive di aver ripetuto tre volte la classe 3° perché capiva poco!, in realtà, per i motivi espressi sopra.
La scuola costituiva per i ragazzi una parte del loro impegno e dovere quotidiano. Negli altri momenti della giornata e nei giorni liberi di scuola, dovevano dedicarsi alle faccende domestiche o al lavoro in stalla, nei campi e nei pascoli. Un altro dovere fondamentale era la frequenza al catechismo e alla messa domenicale. Famiglia, scuola, chiesa erano strettamente unite e solidali nella educazione dei fanciulli.
Giuseppe Guarisco, nella sua poesia, esprime quel tipo di educazione e di formazione. Esalta e rimpiange nei suoi versi i valori che non sono solo del tempo passato, ma perenni: la bellezza della natura, francescamente sentita, ma anche, spesse volte, crudelmente sperimentata: tu sei benefica e pur crudele; il bene che l’uomo può compiere con l’aiuto di Dio, il male che compie per la sua fragilità e che deve espiare; l’amore, il più nobile dei sentimenti dell’uomo, ma che oggi giorno viene spesso profanato.
Nei suoi componimenti troviamo temi costanti e comuni a tutti i poeti antichi e moderni: il tempo che fugge, la morte che sovrasta, i dolci doni della natura, le piccole, ma significative gioie della vita. Tutto è visto con l’occhio dell’adulto che sa per esperienza, sovente dolorosa, la ragione del vivere, ma che ha conservato nell’anima la voce semplice del contadino.
Può sembrare, ad una prima lettura, di avere davanti una poesia popolare e naïf. Ed è vero: sono poesie per la maggior parte occasionali, scritte per varie ricorrenze religiose e civili, che la comunità di Viadana ha celebrato e ricordato. Ma le emozioni, i sentimenti, i pensieri trascendono il momento, vanno al di là del luogo e del tempo, si dilatano nel tempo e nello spazio.
In realtà, le poesie qui riportate esprimono l’esperienza di una vita intessuta di dolori e di fatica. Vi è la visione ottimistica e serena donata a Giuseppe Guarisco dalla fede e dalla pratica religiosa; ma vi è anche la consapevolezza del male e della cattiveria umana, che si è manifestata nella guerra, nella deportazione, nella prigionia nei lager. Vi è la vita di ogni giorno bella e triste nello stesso tempo, ove l’esperienza del dolore (fisico, morale, spirituale) supera l’esperienza della gioia.
E’ vera poesia, poesia religiosa, perché la vita è vissuta e vista sotto la luce di Dio, come è ovvio per chi ha scoperto il senso religioso del vivere.
Viene qui pubblicato un piccolo canzoniere, che vuol essere diario umano e spirituale. Poesia che esprime il vissuto dell’autore che rivive e reinterpreta sentimenti, emozioni, immagini proprie delle persone che vissero e ricordano un mondo ormai perduto, un mondo contadino ormai inesistente.
Affiorano dalla memoria i ricordi indelebili di chi in quel mondo è nato e a lungo è vissuto. Talvolta si nota una accorata elegia del paesaggio che è mutato troppo in fretta. E’ poesia che racconta un paese, con un pizzico di rimpianto per i valori purtroppo perduti. Ma non è rimpianto per le fatiche, per i dolori, per le preoccupazioni presenti nella civiltà contadina: chi rimpiange la vecchia civiltà contadina non l’ha mai conosciuta da vicino.
Quello era un mondo in cui vi era una diffusa povertà, sopportata con diffusa rassegnazione. La terra era l’unica fonte per il sostentamento degli uomini e degli animali. Viene alla memoria la figura di don Pietro che, all’approssimarsi dei temporali, correva a suonare le campane, per allontanare la nuvolaglia e a portarsi sulla soglia della chiesa con la reliquia della Santa Croce per scacciare con una benedizione la sventura che sovrastava.
Specie nei componimenti in dialetto (e soprattutto nelle commedie che meriterebbero di essere pubblicate) è raffigurato il mondo contadino, particolarmente quello calvisanese, o meglio viadanese.
E’ poesia intesa come gioco, lusus, come divertimento, affrontato con serietà di impegno e di intenti. Non c’è pretesa, ma gusto del poetare, desiderio non solo di dire parole, ma soprattutto di esprimere cose.
Virginio Prandini

AMORE
Fate silenzio, labbra, sì tacete!
Non cantate amor che non sapete!
Volete profanare questo grande verbo
ch’è tanto saporoso, ma per voi acerbo?
Oh! Esseri umani, miseri, che fate?
Amor non conoscete e tanto lo cantate!
Gridando fra le “musa” con espressivi gesti,
a volte forsennati, a volte pii e mesti,
che i cantautori esprimono ignari del valore
che in sè racchiude quel verbo ch’è amore.
Sol tu, o pia Madre, che il Figlio amasti tanto
puoi dir cos’è amore parlando dal tuo canto.
Sol tu, o Madre Santa, che prona alla croce
vedi il divin Figlio tra spasimo atroce,
ch’è fisso con tre chiodi, il volto insanguinato,
ci indica l’amor su un legno inchiodato.
Il Figlio tuo guardati, amor senza confini
ed i peccati sconta dei miseri tapini,
con testa bassa e umile, Lui, ch’è Redentore
e il mondo va altero seppur è peccatore.
Giuseppe Guarisco

LA VITA
Nasce un bimbo, una luce s’accende
sul lungo cammino la vita ascende.
Dapprima è bella, tutto un trastullo!
E corre e cresce quel caro fanciullo.
Tra il buono e il bello ancora non pensa
che di dolori la vita è pur densa.
E su quel sentiero il mondo nasconde
trappole, inganni e lui si confonde.
Cammina evitando fastidi e noie.
Infatti gli arridon fortune e gioie!
Diventa adulto e con l’occasioni
fa intemperanze a profusioni!
Con tanti abusi di ogni sorte
s’ammala e quasi è vicino alla morte!
L’imperdonabile mal lo colpisce
tutto il suo mondo, d’un tratto, fallisce!
Aveva una luce a mo’ di chi crede:
ma è torturato e perde la fede.
Cammina sull’orlo per disperarsi,
ma poi ci ripensa vorrebbe rifarsi!
Perché se si spegne quel poco di luce
resto al buio e chi mi conduce?
La sofferenza su di me veglia
tormentata la carne, ma l’alma risveglia.
Il mondo, il mio corpo mi hanno tradito.
Signore, Signore, or son pentito!
Lo so, lo sento che io qui soffro:
ma tutto, Signore, tutto ti offro!
Perché, purtroppo, lo devo scontare
il mal che ho fatto, il mio peccare!
Ti rendo grazie per questa tua prova,
tu mi regali una vita ch’è nuova!
Al fin quella luce prima accesa
ancor sarà viva dopo l’ascesa.
E con la morte questa mia vita
io credo, Signore, non è qui finita!
Ma sfocia gloriosa, eterna, lassù
ove tutti quei mali, non ci sono più.
Giuseppe Guarisco

LA VITE E L’UOMO
Nel verno, spoglia, niente tu dici,
niun il guardo volge su te.
Ferme, gelate son le radici
Fin che stagione bella non v’è.
Il vignaiolo poi ti s’appressa:
come chirurgo pianger ti fa.
Al rigido palo vieni poi messa,
stretta da baci senza pietà!
Lo stelo tortuoso dal sole baciato
presto si copre da verdula chioma,
da turgidi grappoli incorniciato
espande, gustoso, il suo aroma.
Superba la mano che in tavola porta
l’uva regale, bruna e dorata;
e tra la frutta di ogni sorta
sei tu la prima, la prelibata.
L’uomo sorride vederti pigiata
E ne pregusta il succo rubino:
in ogni mensa che è preparata
c’è la premura sempre del vino!
Neanche la Vergin seppe tacere
quando a Cana il vino mancò:
“Oh, figlio mio! Non hanno da bere!”.
Gesù la guarda… e poi l’ascoltò!
Ecco strappato il primo miracol
alla potenza del Figlio divin.
E’ come se vuoto sia un oracol
quando alla mensa vi manca il vin!
Oh! Qual profumo di provvidenza
c’è dal vigneto alla cantina!
“Beviamo, pure, di questa essenza:
ce l’ha mandata la mano divina!”.
Oh! Vite umile e prigioniera!
Ci dai un succo di tanto valor.
E se bevuto con bella maniera
ci rende lieti, ci dà vigor!
Chi se n’abusa sbaglia di certo:
offende Dio e scandalo dà!
Nella sua mente v’è lo sconcerto:
è degradato e nemmeno lo sa!

Il MARE
O mare! Quanto sei bello, grande, immenso!
Su di te scivolano uomini di ogni sorte!
Ma sotto, nelle viscere del tuo denso,
quanti, quanti sono gli spettri di morte!
Per questo a te volgo lo sguardo... e penso!
L’ ACQUA
Tu non hai vita e vita pur dai
immensa regina della natura.
C’è chi ti guarda, chi ti trascura
e c’è chi perfin offenderti sa.
Chi ti conosce e ti comprende
creatura, sorella mia?
Fors’il viandante su quella via
che arso e stanco si dissetò?
Oppure quel volgo, che sotto il sole,
è massacrato dal suo lavoro
ed ha trovato grande ristoro
nel chiaro vivido tuo zampil?
O forse l’uomo - il lussurioso -
che nei bagordi s’è dimenato
e refrigerio ha poi ritrovato
nella semplice tua bontà?
Quell’altro che stava nuotando
in quella spiaggia, in quel momento,
che si beava tutto contento
nel tuo dolce e lieto cullar?
Oh!… Nessuno ti dice grazie!
Ma che cattivi e senza cuore!
Eppure sanno che tutto muore
e non c’è vita senza di te!
Ah!... Quei frutti sì ubertosi
che dalla terra hanno succhiato!
Tu sei stata che hai mandato
alle radici il provvid’ umor.
Se pur semplice sei a guardarti
non ti conosce nemmen chi ti usa:
in un arcano tu sei rinchiusa
sol ti conosce il Creator.
Tu sei in terra, in cielo, in mare;
tu cambi forma, colore, aspetto
e a noi parli del tuo diletto
col tuo inno, le tue virtù.
Sei tu ancora che muovi la ruota
e al mondo dai energia.
E se di notte, su quella via,
le luci brillan, ancora sei tu.
Calma ten’vai, senza stancarti;
vispa gorgheggi nel lieto ruscello,
muovi, lambisci il ramoscello
che si diverte al tuo passar.
Quando ti tocca il sole cocente,
allora ti cangi e nùgol diventi
e poi ti plasman i provvidi venti
fin che di nuovo ritorni quaggiù.
A volte lenta, quasi graziosa,
scendi benefica dal tuo cielo
a rinverdire del prato lo stelo
e dissetare gli arsi terren.
Quando in alto ti trovi nel verno
lui ti trastulla e dice con vanto:
“Va’ sulla terra e stendi un manto
che pareggiabil un altro non v’è”.
A volte scendi, invece, furiosa
e se dal gelo tu sei toccata
allora in chicchi sei trasformata
e flagellando ci porti squallor!
Tu sei benefica e pur crudele;
diventi cattiva, cieca e dura:
perché tormenti la bella natura
che ebbe la vita pel tuo poter?
Ah!... Purtroppo quando t’impenni
e forsennata spingi la onda,
fin che all’urto cede la sponda,
allora pietade alcuna non v’è!
Come pagliuzze tutto trascini,
produci panico, grida e morte!
Eppure non meno ivi è la sorte
ove presenza tua non c’è!
Oh!…Bell’acqua, scusami tanto!
Or t’ho capito, sì finalmente!
Tu non hai colpa, sei innocente
e sei guidata dall’Autor!
Quando, fuorviata, meni una strage
è un richiamo del Creatore
che porge la prova al peccatore
perché elevi la mente al ciel!
Tu nella neve sei la purezza,
nella tempesta sei il peccato,
che strugge quanto Dio ci ha dato
e poi ritorni tutto a lavar!
Tu nel diluvio fosti lavacro
e nel mar Rosso liberatrice
poi nel Giordano, il Vangelo dice,
hai battezzato il Cristo Gesù!
Sorella acqua!
Giuseppe Guarisco
Memoria..

IL LAGER
Un grande campo tutto cintato
con sentinelle e filo spinato
dentro si gira inebetito
il prigioniero, magro, sfinito.
Lo copre un panno pien di pidocchi:
scarno il viso, fondi gli occhi.
Ha un giaciglio senza la paglia,
un gamellino e poca brodaglia.
Si regge appena, cammina a stenti,
crudo è l’inverno e batte i denti.
Pensa alla mamma, alla sposa lontano.
Di nuovo ripensa, ma tutto è vano.
Cade per terra: lenta è la mossa.
Dalla sua pelle sporgon le ossa.
L’ultimo rantolo ecco vi rende!
Dal suo collo il piastrino vi pende.
Per il tedesco che l’ha bastonato
è solo un numero quel soldato.
Lesta si muove la sentinella:
due compagni, una barella.
Il prigioniero sopra vi giace
e lento va in eterna pace.
O prigioniero! O internato!
Nella tua casa non sei ritornato.
IL SOLDATO E LA TRINCEA
Addio, mia terra!
Ti lascio, o mamma!
E’ acceso quel dramma
che chiamasi guerra.
Non sono sol io,
ma altri fratelli
che, giovani e belli
e senza oblio
pur sono chiamati
con mani protese
al natio paese
e gli occhi bagnati.
Con scarpe bucate
al freddo e pioggia
e come una roggia
trincee fangate!
Lungo il verno
con ciel rischiarato
in ogni suo lato
da guizzi d’inferno!
Son bombe, granate,
son urli, boati,
tapini soldati
si scambian occhiate.
Si squarcia la terra!
E fango e sangue!
Orribile guerra!
Hai fatto orrore,
di noi un calvario,
ed è un sacrario
che lascia dolore!
O patria amata!
Sei bella, sei cara,
ma come un’ara
di sangue bagnata!

LA GUERRA E LA MAMMA
Dense nubi di grossi apparecchi,
lucidi, in alto, sembrano specchi!
Del ciel, il soffitto, fa stillicidi
e sono bombe che fanno omicidi.
La terra si squarcia in ogni loco
e come vulcano è pioggia di fuoco!
Sui fronti, la mischia è tutta rovente:
è prova di fuoco per l’innocente!
Ed è il soldato, povero figlio,
che in terra cade tra quel periglio!
Esce dal cuore, come una fiamma,
il grido che invoca la povera mamma!
E corre la voce in tutte le onde,
la mamma accorata, ecco risponde:
“Un dì nella gioia ti ho concepito
e nel dolore ti ho partorito!
Ma tu, o guerra, me l’hai rapito!
A me solo resta pianto e duolo!
E calde lacrime bagnano il suolo”.

LA MAMMA
Mamma! Nome sacro davvero!
Ogni figlio il primo a chiamar,
quando in fasce è senza pensiero,
ma quel nome sa balbettar!
A quel nome s’aggrappa l’infante
quando piange con tanto spiacer
ed ancor se il viso è brillante
lo pronuncia siccome dover.
Oh! La mamma pel figlio ammalato
sta in pena e conforto le dà.
E nemmen un dottor rinomato
tanto bene a quel bimbo farà.
Su l’infante che giace in lettino
piovon lacrime calde e d’argento.
Lui le sente e spiana il visino:
“Mamma cara, mi ami, lo sento!”.
Quante notti, mal ferma e stanca,
tiene il bimbo che piange sul petto.
Con la tremula voce lei canta
e lo stringe ricolma d’affetto.
Con le gote sul suo visino
Lei lo scalda, lo culla d’amor;
e quegli occhi si chiudon pianino:
c’è silenzio, ma tanto calor!
Un calore che è vivo di fiamma
e che vita ha dato al piccin.
E uscito dal cuore di mamma
che pel bimbo è il cuor più vicin.
E chi, dunque, potrebbe amare
quanto lei che il dolore provò?
Oh! Vorrei col mio ben ricambiare,
ma sì tanto trovarlo non so.
Sempre pronta alla dura fatica
per i figli che sono un tesor.
Fino quasi a sfasciare la vita,
ma l’affetto di mamma non muor.
Il tuo sguardo è bello e giocondo;
il tuo volto è fatto per me.
Son tutte belle le mamme del mondo:
ma più bella ancora sei te!
Verbo eterno di Dio..Adriana Zarri
Lasciate solo la terra
che scriva, a primavera,
un'epigrafe d'erba.
E dirà
che ho vissuto,
che ho atteso,
che attendo
Adriana Zarri
Ormai si è fatto scuro e io accendo la Luce
Adriana Zarri
Se ora volessi chiudere con un congedo edificante vi potrei dire: "Ricordatevi che, in una cascina, in mezzo alla campagna, c'è un'eremita che prega". Ma mi parrebbe estremamente pletorico. Sento il bisogno di semplificare, di ridurre all'essenza: spoglio, nudo, un osso. Lasciamo cadere l'eremitismo, il monachesimo, la cascina, la campagna, perfino la preghiera. Preferisco dire che vivo: mi sembra più semplice e più ricco perchè la vita comprende la preghiera, e forse la preghiera comprende la vita ed è la vita stessa. E non è necessario ricordarmi; ma, se mai, i termini sono questi: "In una casa c'è una persona che vive". E non è poi quello che diciamo sempre quando ci chiedono: "In quella casa chi ci abita?" e noi rispondiamo: "C'è Tizio; ci abita Caio".
Quanto narrare per concludere con quasi nulla, quasi una banalità! E sbiadiscono tutte le strutture: anche quelle più care, quelle che mi hanno portato e che mi portano, che mi fanno esser chi sono e come sono ma non dissimile, nella profondità, da ogni uomo che vive, che lavora, studia, s'interroga, si tormenta... e tutto questo ripiegarsi e complicarsi è per scoprire la semplicità.
Sono un'eremita come potrei essere una suora, o una moglie o un padre; vivo in una cascina di campagna come potrei vivere in un monastero o in un appartamento di città; faccio la scrittrice come potrei fare la sarta. Niente importa perché tutto è importante nella medesima maniera.
Ormai s'è fatto scuro e io accendo la luce. Si vede, fin dalla strada, la luce del Molinasso. Anch'io rischiaro debolmente il buio come ogni finestra che s'accende di notte. Uno passa, vede quei piccoli punti luminosi e pensa che c'è una casa, un uomo, una vita. "In una casa c'è una persona che vive".
ADRIANA ZARRI. MONACO IN DIALOGO
Giannino Piana
Il mondo interiore di Adriana Zarri [*], una vera mistica del nostro tempo, non è facile da decifrare. Sebbene siano molti i testi di spiritualità che ci ha lasciato – alcuni dei quali di rara intensità[1] – la sua figura di donna votata alla vita monastica risulta a chi l’ha conosciuta da vicino (e per un lunghissimo periodo della sua esistenza) caratterizzata da mille sorprendenti sfaccettature che non si lasciano imbrigliare dentro una scrittura, sia pure carica sempre di un’impronta fortemente personale, come la sua.
La ricchezza della personalità e la estrema varietà degli interessi coltivati confluivano in lei attorno ad un asse fondamentale, che dava unità alla sua esistenza: la ricerca insonne di Dio in un rapporto stretto con la terra in tutte le sue componenti – dagli uomini agli animali al mondo vegetale (è sufficiente ricordare la passione di Adriana per i gatti e, finché le è stato concesso dalla salute, l’allevamento degli animali da cortile e la coltivazione dell’orto) – aderendo alle radici contadine, che hanno segnato profondamente la sua identità umana e religiosa[2].
Ad avvalorare questa visione vi è poi il suo essere donna: l’appartenenza di genere si riflette decisamente anche sulla sua spiritualità, che ha i connotati di una spiritualità al femminile. Anche a questo proposito emerge tuttavia l’originalità di Adriana: la sua adesione alle lotte femministe è stata infatti sempre contrassegnata da un vero (e profondo) coinvolgimento e insieme dalla rivendicazione di una grande libertà e indipendenza di giudizio.
Nel cuore di una spiritualità della vita quotidiana
La spiritualità di Adriana coinvolge dunque – come si è accennato – la realtà in tutte le sue dimensioni. Il profumo dei campi nelle diverse stagioni, il colore variegato dei fiori, il fruscio delle fonde e il verso degli animali e (soprattutto) le vicende degli uomini, quelle dei poveri in particolare, segnano l’incontro con un Dio che è dentro la storia: il Dio che si è definitivamente manifestato nella persona di Gesù di Nazaret. Ma l’aspetto che contraddistingue, in modo speciale, il suo approccio, e che la avvicina alla spiritualità francescana, è l’accento posto sull’importanza che ha avuto, nel «farsi carne» (sarx) del Figlio di Dio, la dimensione «spaziale» (e non solo «temporale»), il «divenire natura» (e non solo storia).
Il creato, in tutta la ricchezza delle sue espressioni, assume il carattere di habitat (spazio opportuno) che, rapportandosi al kairòs (tempo opportuno), conferisce alla dimensione contemplativa un orizzonte cosmico. L’esperienza di Dio nel mondo fa della vita quotidiana, nella molteplicità delle sue espressioni, non solo la sorgente ma anche la modalità secondo la quale vivere la relazione con il divino. Vi è dunque una profonda continuità tra vita spirituale e vita quotidiana, perché il Dio della rivelazione è – come ci ricorda la lettera ai Filippesi da Adriana spesso citata – colui che in Gesù Cristo «svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini» e «facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2, 7-8).
Dio e mondo sono dunque per Adriana in un rapporto di circolarità: da un lato, la immagine del Dio cristiano non può prescindere dalla sua relazione con il mondo di cui è entrato a far parte; dall’altro, il mondo è da questa relazione riscattato; diviene anticipazione del Regno. Questa visione della realtà, che sollecita l’impegno nel presente e l’attesa del futuro, ha per Adriana una perfetta esplicitazione nella preghiera del Padre nostro, dove alla richiesta del pane quotidiano («Dacci oggi il nostro pane quotidiano») corrisponde l’invocazione del compiersi del Regno («Venga il tuo Regno») e dell’adempimento della volontà del Padre (“Sia fatta la tua volontà”) (Mt 6, 9-13).
La dimensione trinitaria
La dinamica relazionale, che è l’asse portante della spiritualità di Adriana, ha poi nel mistero trinitario le sue radici. Il Dio della rivelazione ebraico-cristiana, che Gesù di Nazaret ha reso trasparente nella sua persona e attraverso la sua azione, è il Dio Padre, Figlio e Spirito Santo: un Dio nel quale la relazione coincide con la stessa natura: le persone che costituiscono il mistero divino sono in quanto si rapportano tra loro.
La definizione che di Dio fornisce la prima lettera di Giovanni: «Dio è carità» (1 Gv 4, 8) ha qui la sua più profonda motivazione. Trinità e carità sono strettamente correlate e interdipendenti. Solo di un Dio che vive in comunione di persone è infatti possibile dire che è Amore (e non semplicemente che ha l’amore), perché l’amore implica la relazione tra persone, che si costituiscono nel reciproco donarsi. In un libro di preghiere (o di quasi preghiere) che reca significativamente il titolo Tu[3], Adriana si rivolge a Dio come a Qualcuno cui è possibile dare del tu, giungendo a livelli di intimità che ricordano le grandi esperienze mistiche – da maestro Eckhart a Giovanni della Croce e a Teresa d’Avila – alle quali spesso Adriana fa riferimento nei suoi scritti.
L’incontro profondo ma sempre inevitabilmente limitato con il tu divino – la conoscenza di Dio è quaggiù parziale («per speculum et in aenigmate») – è la molla che spinge Adriana ad accostarsi alla morte, che ella considera una componente essenziale della vita – il contatto con la natura cui è stata abituata fin dall’infanzia facilitava la consapevolezza di questa continuità – come al passaggio da questa vita alla vita nuova, nella quale diviene finalmente possibile entrare in una relazione «faccia a faccia» con il Signore, che consente di conoscerlo come egli è («sicuti est»).
Due attitudini esistenziali: ascolto e ricettività
La spiritualità di Adriana non si esaurisce tuttavia nella sola adesione ai presupposti fondativi ricordati; si rende concreta in una serie di attitudini esistenziali, due delle quali meritano di essere particolarmente ricordate.
La prima è l’ascolto. Le religioni del Libro sono religioni dell’ascolto: «Ascolta Israele» è l’invito che, fin dall’inizio, Dio rivolge al suo popolo. Ma l’ascolto – Adriana lo mette bene in evidenza – non si esaurisce (e non può esaurirsi) in un semplice sentire; esige un ridimensionamento dell’io per fare spazio all’accoglienza dell’altro e alla comprensione del suo messaggio. Esige la creazione di un clima di silenzio e la disponibilità a fare propria la povertà evangelica, che è insieme sobrietà nei confronti delle cose e apertura fiduciale alla grazia divina. La scoperta del mondo degli altri e dell’Altro è legata all’abbandono di ogni forma di autoreferenzialità, quale frutto di una profonda trasformazione interiore, una vera metanoia.
Una seconda attitudine, particolarmente cara ad Adriana, è la ricettività, che ella considera un habitus esistenziale in stretta sintonia con il vissuto femminile. Destinata ad essere custode della vita, la donna ha sviluppato una maggiore sensibilità nei confronti di tale attitudine, la quale, lungi dall’identificarsi con la passività, è l’espressione (forse) più alta di attività, in quanto esige, per potersi esplicare, un processo di interiorizzazione, che consenta di riconoscere l’altro nella sua alterità, senza proiezioni mistificatorie.
D’altra parte, la ricettività non è soltanto una virtù umana, per quanto grande; è anche – a questo va soprattutto ricondotta l’importanza che Adriana attribuisce ad essa – la condizione fondamentale per vivere la relazione con il Dio cristiano, il quale viene costantemente incontro all’uomo, andando alla sua ricerca anche quando si è colpevolmente allontanato da Lui. La fede non comporta dunque un andare verso Dio, ma un disporsi a riceverlo, creando le condizioni per accoglierlo, lasciandosi fare e amare da Lui.
La preghiera e l’eremo
L’esperienza spirituale fin qui evocata ha per Adriana il suo momento più alto nella preghiera, o meglio nel pregare, il quale, lungi dal ridursi a fare o a dire preghiere, è un vero e proprio modo di essere-al-mondo. Il Dio della rivelazione biblica è il Dio dell’alleanza, che entra in comunione vitale con l’uomo ma che, al tempo stesso, gli impone di non raffigurarlo nè nominarlo, rivendicando in questo modo la sua assoluta Alterità. La preghiera è dunque ascolto, incontro e relazione, ma è anche rispetto di una distanza che non può mai essere del tutto colmata. È un vivere alla presenza di Dio, fare esperienza dell’essere abitati da Lui, ma è anche riconoscimento dell’assenza; è rifiuto di catturarlo per servirsene, evitando di assumersi fino in fondo la propria responsabilità nel mondo.
La preghiera è una cosa seria che implica la confidenza, ma che non può essere viziata da sdolcinature impudiche – il tema del pudore ricorre con frequenza nei testi spirituali di Adriana come un’istanza che deve connotare ogni espressione religiosa – e che non deve essere separata dal contesto in cui si sviluppa l’esistenza. L’incontro con Dio rinvia all’impegno nel mondo; l’atto cultuale non ha alcun significato se non si traduce in culto spirituale, nella capacità di coniugare incontro con Dio e fedeltà all’uomo e alla terra, immettendo nel dialogo religioso le inquietudini e le speranze umane.
La preghiera di Adriana ha questo timbro; da essa scaturisce la militanza che ha contrassegnato l’intera sua esistenza, con la partecipazione diretta alle battaglie contro le diseguaglianze sociali e per la promozione dei diritti civili. L’eremo non è stato per lei un luogo separato dal mondo, ma un angolo appartato dal quale guardare con lucidità e partecipazione le vicende umane e mondane. La solitudine del monaco – Adriana preferiva definirsi così, al maschile, per l’accezione equivoca acquisita dal termine femminile – non è isolamento; è un processo di riappropriazione del mondo interiore, che restituisce all’uomo la libertà, rendendolo capace di esercitare il discernimento profetico nei confronti della realtà.
Una spiritualità, quella di Adriana, la cui grande linearità e coerenza, ha suscitato talora forti contestazioni da parte di ambienti ecclesiastici tradizionalisti; ma che ha, nel contempo, favorito la nascita di profonde amicizie religiose e laiche – come non ricordare dom Benedetto Calati e Rossana Rossanda? – che hanno concorso ad arricchire la sua esperienza religiosa e civile (e di cui hanno fruito quanti hanno frequentato i suoi incontri). Una spiritualità soprattutto, nella quale la tensione alla trascendenza, lungi dal vanificare la dedizione nei confronti dell’uomo e della terra, ha fornito piuttosto lo stimolo all’esercizio di una limpida e feconda testimonianza in favore della città degli uomini.
Giannino Piana
Già docente di etica cristiana alla Libera Università di Urbino e di etica ed economia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino. Socio fondatore e membro del Gruppo di Riflessione e Proposta di Viandanti
[*] Il 26 aprile Adriana Zarri [1919-2010] avrebbe compiuto cento anni. La rivista Il Gallo, che aderisce alla Rete Viandanti, ha chiesto a Giannino Piana di ricordarla nella sua personalità, nella sua spiritualità e nel suo pensiero.
L’articolo è apparso su “Il Gallo” numero 800 (maggio 2019) pp. 8-9.
[1] Tra le opere più significative vanno ricordate:
È più facile che un cammello… Gribaudi, Torino 1975; Nostro Signore del deserto. Teologia e antropologia della preghiera, Cittadella, Assisi 1978; Erba della mia erba. Resoconto di vita, Cittadella, Assisi 1981; Un eremo non è un guscio di lumaca, Einaudi, Torino 2011; Quasi una preghiera, Einaudi, Torino 2012.
[2] Cfr. Con quella luna negli occhi, Einaudi 2014.
[3] Tu. Quasi preghiere, Gribaudi, Torino 1973.

LA PREGHIERA È LA CONTESTAZIONE PIÙ PROFONDA”. ADRIANA ZARRI, UNA MISTICA DEL NOSTRO TEMPO
«Due ginocchia prostate a terra in preghiera, due mani aperte nel cielo ad abbracciare l’universo»: si ritraeva così Adriana Zarri, monaco laico, teologa e scrittrice, nel suo primo libro, L’arcobaleno delle ore (Edizioni Il giorno, 1947). E così ha vissuto fino alla morte, come testimoniano le sue opere: con le mani sporche di mondo, di deserto, di preghiera. Con le mani inquinate di terrestrità pur nell’incessante anelito alle stelle, alle galassie, a Dio. Mani aperte nel cielo, con le gambe distese tra un filo d’erba e l’altro: questo significava per lei pregare. Vivere al vocativo: sentirsi chiamati e chiamare, come ceste vuote, recipienti nudi da riempire di Spirito, «in un appello perenne, in una continua esclamazione di stupore, incontrare […] Dio che pronuncia il nostro nome; e pronunciare noi il suo (Gv 20, 11-18) che è il nome stesso della vita» (Nostro Signore del deserto, Rubettino, 2013, p. 208; prima edizione: Cittadella, 1978).
Scrivere di Adriana Zarri (1919-2010) porta a chiedersi anzitutto se sia possibile raccontare un’esperienza di silenzio. Nel 1970 decise infatti – dopo una lunga attività teologica e giornalistica, spesso polemica e senz’altro libera e originale (fu la prima donna in Italia a occuparsi di teologia ed ecclesiologia, con senso critico e coraggiosa militanza) ⎼ di approfondire a tutto tondo la vocazione eremitica, trasferendosi inizialmente da Roma al castello di Albiano d’Ivrea, dove rimase per un po’ anche insieme ad altri monaci, e poi a Perosa Canavese, al Molinasso, una cascina abbandonata immersa tra i rovi, luogo che vide avverarsi la sua svolta di fede verso una più autentica adesione al monachesimo laico, di cui fu, già dalla giovinezza ⎼ segnata da un periodo trascorso in convento, nella Compagnia di San Paolo del Cardinal Ferrari ⎼ innovativa e radicale esponente. Una delle Lettere dall’eremo, scritta proprio durante l’insediamento al Molinasso, ne rievoca la bellezza e la posizione molto isolata: «La mia casa, nella sua parte posteriore, dà sui campi e, più oltre, su un bosco che costeggia un fiume. È il deserto. Nessuna voce se non, in lontananza, lo scorrere dell’acqua, nessuna strada, nessuna casa, se non, lontanissimo, aggrappate sui monti. Sul davanti invece la solitudine è più attenuata. C’è il viottolo poderale che porta alla strada. A un’opportuna distanza, che difende il mio silenzio (oltre, cioè, a mezzo chilometro), vedo passare le macchine, i trattori, le pecore… A un paio di chilometri ⎼ visibili d’inverno, con la caduta delle foglie ⎼ alcune case di contadini. Di notte, quando non c’è la nebbia, vedo le loro finestre illuminate. A volte (di rado, se il vento è favorevole) mi giunge perfino una voce umana. È la vita con le sue strade, con le sue case, le sue finestre accese, nella notte; e il lontano vociare degli uomini. Una voce che giunge di tanto in tanto non è un disturbo: è come una visita di umanità che ci riscalda l’animo e lo rende ancor più disponibile all’amore» (in «Rocca», 15 gennaio 1978).
Adriana Zarri..l'inquietudine della fede
Il 18 novembre 2010 moriva Adriana Zarri, poliedrica e singolare figura del cattolicesimo italiano, pubblicista, teologa, eremita e donna libera che ha saputo nella sua lunga esistenza, non priva di contraddizioni, tenere la linea della testimonianza cristiana come bussola e orizzonte in una società in tumulto come quella novecentesca. Nell’ambito del progetto 900Storie a cura del Centro Studi Piero Gobetti, la Fondazione Donat-Cattin ricorda, in una settimana a lei dedicata, la figura, il pensiero, l’azione culturale e la spiritualità. Il primo appuntamento si è tenuto lunedì 2 novembre sulle piattaforme social della Fondazione Donat-Cattin e del Polo del ‘900 con un breve filmato della teologa Morena Baldacci, liturgista e docente, che ha introdotto il tema della teologia vissuta e pensata, pregata e studiata da una donna, e un podcast con letture e brani scelti dalla produzione ricca e articolata del pensiero della Zarri. Giovedì 5 novembre, alle 18,00 in modalità streaming sui canali della Fondazione Donat-Cattin e del Polo del 900, si svolgerà un confronto con i teologi Ermis Segatti, Stella Morra e la storica Mariangela Maravaglia, autrice della prima biografia critica “Semplicemente una che vive. Vita e opere di Adriana Zarri” appena pubblicata da “Il Mulino”. Il confronto sarà inframmezzato da letture dell’attrice Eleni Molos tratte da brani di saggi della Zarri. Introdurrà i lavori Luca Rolandi, giornalista e ricercatore della Fondazione Carlo Donat-Cattin.
Adriana Zarri nasce a San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, nel 1919. I suoi studi e il suo impegno furono subito orientati al confronto con il Cristianesimo e con una chiesa cattolica da portare oltre la visione di Pio XII. È diventata, anno dopo anno, esperienza dopo esperienza, una delle più importanti testimoni di quella fedeltà al Vangelo che si coniuga – proprio in virtù di una verità che rende liberi – con la più schietta laicità. Antifascista, coinvolta nei problemi sociali, decisa a difendere la libertà di coscienza, si trasferisce a Roma dove studia teologia. Diventa giornalista e scrive dapprima su tutti i giornali e le riviste di area religiosa: l’«Osservatore romano», «Studium», «Servitium», «Il Regno», «Concilium», «Rivista di teologia morale» (RTM), «Rocca». In seguito collabora assiduamente a «Politica» e «Settegiorni» le riviste di punta su cui la sinistra democristiana si confronta con i fermenti ecclesiali, politici e sociali. Infine collabora a “Micromega” e a “Il Manifesto”. Naturalmente i tanti libri editi da Locusta, Cittadella, Borla, e dopo la sua morte da Einaudi. Ha partecipato anche a trasmissioni radiofoniche (Uomini e profeti) e televisive (la Samarcanda del primo Santoro). Note le sue posizioni molto dure anche contro la gerarchia e su temi etici che però non hanno offuscato nella memoria collettiva le sue radici profondamente evangeliche e fedeli alla dottrina cattolica, ovviamente sempre imperniati su conflitti di coscienza e di fede umana e divina. Poi all’inizio degli anni Settanta, dopo i vorticosi anni del post-Concilio, la sua presenza attiva alla Pro Civitate Christiana di don Giovanni Rossi ad Assisi, in molti gruppi del dissenso cattolico, senza mai una adesione e con molti distinguo e infine la scelta eremitica che in località diverse dell’area dell’eporediese, accolta dal vescovo di Ivrea mons. Luigi Bettazzi, che caratterizzerà gli ultimi 35 anni della sua esistenza. E’ sepolta nel cimitero canavesano di Crotte, una frazione di Strambino, dove visse gli ultimi anni nel suo eremo di Ca’Sassino. Per la sua tomba, in terra, scrisse lei stessa quella che definì “un’epigrafe d’erba”: “Non mi vestite di nero:è triste e funebre. Non mi vestite di bianco: è superbo e retorico. Vestitemi a fiori gialli e rossi e con ali di uccelli. E tu, Signore, guarda le mie mani. Forse c’è una corona. Forse ci hanno messo una croce. Hanno sbagliato. In mano ho foglie verdi e sulla croce, la tua resurrezione. E, sulla tomba, non mi mettete marmo freddo con sopra le solite bugie che consolano i vivi. Lasciate solo la terra che scriva, a primavera, un’epigrafe d’erba. E dirà che ho vissuto, che attendo. E scriverà il mio nome e il tuo, uniti come due bocche di papaveri”.
Verso un sapere dell'anima..Maria Zambrano
«L’anima si è rivolta alla sua interiorità, nel suo centro si è trovato quel punto d’identità, eterno e impassibile, che è dentro l’uomo, che non lo trascina fuori di sé come oggetto del mondo intelligibile. L’agognata unità si ottiene in altro modo, è un altro genere di unità in cui la vita ha preso, grazie a questo centro interiore, i caratteri dell’essere autentico; è unità vera ed eterna».
Maria Zambrano

Perché si scrive
María Zambrano
Scrivere è difendere la solitudine in cui ci si trova; è un’azione che scaturisce soltanto da un isolamento effettivo, ma comunicabile, nel quale, proprio per la lontananza da tutte le cose concrete, si rende possibile una scoperta di rapporti tra esse.
E’ una solitudine, però, che non ha bisogno di essere difesa, che non ha bisogno cioè di giustificazione. Lo scrittore difende la sua solitudine, rivelando ciò che trova in essa e in essa soltanto.
Se esiste un parlare, perché scrivere? Ma l’espressione immediata, quella che sgorga dalla nostra spontaneità, è qualcosa di cui non ci assumiamo interamente la responsabilità, perché non emana dalla totalità integrale della nostra persona; è una reazione sempre dettata dall’urgenza e dalla sollecitazione. Parliamo perché qualcosa ci sollecita e ci sollecita dall’esterno, da una trappola in cui ci cacciano le circostanze e da cui la parola ci libera. Grazie alla parola ci rendiamo liberi, liberi dal momento, dalla circostanza assediante e istantanea. Ma la parola non ci pone al riparo, né pertanto ci crea, anzi, il suo uso eccessivo produce sempre una disgregazione; per mezzo della parola vinciamo il momento e subito dopo siamo vinti da esso, dalla successione di momenti che superano il nostro assalto senza lasciarci rispondere. È una continua vittoria, che alla fine si trasforma in sconfitta.
E da questa sconfitta intima, umana, non di un singolo uomo ma dell’essere umano, nasce l’esigenza di scrivere. Si scrive per rifarsi della sconfitta subita ogni qualvolta abbiamo parlato a lungo.
La vittoria, del resto, può darsi solo dove si è subita la sconfitta, nelle stesse parole. Queste stesse parole avranno ora, nello scrivere, una diversa funzione: non serviranno più il momento oppressore, non serviranno più a giustificarci di fronte all’assalto del momentaneo, bensì, partendo dal centro del nostro essere raccolto in se stesso, ci difenderanno di fronte alla totalità dei momenti, di fronte alla totalità delle circostanze, di fronte alla vita intera.
C'è nello scrivere un trattenere le parole, come nel parlare c'è invece un liberarle, un distaccarsi da noi. Scrivendo si trattengono le parole, le si fanno proprie, soggette a ritmo, contrassegnate dal dominio umano di chi in questo modo le maneggia. Ciò indipendentemente dal fatto che lo scrittore si preoccupi delle parole, scelga coscientemente e le disponga in un ordine razionale, conosciuto.Al contrario, basta essere scrittore, scrivere spinti da questa intime necessità di liberarsi delle parole, di superare completamente la sconfitta subita, perché si verifichi questo trattenimento delle parole. La volontà di trattenere si trova già al principio, alla radice dell'atto stesso di scrivere e l'accompagna permanentemente. Le parole vanno così cadendo precise, in un processo di riconciliazione dell'uomo che le libera trattenendole, di chi le pronuncia con cauta generosità.
Ogni vittoria umana deve essere riconciliazione, ritrovamento di un amicizia perduta, riaffermazione dopo un disastro del quale l'uomo è stato la vittima; vittoria in cui non potrebbe esistere umiliazione dell'avversario, poiché in tal caso non sarebbe più vittoria, cioè gloria per l'uomo.
Sì, perché lo scrittore cerca la gloria la gloria di una riconciliazione con le parole, precedenti tiranne della sua potenza di comunicazione. Vittoria di un potere di comunicazione. Lo scrittore infatti esercita non solo un diritto richiesto dalla sua stringente necessità, ma anche un potere, una potenza di comunicazione che accresca la sua umanità, che porti l'umanità dell'uomo a limiti appena scoperti, ai limiti del valore umano, dell'essere umano, con l'inumano, ai quali lo scrittore giunge, vincendo nel suo glorioso incontro di riconciliazione con le parole tante volte traditrici. Salvare le parole dalla loro vanità, dalla loro vacuità, dando loro consistenza, forgiandole durevolmente, è lo scopo che persegue, anche senza saperlo, chi scrive davvero.
C'è infatti uno scrivere parlando, quello che scrive "come se parlasse", e già questo "come se" deve farci diffidare, poiché la ragione d'essere qualcosa deve essere ragione d'essere questo e questo soltanto. Fare una cosa "come se fosse" un'altra la impoverisce e le sottrae tutto il suo significato, ponendo in dubbio la sua necessità.
Scrivere diventa il contrario di parlare: si parla per soddisfare una necessità momentanea immediata e parlando ci rendiamo prigionieri di ciò che abbiamo pronunciato; nello scrivere, invece, si trova liberazione e durevolezza – si trova liberazione soltanto quando approdiamo a qualcosa di durevole. Salvare le parole dalla loro esistenza momentanea, transitoria, e condurle nella nostra riconciliazione verso ciò che è durevole, è il compito di chi scrive.
Ma le parole dicono qualcosa. Che cosa vuol dire lo scrittore e a quale scopo? Perché e per chi?
Vuole dire il segreto, ciò che non si può dire a voce perché troppo vero; le grandi verità non si è soliti dirle parlando. La verità di ciò che accade nel seno nascosto del tempo è il silenzio delle vite, e che non può essere detto. “Ci sono cose che non si possono dire”, ed è indubitabile. Ma è proprio ciò che non si può dire che bisogna scrivere.
Scoprire il segreto e comunicarlo sono i due stimoli che muovono lo scrittore.
Il segreto si rivela allo scrittore mentre lo scrive, non quando lo pronuncia. La parola rivela segreti soltanto nell'estasi, fuori dal tempo nella poesia. La poesia è segreto parlato, che deve essere scritto per fissarsi, non per essere prodotto. Il poeta esprime con la propria voce la poesia il poeta ha sempre voce, canta, o piange il suo segreto. Il poeta parla, trattenendo le parole nel dire, misurandole e creandole nel dire della sua voce. Si riscatta da esse senza renderle mute, senza ridurle al solo mondo visibile, senza cancellarle dal suono. Lo scrittore invece incide, fissa immediatamente senza voce. Perché la sua solitudine è diversa da quella del poeta. Allo scrittore nella sua solitudine il segreto si rivela non del tutto, ma in un divenire progressivo. Scopre a poco a poco il segreto nell'aria e sente il bisogno di fissare il suo tracciato per poter poi alla fine abbracciare la totalità della sua figura... Ciò anche quando possiede uno schema antecedente all'ultima realizzazione. Lo schema stesso dice già che c'è stato bisogno di fissarlo progressivamente in una figura, di comporlo linea per linea.
Ansia di svelare, ansia incontenibile di comunicare ciò che si è svelato; duplice tafano che assilla l’uomo, facendo di lui uno scrittore. Quale doppia sete è mai questa? Quale essere incompleto è costui che produce in sé tale sete, che si placa solo scrivendo? Scrivendo soltanto? No; solo per mezzo dello scrivere. Quello che lo scrittore persegue, è il puro scritto o qualcosa che si ottiene per mezzo dello scritto?
Lo scrittore esce dalla sua solitudine per comunicare il segreto. Quindi non è già più lo stesso segreto conosciuto da lui quello che lo colma, dato che ha bisogno di comunicarlo. Sarà piuttosto questa comunicazione? Se è così, l’atto dello scrivere è solo un mezzo, e lo scritto, lo strumento forgiato. Ma a caratterizzare lo strumento è il fatto che viene forgiato in vista di qualcosa, e questo qualcosa è ciò che gli conferisce la sua nobiltà e il suo splendore. E’ nobile la spada perché è fatta per il combattimento, e la sua nobiltà cresce se la mano d’opera l’ha forgiata con maestria, senza che questa bellezza di forma scalzi il suo primo significato: l’essere stata creata per la lotta.
Lo scritto è ugualmente uno strumento di cui si serve quest’ansia incontenibile di comunicare, di “pubblicare” il segreto trovato, e la bellezza formale che possiede non può sottrargli il suo primo significato: produrre un effetto, far sì che qualcuno venga a sapere qualcosa.
Un libro, finché non viene letto, è soltanto un essere in potenza, in potenza come una bomba inesplosa. Ogni libro deve avere qualcosa della bomba, di un evento il cui verificarsi minaccia e, anche semplicemente con la sua vibrazione, mette in risalto la falsità.
Come chi lancia una bomba, lo scrittore scaglia fuori di sé, dal suo mondo e quindi dall'ambiente che può controllare, il segreto trovato. Non sa che effetto produrrà a seguito della sua rivelazione, nè può dominarlo con la sua volontà. Perciò è una atto di fede, come mettere una bomba o appicar fuoco a una città; è un atto di fede, come lanciarsi su qualcosa la cui traiettoria non è in nostro possesso.
Puro atto di fede è lo scrivere e ancor di più perché il segreto rivelato non smette di essere tale per chi lo comunica scrivendolo. Il segreto si mostra allo scrittore, senza rendersi spiegabile; non smette cioè di essere un segreto per lui prima che per chiunque altro, e forse per lui soltanto, poiché il destino di chi in incappa per primo in una verità è quello di trovarla per mostrarla agli altri, lasciando che siano questi, suo pubblico a sviscerarne il significato.
È un atto di fede lo scrivere, e come ogni fede, di fedeltà. Lo scrivere richiede fedeltà prima di ogni altra cosa: essere fedeli a ciò che chiede di essere tratto fuori dal silenzio. Una cattiva trascrizione, un’interferenza delle passioni dell’uomo che è scrittore distruggeranno la fedeltà dovuta. È il caso dello scrittore opaco, che interpone le sue passioni tra la verità scritta e coloro a cui sta per comunicarla.
Il fatto è che lo scrittore non deve esibire se stesso, anche se da sé trae ciò che scrive. Trarre qualcosa da sé è tutto il contrario dell’esibire se stesso. E se il trarre da sé con polso sicuro l’immagine fedele dà trasparenza alla verità dello scritto, il porre con vuota incoscienza le proprie passioni davanti alla verità l’appanna e l’oscura. La fedeltà, per essere conseguita, esige una totale purificazione dalle passioni, che devono essere messe a tacere per far posto alla verità. La verità ha bisogno di un grande vuoto, di un silenzio in cui poter prendere dimora senza che nessun’altra presenza si mischi alla sua, falsandola. Chi scrive, mentre lo fa, deve far tacere le proprie passioni e, soprattutto, la sua vanità. La vanità è una gonfiatura di qualcosa che non è riuscita a essere e si gonfia per coprire il suo vuoto interiore. Lo scrittore vanitoso dirà tutto ciò che deve essere taciuto per mancanza d'entità, tutto ciò che per non essere davvero non deve essere messo in chiaro, e per dirlo tacerà iò che deve essere rivelato, lo passerà sotto silenzio o lo falserà con la sua intromissione vanitosa. La fedeltà crea in chi la rispetta la solidità, l'integrità del suo stesso essere. La fedeltà esclude la vanità, che consiste nell'appoggiarsi su ciò che non è, su ciò che non è verità. Questa verita' è quella che ordina le passioni senza sradicarle, le fa servire, le pone al loro posto, nell'unico punto da cui sostengono l'edificio della persona morale che con esse si forma per opera della fedeltà a quel che è vero. Così, l’essenza dell’uomo scrittore si forma in questa fedeltà con cui egli trascrive il segreto che rende pubblico, quale uno specchio fedele della sua figura, senza permettere alla vanità di proiettare la sua ombra, e di sfigurarla. Se infatti lo scrittore rivela il segreto non è per un atto di volontà, né per l’ambizione di mostrarsi qual è (cioè come non riesce a essere) davanti al pubblico. In realtà esistono segreti che esigono di per se stessi di essere rivelati, resi pubblici.
Quel che si pubblica serve perché qualcuno, uno o tanti, viva tenendo presente quanto è venuto a conoscere, perché viva in modo diverso dopo averlo conosciuto; serve a liberare qualcuno dalla prigione della menzogna, o dalle nebbie del tedio, che è la menzogna vitale. Ma forse a tale risultato non si può giungere se, filantropicamente, lo si assume come obiettivo in sé. Quel che pubblica, che lo si voglia o no, libera ciò che ha il potere per questo o per il contrario, ma senza tale potere non serve nulla il volerlo. Esiste un amore impotente, che si chiama filantropia. "Senza la carità la fede che muove le montagne non serve a nulla", dice san Paolo, e aggiunge: "La carità è l'amore di Dio".
Senza fede la carità decade ad ansia impotente di liberare i nostri simili da un carcere da cui non riusciamo a prevedere l'uscita. Dà la libertà solo chi è libero "La verità vi farà liberi". La verità ottenuta mediante la fedeltà purificatrice dell'uomo che scrive.
Ci sono segreti che hanno bisogno di essere resi pubblici e sono quelli che visitano lo scrittore approfittando della sua solitudine, del suo effettivo isolamento, che gli fa avere sete. Di un essere assetato e solitario ha bisogno il segreto per posarvisi sopra, chiedendogli, nel dargli progressivamente la sua presenza, che la vada fissando, per mezzo della parola, in tracciati durevoli.
Un essere appartato da sé e dagli uomini, e persino dalle cose, poiché solo nella solitudine si sente la sete di verità che colma la vita umana, una sete di riscatto di vittoria sulle parole che ci sono sfuggite tradendoci; sete di vincere per mezzo della parola gli istanti vuoti trascorsi, il fallimento incessante di lasciarci andare attraverso il tempo.
In questa solitudine assetata anche la verità, benché occulta, si rivela, ed è proprio lei che chiede di essere messa in chiaro. Chi l’ha vista a poco a poco non la conosce se non la scrive, e la scrive perché gli altri la conoscano. A rigore, se si mostra a lui, non è a lui in quanto individuo determinato, ma in quanto individuo del medesimo genere di coloro che devono conoscerla; e gli si mostra approfittando della sua solitudine e ansia, del suo far tacere lo schiamazzo delle passioni. Ma non è propriamente a lui che essa si mostra. Dal momento che lo scrittore conosce a seconda che scrive e scrive già per comunicare agli altri il segreto trovato, è in realtà a questa comunicazione, a questa comunità spirituale dello scrittore con il suo pubblico che la verità si mostra.
La comunicazione di ciò che è nascosto, che a tutti si offre mediante lo scrittore è la gloria; la gloria quale manifestazione della verità nascosta fino al presente, che dilaterà gli istanti trasfigurando le vite. È la gloria che lo scrittore spera pur senza dirselo è che raggiunge quando, ponendosi in ascolto con fede nella sua solitudine assetata, sa trascrivere fedelmente il segreto disvelato; la gloria di cui è soggetto degno dopo lo spontaneo martirio vissuto nel perseguire, catturare e trattenere le parole per adattarle alla verità. Per questa ricerca eroica la gloria ricade sulla testa dello scrittore, si riflette su di essa. Ma la gloria a rigore è di tutti; si manifesta nella comunanza spirituale dello scrittore con il suo pubblico e la trascende.
Tale comunanza tra scrittore e pubblico, contrariamente a quanto si crede, non si forma dopo che il pubblico ha letto l’opera pubblicata, bensì prima, nell’atto stesso in cui lo scrittore scrive la sua opera. La comunanza dello scrittore con il suo pubblico si crea pertanto nel momento in cui si rende manifesto il segreto. E pubblico esiste prima dell’eventuale lettura dell’opera, esiste dall’inizio dell’opera, coesiste con essa e con lo scrittore in quanto tale. E in realtà riusciranno ad avere un pubblico solo quelle opere che l’avevano già dal principio. Lo scrittore perciò non ha bisogno di porsi il problema dell’esistenza di tale pubblico, dato che esso esiste insieme a lui dacché ha cominciato a scrivere. Questa e' la sua gloria, che sempre giunge in risposta a chi non l'ha cercata né desiderata, anche se la presagisce e la desidera per trasformare con essa la molteplicità del tempo, trascorso, perduto, in un solo istante, unico, compatto ed eterno.
(Verso un sapere dell'anima, Raffaello Cortina 1996, pp.23-31)
Verso un sapere
dell'anima
María Zambrano
Ogni epoca trova una sua giustificazione di fronte alla storia per la scoperta di una verità che in essa acquista chiarezza. Quale sarà mai la verità della nostra epoca? Quale la sua manifestazione? Le verità hanno i loro precursori, che scontano con la pena dell'oblio la colpa di aver visto lontano.
Ma i precursori si riconoscono soltanto dalla pienezza della verità che li ha preceduti; solo dal possesso di questa verità si comprende il significato delle loro enigmatiche parole. Unicamente nella verità rischiarata si riconosce la verità seminascosta.
La rivelazione a cui stiamo assistendo nei tempi odierni è quella dell'uomo nella sua vita, rivelazione prodotta dalla Filosofia che, a sua volta, in essa si rivela. Dalla Filosofia che impiega i suoi strumenti razionali per gettar luce sulla Scienza, "Scienza delle scienze", si è tornati, senza tuttavia disperdere tale eredità, a un fatto sorprendente e assolutamente meraviglioso: la Filosofia, il pensiero in tutta la sua purezza, si lancia con l'impeto della passione non per divorare se stessa, come solo la passione fa, ma per indugiare opportunamente e portarci intatta la preda, prima che questa possa sfuggirle.
La passione da sola mette in fuga la verità, che, suscettibile e agile, riesce a sottrarsi alle sue grinfie. La ragione da sola non riesce a sorprendere la preda. Mentre passione e ragione unite, o meglio, la ragione appassionata che si slancia con impeto ma sa poi trattenersi al momento giusto, riescono a catturare senza danno la nuda verità.
La Filosofia è quindi, come diceva Platone parlando di Pitagora, "cammino di vita". La verità è l'alimento della vita, che tuttavia non la divora ma la tiene in alto, fissandola infine nel tempo, poiché "il tempo passa e la parola del Signore resta".
Così, l'essere consapevoli che nel tempo in cui viviamo si porta alla luce della- ragione una verità, ci conforta e ci aiuta a sopportare l'angoscia di passare con esso. "Tutto scorre" sarebbe la grande consolazione dei Quietisti se nel tutto non fossimo compresi anche noi, se con il tempo che passa non passasse anche la nostra vita. Aggrappandoci alla verità, alla nostra verità, legandoci alla sua scoperta per averla accolta dentro di noi, fissandola nel nostro essere, sentiamo che il nostro tempo non passa, o almeno non invano. Del suo passare rimane qualcosa, come nel fluire dell'acqua del fiume, che scorre e si trattiene. "Tutto scorre": scorre l'acqua del fiume, però il fiume stesso e il suo letto rimangono. È necessario che ci sia un percorso, e il percorso della vita è la verità.
È indispensabile che un fiume abbia un letto, altrimenti non si avrebbe un fiume ma un pantano. Potendo sfuggire, l'acqua avrebbe l'illusione momentanea di aver ottenuto la libertà, di aver riacquistato l'integrità della sua potenza. Ma la potenza si esaurisce in assenza di argini; anche con íl solo ostacolo rappresentato dalla sua estensione illimitata, la furia dell'acqua incanalata scenderebbe sopraffatta sulla pianura sterminata. Il letto serve al fiume tanto quanto la furia della corrente dell'acqua che scorre in esso. Ed è un bene che la vita si precipiti di corsa: lo sfuggire della semplice presenza fisica che cade nelle pieghe del tempo, l'angoscia di passare, si trasforma nella gioia di essere in cammino.
Ciò che fa la Filosofia quando è fedele a se stessa è precisamente mostrarci tale percorso, rivelandosi dunque una guida, un cammino di vita.
Ma tale cammino è composto inizialmente dai passi, tracce, e solo quando una linea segnata lo distingue dall'estensione inanimata che lo circonda possiamo vederlo, come accade ai giorni nostri. Cominciamo a sentire che la nostra vita scorre, vincolata e libera, nell'alveo di una verità che ci si rivela, e da lì iniziamo a comprendere pensieri di fronte ai quali saremmo forse rimasti insensibili, o al contrario colti da uno stupore, impossibile da tradurre in idee. Ci sono due modi di reagire di fronte ai pensieri che sono stralci o parti di un pensiero più radicale, ancora sconosciuto: uno è quello di rimanere insensibili alla verità che indicano, l'altro è di rendersi conto, per una forma di sensibilità generata dalla necessità che abbiamo di quella verità, che essa è lì ma non possiamo incontrarla direttamente. È la conoscenza a provocarci la sete che ci conduce alla roccia sotto cui sgorga l'acqua, senza però permetterci di portarla alla superficie.
Al contrario, quando viviamo in contatto con un pensiero ultimo, rivelatore, abbiamo anzitutto un orizzonte da cui ci sentiamo presi e anche uno strumento tecnico per situare e collocare con ordine í problemi, i pensieri; il cammino dà ordine al paesaggio e permette di muoversi verso una direzione precisa.
Così ci sentiamo di fronte alla rivelazione che ci offre la Ragione secondo il suo nuovo significato: quello di essere guida, cammino di vita.
In questo cammino avvertiamo la necessità di un sapere dell'anima, di un ordine della nostra interiorità. A ciò mirano gli scritti postumi di Max Scheler, Ordo Amoris e Morte e sopravvivenza. La sua impostazione deriva da Pascal e Spinoza da un lato, e da Nietzsche dall'altro. Il Pascal della frase ripetuta e abusata fino a farle dire il contrario: "Ci sono ragioni del cuore che la ragione non conosce", lo Spinoza dell'Amor Dei intellectualis e il Nietzsche che cercava un superuomo; come asse portante l'idea cristiana dell'uomo quale essere che muore e ama, che muore con la morte e si salva con l'amore.
Max Scheler reclama energicamente un ordine del cuore, un ordine dell'anima che il razionalismo, più che la ragione, ignora.
La cultura moderna ha espulso da sé l'essere totale dell'uomo per occuparsi soltanto del suo pensiero, dalla scoperta dell'uomo come res cogitans fino a scienze non propriamente filosofiche. Cartesio scrisse un Trattato sulle passioni, e qualche tempo dopo Spinoza un'Etica in cui la psicologia è ancora Metafisica, poiché lo studio e la classificazione naturalista delle passioni vengono indirizzati verso un sapere superiore dell'uomo e della sua vita; le passioni, quali strumenti, vengono studiate allo scopo di trovare una vita felice, una vita eterna. [1]
Immediatamente il processo si accelera, precipita. Leibniz e gli inglesi – Hume e Locke – scrivono solo sull'Intelletto umano. Kant elabora la sua Filosofia della ragione e del soggetto etico. Già qui si trova l'uomo, o meglio, è a partire da qui che comincia a esserlo, ma in un senso diverso da quello che ci interessa adesso.
Ma la cosiddetta "psiche", la cosiddetta "anima", che fine ha fatto? Fu incaricata la Psicologia scientifica dí studiarla, e la Psicologia applicò all'anima i suoi metodi scientifici. Che cosa siamo venuti a sapere dai suoi risultati?
In realtà l'anima rimaneva una sfida; da una parte infatti la Ragione dell'uomo illuminava la natura; dall'altra la ragione era íl fondamento del carattere trascendente dell'uomo, del suo essere e della sua libertà. Ma tra la natura e l'Io dell'idealismo rimaneva quel frammento di cosmo nell'uomo a cui si è dato il nome di anima.
Che cosa ne sappiamo? La natura, le forze cosmiche circondano l'uomo, ed egli ha saputo dominarle e penetrare alcuni dei loro segreti. "Le cose sono i limiti dell'uomo", ha detto Nietzsche, e questi limiti l'uomo arrivò a conoscerli. Tuttavia esistevano due saperi distinti: un sapere che la ragione domina e un sapere poetico, non dominabile, del cosmo, della natura. È curioso vedere come, nel secolo xix, in cui la ragione allarga il suo dominio sulla natura, sui "fenomeni della natura", l'uomo viva personalmente nella coscienza romantica dell'invincibilità della natura. La natura per il romantico è immensa, inafferrabile, infinita, ed egli la vede nei suoi momenti di furia estrema: nella tempesta, nei fulmini, nella "montagna scoscesa", nel "mare insondabile", negli "abissi senza fine", nei "precipizi profondi della terra e del cielo". L'uomo romantico, che sottomette con la propria ragione le forze della natura come mai era accaduto prima, parla della natura poeticamente, con terrore, quasi con spavento.
Ma la natura era, per l'uomo romantico, solo lo specchio in cui poter vedere riflessa la propria anima, della quale la ragione applicata alla scienza non gli diceva nulla; l'anima, della cui conoscenza veniva incaricata la nuova scienza chiamata Psicologia "resasi indipendente dalla Metafisica".
L'anima cercava se stessa nella poesia, nell'espressione poetica. [2] Cercava se stessa nella natura impetuosa. "Gli abissi insondabili", i "precipizi senza fine", "le tempeste fragorose" erano i suoi propri abissi, le sue proprie tempeste, ottenebrate a causa dell'abbandono della luce della ragione.
Così Max Scheler, formulando un sapere del cuore, può dire: "Ciò che l'espressione simbolica 'cuore' designa non è (come ve lo immaginate voí, filistei da un lato e romantici dall'altro) la sede di stati confusi, di impeti oscuri e indeterminati o di forze intense che spingono l'uomo da una parte all'altra".
L'uomo romantico, la cui ragione assoggettava l'universo per catturare il fulmine e scomporre l'acqua, si trovava contemporaneamente assoggettato dall'incanto dell'immensità del mare o dalla capacità fulminante della scarica elettrica, come da un potere divino. Era la sua stessa anima incompresa, abbandonata dalla luce della ragione, a dirigersi verso ciò che di inafferrabile ha la natura per l'uomo, spinta da un'irresistibile forza di compensazione. Per l'uomo i fenomeni naturali si possono ridurre a formule matematiche, ma da queste formule trascende qualcosa di innominabile, di irriducibile che lascia l'uomo meravigliato di fronte al mistero della sua presenza, di fronte alla sua impressionante bellezza.
E l'uomo romantico si trovava ad avere una entità così importante come l'anima, abbandonata a se stessa e cieca, dopo quasi due secoli di ragione. Vennero così a convergere, in una confluenza pericolosa e piena di fascino, queste due ragioni del cosmo: la natura, nella sua irriducibilità a formule matematiche, e l'anima umana, nella sua estraneità alla luce della ragione. Le tempeste, i naufragi, le onde increspate, gli abissi terribili, erano naturali e umani a un tempo, erano natura e anima, erano cosmici... Da qui l'originalità dello stile dell'arte romantica, il legame misterioso tra uomo e natura. Osservando le incisioni di Gustave Doré che illustrano la Divina Commedia, rimaniamo sempre un po' incerti: di che tipo di abissi si tratta? Sono realtà cosmiche o è la realtà della povera anima del condannato? Entrambe le cose: è la medesima realtà quella dell'abisso tenebroso, fenditura tra due montagne, e quella dell'abisso di disperazione in cui si trova l'anima condannata; natura e anima, parti dell'universo che si sono unite nell'arte romantica.
Ma sarà sempre così? Rimarranno senza luce questi abissi del cuore, rimarrà abbandonata l'anima con le sue passioni, al margine dei cammini della ragione? Ci sarà posto per lei in questo "cammino di vita" che è la Filosofia? La sua corrente dovrà continuare a straripare con il rischio di finire ridotta in una pozza? Potrà scorrere incanalata e libera all'interno del percorso che la verità apre alla vita? Ci sono sì ragioni del cuore, c'è un ordine del cuore che la ragione ancora non conosce.
In alcune occasioni però ha provato a conoscerle. Da differenti punti di vista l'uomo ha squarciato i veli che coprono l'ordine occulto della propria anima. È accaduto nelle religioni greco-orientali, nel cattolicesimo (il protestantesimo, quasi sempre puritano, avvertiva probabilmente una certa repulsione verso questo scrutare le viscere umane), in qualche filosofo che volle lasciare la propria anima intagliata come un brillante, incastonando le passioni in geometrici cristalli di teoremi, chiose e postulati, in quelle carte postume che oggi possiamo leggere anche nella nostra lingua; [3] o in un altro pensatore ebreo, Spinoza, che andò vagando di religione in religione, errando per le differenti credenze, come altri fratelli della stessa stirpe per vari paesi. Questi due pensatori, pur a distanza di tre secoli e con molte differenze, in quanto segnati da un comune destino religioso di peregrinazioni, hanno voluto fondare un ordo amoris. Hanno parlato in forma distinta, perché distinti sono i loro strumenti e i loro metodi, ovvero il loro modo di avvicinarsi alle cose; ma di fronte all'interrogativo indifferibile che sentiamo oggi formulare intorno alle ragioni del cuore che la ragione ancora non conosce, essi si distinguono dagli altri per la loro attenzione alle realtà profonde dell'anima, che hanno voluto illuminare con la ragione.
Ma il nostro sguardo ripercorre íl ciclo della cultura che ci è familiare, cercando un sapere sulla graziosa, adulata e abbandonata "psiche", e ciò che si vede anzitutto è il carattere frammentario e come privo dí sostegno (a eccezione forse di Aristotele e Spinoza) di quanto si è detto su un argomento tanto importante e pericoloso; o al contrario un'architettura eccessiva, una rigidità derivata dall'essere giunti a questo tipo di sapere a partire da a priori, etici o religiosi (in quest'ultimo caso, senza dubbio molto più fecondi e flessibili). O eccesso di architettura, di ipotesi, oppure mancanza di fermezza e di chiarezza piena in ciò che è stato afferrato. La farfalla in alcuni casi muore, in altri vola via. Raramente si è verificato quel miracolo di agilità della mente che le permette di trattare adeguatamente l'anima, di costruire una rete fatta apposta per catturare la realtà sfuggente della "psiche".
Dato che l'anima non è l'unica realtà dell'uomo, il sapere che la riguarda deve essere inserito in un sapere più ampio e radicale, come la navata di un edificio deve essere sostenuta dalla meccanica dell'intero edificio.
Ma questo sapere più ampio, nel quale può svilupparsi il delicato sapere intorno all'anima, non poteva essere un sapere qualsiasi, una Filosofia qualunque. Era necessaria un'idea dell'uomo nella sua integrità e un'idea della ragione ugualmente nella sua integrità. Finché, per esempio, l'uomo era un ente razionale e nient'altro e la ragione una ragione matematica, come poteva darsi un sapere dell'anima? Da questo punto di vista [4] poteva esserci solo un Trattato sull'anima, di Spinoza, in cui l'anima è l'idea adeguata del corpo e nient'altro.
Era necessario imbattersi in questa nuova rivelazione della Ragione, alla cui aurora assistiamo come alla Ragione della vita intera dell'uomo. In essa intravediamo sì la possibilità di un tale sapere, che sentiamo tanto indispensabile. Il percorso che questa verità apre alla vita permette e addirittura richiede che il fluire della "psiche" scorra in esso. Almeno così speriamo.
Quanti saperi, risultato di una vita di lotta contro le passioni, saranno stati passati sotto silenzio per mancanza di orizzonti razionali in cui inserirsi, per mancanza di coordinate adeguate a cui far riferimento! Senza l'orizzonte di un sapere radicale il sapere sulle passioni, amore e odio, rimaneva privo di sostegno, sospeso in un'aria terribile di confessione, o peggio, di confidenza. Bisognava avere un marcato cinismo e una sorta di intimo compiacimento nel parlare di sé per mettere insieme la propria esperienza, quella amorosa ad esempio. Che struttura darle? Abbiamo un Dell'amore di Stendhal, tentativo audace in pieno romanticismo di non lasciare sospeso nel "vago e ineffabile" l'argomento amoroso. E senza pensarci ecco che ci siamo imbattuti in un altro di quegli uomini che non rimasero indifferenti alla vita dell'anima, lasciando in silenzio la ragione.
Filosofi, romanzieri, poeti, hanno gettato luce su qualcosa inerente alle ragioni del cuore, alle viscere dell'uomo; tra le religioni, quelle greco-orientali e la Chiesa cattolica, che per fortuna non disdegnò completamente di trarre qualche beneficio dal sapere orientale.
In Grecia ritroviamo gli oracoli a parlarci dell'anima, o almeno ad alludervi. Che cosa rappresentano gli oracoli nella vita greca? Se la Filosofia inizia con Talete a interrogarsi sull'essere delle cose, l'oracolo soddisferà quest'altro interrogativo: Chi sono io? Qual è il mio destino? Che cosa devo fare di fronte a questa o a quella situazione? E vediamo persino Socrate consultare l'oracolo di Delfi, ascoltare il suo daimon interiore. I greci andavano a consultare il Dio che abitava il santuario, il piccolo tempio che non separava la divinità dal paesaggio che lo circondava; interrogavano il Dio e si abbandonavano a un'orgia di purificazione.
Nei riti orfici e nel culto di Dioniso l'anima, per conoscersi, si immergeva nella natura, come accadrà nel romanticismo, ma in maniera molto diversa. Se il romanticismo umanizza la natura e cerca in essa la plasticità, la figura, nel culto di Dioniso l'anima cerca la musicalità insita nella natura, il suo impeto puro. È un bagno cosmico, un'immersione dell'anima nelle fonti originarie dell'impeto della vita, una riconciliazione dell'anima con la vita. "Le situazioni di massima esaltazione corporea portano con sé un delizioso annullamento nell'unità cosmica." (Ortega y Gasset, Vitalità, Anima, Spirito). L'orgia è una riconciliazione dell'anima, che cominciando a sentire se stessa soffre, con la natura; è un appello ai poteri cosmici che l'uomo fa quando le viscere della vita gli provocano dolore. È un ritorno alle fonti originarie della vitalità che lo purifica dalle ombre dell'interiorità, da qualcosa che comincia a sentire suo, dimora di silenzio e solitudine.
La solitudine è stata avvertita in principio come un peccato, come un qualcosa che produce rimorso. Ogni distanza che l'uomo prende dal resto dell'universo gli crea una solitudine che inizialmente genera terrore e rimorso, e dalla solitudine appena conquistata ritorna ad abbracciare ciò che ha da poco lasciato.
Così l'anima greca, quando cominciava a sentirsi separata dal cosmo, riccorreva ai misteri di Eleusi e al culto di Dioniso in cerca di una riconciliazione, con la speranza di liberarsi dei suoi dolori, e anche con l'allegria di chi ritrova le proprie origini. Orgia, purificazione, abbandono momentaneo dei dolori della recente solitudine.
Il romantico, al contrario, non pretende di immergersi nel dionisiaco della natura, bensì si unisce alla sua plasticità. Cerca sì l'impeto, ma nella figura che lo ha attraversato. Il romantico lega la propria anima alla natura affinché se ne riempia, se ne impregni, come nelle notti di luna che amava tanto descrivere.
Ma l'oracolo significava altro nel suo riferimento alla "catarsi" orfica e all'orgia. Era piuttosto un'ansia dell'anima per il razionale, la speranza di uscire dal dubbio più che di liberarsi dai dolori, di risolvere l'indecisione dell'individuo di fronte alle situazioni della vita: l'affanno di conoscere per saper cosa fare. Anticipava il "conosci te stesso" socratico. In un certo modo Socrate diventò l'oracolo per ogni cittadino di Atene che non aveva paura di pensare, ovvero di divenire a sua volta oracolo di se stesso.
I grandi filosofi greci non rinunciarono al compito di gettar luce sull'entità misteriosa dell'anima: non lo fece Platone, e neppure Aristotele, che fornirono i fondamenti di tutto il sapere cristiano-medioevale.
Lasciando da parte ciò che la ragione ha detto dell'anima quando ha gettato la propria luce su di essa, e anche per meglio considerare queste ragioni, sarebbe opportuno vedere prima più chiaramente in che modo l'uomo ha sentito la sua anima, e come ha rapportato se stesso al mondo e ai suoi due poli, che potremmo chiamare Dio e Natura. Se l'uomo non consiste nella propria anima – e oggi lo vediamo con chiarezza –, come ha percepito questo frammento di cosmo che dimora in lui? Se pensiamo a ciò che chiamiamo Io, lo vediamo circondato da strati concentrici sempre più distanti ed estranei; in primo luogo dentro di sé, poi in ciò che ormai non è più uomo. In questi strati ritroviamo l'anima. Che posto occupa? Qual è il suo ruolo?
Tra l'Io e la natura al di fuori si interpone ciò che chiamiamo anima. Abbiamo già avuto modo di osservare molto brevemente con quali forme distinte l'anima ha cercato se stessa attraverso la natura nelle religioni greche e nell'arte romantica, ma si è anche detto che "Dio si trova nel fondo dell'anima".
Come accade nel sistema planetario in cui viviamo, questi tre corpi, Dio, la Natura e l'Uomo vanno tessendo con le loro orbite un dramma. Si verificano anche eclissi, e allora un'ombra cade su uno dei corpi. L'anima dell'uomo che ruolo gioca in questo dramma, in queste distanze ed eclissi? Dell'anima si è predicato con insistenza la purezza, la trasparenza. Tale anelito profondo di "catarsi" da parte dell'uomo, tale desiderio perenne di possedere un'anima chiara e trasparente, non indicherà una necessità più profonda? Trasparente è un aggettivo che utilizziamo per indicare ad esempio la qualità di un cristallo, di qualcosa che è un mezzo per lasciar passare qualcos'altro. La profondità, qualità che attribuiamo ugualmente a un'anima superiore, non è una condizione contraria. Un'anima chiara e profonda... per quale scopo ultimo della sua vita deve possederla l'uomo? Che cosa deve far passare attraverso la trasparenza dell'anima, quali radici profonde devono albergare nella sua profondità?
A seconda dei diversi momenti della Storia, l'anima è stata preferibilmente collegata a una parte dell'universo e messa in relazione ad altri elementi che nell'uomo non sono anima. Sarebbe interessante scoprire le forme proprie con cui l'anima si è espressa, tralasciando per il momento ciò che l'intelletto ha detto dell'anima a esso sussunta; scoprire quelle ragioni del cuore che è il cuore stesso ad aver trovato, approfittando della sua solitudine e abbandono.
NOTE
1. "E intorno all'anima parleremo soltanto di quelle cose che ci possono portare, come per mano, alla conoscenza di una vita felice." B. Spinoza, Etica, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1987, p. 67.
2. Mendelssohn disse, nel 1765, che se la prosa appaga con la ragione, la poesia vuole altro.
3. M. Scheler, "Muerte y supervivencia", "Ordo Amoris", Revista de Occidente, Madrid 1934.
4. Dal punto di vista dell'uomo come essere pensante e della ragione come ragione matematica.
(FONTE: Verso un sapere dell'anima, Raffaerllo Cortina Editore 1996, pp. 11-22)
La salvezza nello sguardo..Simone Weil

Debbo desiderare di avere, tendere di avere una concezione della misericordia divina che non venga meno e non si modifichi, qualunque evento il destino mandi e che possa essere comunicata a qualunque essere umano senza costituire per lui un oltraggio. Una simile concezione può essere solo frutto di ispirazione.
Simone Weil
Simone Weil: ritratto e itinerario..La porta è davanti a noi
Francesca Simeoni
La porta è davanti a noi; a che serve desiderare?
Meglio sarebbe andare senza più speranza.
Non entreremo mai, siamo stanchi di vederla.
La porta aprendosi liberò tanto silenzio
Che nessun fiore apparve (...)
Solo lo spazio immenso
apparve d'improvviso da parte a parte, colmò il cuore,
lavò gli occhi quasi ciechi sotto la polvere. [3]
Una vita esigente
Simone Weil: donna forte, esagerata e scrupolosamente attenta alla bellezza del mondo, storico, fisico e interiore. Imbarazzante tentare di tracciarne un ritratto o di condensarne il pensiero: si ha l'effetto di mancanza e di insufficienza proprio dei profili di grandi pensatori, di grandi uomini e donne. La sua vita [4] ed i suoi scritti svelano un carattere poliedrico, eppure chiaramente e intimamente unificato, tratto tipico del femminile, capace di sfumature e di coesistenza nella complessità.
Nacque nella Parigi dei primi del Novecento (3 febbraio 1909) in una famiglia medio-borghese. I genitori, ebrei di origine ma non legati ad alcuna tradizione religiosa, avevano saputo creare un ambiente familiare ricco di stimoli culturali per i figli Simone e André.
Negli studi la piccola Simone era vivace e molto brillante. Durante gli anni al liceo Henry IV trovò un punto di riferimento in Alain, nome col quale si presentava il filosofo Emile Chartier, suo professore, docente il cui atteggiamento socratico, scettico e aperto segnò la formazione di diverse generazioni di intellettuali francesi, mettendo i suoi studenti a contatto diretto con i grandi filosofi e suscitando anche in Simone Weil l'amore per la libertà incondizionata del pensiero.
Nel 1928 entrò all'École Normale Supérieure e nel '31 ne uscì con il titolo per l'insegnamento della filosofia. Inizia così la sua professione di docente nei licei femminili di Le Puy, Auxerre e poi Roanne e Bourges. Sono i primi anni Trenta, anni di dura crisi economica e mentre insegna, Simone Weil avverte la necessità di condividere la sorte degli operai suoi concittadini: inizia così un'intensa attività sindacale, condivide con loro il suo stipendio, partecipa all'organizzazione di corsi serali per minatori, si mette insieme agli "sventurati", non per essere prima tra gli ultimi, ma per essere. Questa condivisione, fino all'impiego in diverse fabbriche parigine, è accompagnata da una tagliente riflessione critica, sociale e politica, sulla condizione dell'oppressione e della libertà dell'uomo contemporaneo. [5]
Partecipa intensamente alla storia e al suo tempo, si reca diverse volte in Germania per testimoniare gli effetti della crisi. Nel 1936, allo scoppio della guerra civile in Spagna, avverte l'impossibilità di restarne fuori e si arruola tra le file anti-franchiste. Per problemi fisici è costretta a rientrare e, a causa di frequenti emicranie che la colpiscono fin da bambina, si reca in Svizzera e in Italia per le cure. Così nella primavera del 1937 visita Milano, Firenze, Roma: è un periodo sereno e di grandi emozioni per la sua insaziabile ricerca.
Ad Assisi ha inizio per lei la scoperta di una parte fondamentale della sua umanità, una svolta repentina e decisiva, che riconoscerà l'anno dopo durante la Pasqua nell'abbazia benedettina di Solesmes. ln modo personalissimo e netto fa l'esperienza dell'amore divino in Cristo, che accende la sua spiritualità, già intensa e ostinata. Si immerge così nella lettura della Bibbia, riprende i classici greci, esplora gli scritti dell'antico Egitto.
Nel 1940 allo scoppio della guerra è costretta a rifugiarsi a Marsiglia con i genitori, dove rimane fino al '42 e trascorre uno dei periodi più fecondi della sua vita spirituale e della sua ricerca intellettuale e ricco di intensi scambi umani: conosce il padre domenicano Perrin e Gustave Thibon, suo grande amico. Le riflessioni prolifiche di questi anni sono raccontate nei Quaderni e negli scritti e nelle lettere raccolti in Attesa di Dio. [6]
Dopo alcuni mesi negli Stati Uniti, nel 1942 si reca in Inghilterra dove si arruola nelle file di "France Combattante", l'organizzazione della resistenza francese in esilio, desiderando di partecipare della vita dei soldati al fronte come infermiera. Muore di tubercolosi in un sanatorio di Ashford il 24 agosto del 1943.
Ogni dettaglio della sua insaziabile vita - le scelte, gli incontri, la forza critica e la determinazione nella condivisione con gli oppressi, fino alle più alte pagine vibranti di un'intensa vita spirituale - è unificato nella sua onesta ricerca di verità, sintesi della sua figura. [7]
Un'intelligenza cordiale
Attraversando gli scritti della pensatrice parigina si ha la percezione di un pensiero che evita ogni sistematizzazione, anzi, che si pone come contrario di ogni sistema, procedendo a ritmo serrato attraverso contraddizioni, corrispondenze, intuizioni penetranti ed evocazioni. L'adesione ad una nitida e cogente coerenza del pensiero lascia spazio infatti alla resistenza della realtà e delle relazioni umane, ponendo al centro una ricerca di senso che tiene insieme rigore razionale, sostanza umana e capacità di grazia. In questa filosofa, dunque, si respira l'impossibilità di una struttura di pensiero chiusa capace di spiegare il tutto, impossibilità che siede nel cuore della cultura contemporanea. Ciò accade anche perché il suo comprendere filosofico è frutto «della sua intelligenza cordiale, indissociabile dal suo essere al mondo con la massa degli oppressi, degli sfruttati, degli schiavi. Se è permesso di "ordinare" i suoi scritti, di trarci dei temi, dei motivi, degli accordi dominanti, questa filosofa di professione non aveva un progetto filosofico. Ella si vuole solamente servitrice docile di una verità che l'abita, portatrice vigorosa di un messaggio che la supera». [8] Vi è infatti un intimo e coltivato legame tra attenzione, amore del prossimo, gusto della bellezza del mondo e amore di Dio che attraversa le pagine weiliane e da cui traspare la sua intelligenza nutrita di passione e aderenza alle cose. L'insieme dei suoi scritti restituisce dunque l'impressione non tanto di un sistema, bensì di un itinerario [9] speculativo ma anche umano e spirituale, percorso che ha un vero valore performativo in chi si pone sulle sue tracce e l'ascolta.
Stare sulla soglia
Seguire Simone Weil nelle sue riflessioni impone al lettore un movimento oscillante continuo tra particolare ed universale, tra intuizioni del sovrannaturale e considerazione del peso concreto della necessità e della materia, tra grazia e pesanteur, [10] due termini chiave per tentare una lettura trasversale del suo pensiero. Nel punto di equilibrio di questa oscillazione risiede la capacità di «dimorare sulla soglia» [11], lì dove l'intelligenza e la condizione umana arrivano ad un ostacolo contro cui cozzano, ad una porta che non si apre, e si esercita la virtù del desiderio e la capacità dell'attesa. La soglia è il luogo in cui i contrari si toccano, in cui la sventura diventa esperienza della grazia, in cui la necessità dura del mondo diventa la sua bellezza, in cui lo svuotamento di sé diventa accoglienza dell'amore divino, in cui la creazione diventa atto di rinuncia di Dio al proprio potere. La centralità della soglia permette inoltre di intuire come il pensiero e l'impegno politici della giovane Weil siano inscindibili dalla parte mistica delle sue opere mature: anche quando è mistica, Simone è ben aderente alla materia; quando parla dell'amore sovrannaturale di Dio, lo associa sempre all'amore dello sventurato e alla bellezza del mondo quale è. «Del resto il suo lavoro non consiste mai nel negare l'umanità dell'uomo, la sua finitezza, il suo limite, la sua carnalità; si tratta piuttosto di concentrarsi su di essa a tal punto e con tale intensità da trasfigurarla, da trapassarla, da coglierla nella sua profondità essenziale, che fa emergere il soprannaturale come l'essenza più profonda del naturale» [12].
Anche riguardo al proprio percorso cristiano Simone Weil rimane sulla soglia: si sente chiamata a stare con gli ultimi anche quando si tratta di chi è escluso dalla Chiesa, a trovarsi nella «intersezione tra il cristianesimo e tutto ciò che è al di fuori di esso» [13]. Per questo, seppur animata da un fervente desiderio di adesione a Cristo, decide di non battezzarsi e di rimanere esterna alla Chiesa, con chi non crede o ne è escluso. Delicatezza e determinazione eloquenti per ogni uomo di fede.
Attendere e fare attenzione
L'atteggiamento della soglia è quello dell'attesa, di chi non forza la porta, ma si fa vuoto di pretese per vedervi oltre. Il tema dell'attendere emerge con nitidezza negli scritti raccolti in Attesa di Dio, dove spunta una breve dispensa [14] preparata per gli studenti dell'amico padre Perrin nella quale Simone Weil, ormai esonerata dall'insegnamento ma per molti anni docente e studente, concentra alcune preziosissime e illuminanti riflessioni per una concezione cristiana degli studi. Lo sforzo che innerva l'esercizio di studio e di comprensione, nota l'autrice, è fatto tutto d'attenzione. indipendentemente dai risultati e dalle nozioni acquisite; tale sforzo non viene mai disperso: esso costituisce una riserva, un allenamento fondamentale che porta i propri frutti, in modo inatteso, nella preghiera. Ogni sforzo d'attenzione, se abitato dal desiderio profondo di verità e se orientato dalla gioia dell'intelligenza, crea un'attitudine rara e di marca squisitamente spirituale. Il pensiero infatti si allena ad attendere, senza ancora aver ottenuto il proprio oggetto, ma semplicemente desiderandolo. In questo modo si crea quello svuotamento che è pura recettività e che permette di accogliere ciò che giunge. Questa capacità di svuotamento e attesa è la sostanza della preghiera, che costringe Dio a scendere verso l'uomo. Ed essa non fruttifica solo nel senso dell'amore di Dio, bensì anche rende capaci di quell'attenzione fine e svuotata di sé verso il prossimo e di quello sguardo capace di vedere lo sventurato, che lo salva.
Rinuncia, attesa e grazia sono dunque i movimenti dell'amore: dall'attenzione dello studio al tirocinio del prossimo, fino al "sacramento" che è l'incontro con l'oppresso: in queste soglie la ricerca di Simone Weil si sofferma, intravvedendovi nitido lo spazio implicito dell'amore di Dio. Un pensiero ferreo e delicatissimo, cui solo una pensatrice poteva donare la propria sensibilità.
"Ogni sforzo d'attenzione,
se abitato dal desiderio profondo di verità
e se orientato dalla gioia dell'intelligenza,
crea un'attitudine rara
e di marca squisitamente spirituale.
Il pensiero infatti si allena
ad attendere, senza ancora aver ottenuto il proprio oggetto,
ma semplicemente desiderandolo.
ln questo modo si crea quello svuotamento
che è pura recettività e che permette
di accogliere ciò che giunge."
Bibliografia essenziale delle Opere di Simone Weil in edizione italiana
- Attesa di Dio, a cura di M.C. Sala, Milano 2008.
- La condizione operaia, a cura di F. Fortini, Milano 1994.
- La prima radice, a cura di E. Fortini, Milano 1990.
- La Grecia e le intuizioni pre-cristiane, a cura di M. Harwell Pieracci e C. Campo, Roma 1999.
- L'ombra e la grazia, a cura di E. Fortini, Milano 2002.
- L'amore di Dio, a cura di G. Bissaca e A. Cattabiani, Roma 1979.
- Quaderni, a cura di G. Gaeta, Milano; vol. I, 1982; vol. II, 1985; vol. III, 1988; vol. IV. 1993.
- Lettera a un religioso, a cura di G. Gaeta, Milano 1996.
Simone Weil
La Salvezza nello sguardo
Compassione e gratitudine.
«Nell'amore vero non siamo noi ad amare gli sventurati in Dio, è Dio in noi che li ama. Quando siamo nella sventura, è Dio in noi che ama coloro che ci vogliono bene. La compassione e la gratitudine discendono da Dio, e quando vengono donate attraverso uno sguardo, Dio è presente nel punto in cui gli sguardi si incontrano» (1).
L’immediatezza dello sguardo umano verso la sventura -che porterebbe all'intervento, ad un gesto di solidarietà- cede il passo all'elaborazione delle accuse nei confronti dell’oppresso. La calunnia è funzionale all'indifferenza, serve a giustificare il fatto di non prendersi cura dell’altro. La compassione nella società che corre solo in avanti, calpestando e lasciando morti e feriti, è un atto illegale. La gratitudine nella società dello scambio e della mercificazione delle relazioni sociali è una forma di obiezione di coscienza. Ma quando qualcuno si sofferma sul dolore del diseredato, scegliendo la condivisione e facendosi carico della propria parte di responsabilità umana, Dio può irrompere nella storia. La sbarra che preme sulle spalle degli oppressi viene, così, sollevata, riprende il respiro della speranza.
Bellezza.
«Tutto ciò che ha qualche rapporto con la bellezza deve essere sottratto al corso del tempo. La bellezza è l’eternità in questo mondo» (2).
La bellezza è soprattutto benevolenza, per questo è eterna.Apre brecce da cui penetra la luce divina che rischiara le tenebre della sopraffazione. Scava fenditure in cui si rifugia l’anima in cerca di consolazione (3). L’atto gentile restituisce il senso all'esistenza continuamente negato dalla violenza.
Compassione, gratitudine e bellezza indicano, quindi, una prospettiva diversa da quella accettata e predicata a reti unificate. Occorre prenderne coscienza ed iniziare ad agire di conseguenza. «Una delle verità fondamentali del cristianesimo, oggi misconosciuta da tutti, è che lo sguardo è ciò che salva» (4).
(1) Simone Weil, Attesa di Dio, a cura di Maria Concetta Sala, Adelphi, Milano 2008, p. 112
(2) Simone Weil, Attesa di Dio, a cura di Maria Concetta Sala, Adelphi, Milano 2008, p. 131
(3) Cfr. Cantico dei Cantici 2,14
(4) Simone Weil, Attesa di Dio, a cura di Maria Concetta Sala, Adelphi, Milano 2008, p 149

Simone Weil
Ritirarsi da sé
per fare spazio all'altro
Donatella Di Cesare
Quanti filosofi hanno lavorato volontariamente in fabbrica? Nessuno? Lo ha fatto una donna: Simone Weil. Il saggio “La condizione operaia”, che testimonia la sua esperienza in tre diversi impianti metallurgici alla periferia parigina, è un documento raro che richiama la filosofia al suo impegno politico. Come capire la fame degli altri? Come immaginarne gli stenti, la fatica, l’umiliazione? L’empatia si ferma spesso alle buone intenzioni. Molti si ritraggono nell’indifferenza. Non sembra possibile né provare davvero angoscia, né sollevarsi per lo sdegno. Lì il dolore è un destino ineluttabile; qui il più lieve malore va attutito in una iperbolica concentrazione su se stessi. Quando, nel dicembre 1934, Simone Weil si fece assumere come fresatrice alla Renault, voleva dimostrare che il comunismo, come lei lo intendeva, non era solo l’ideale politico di una comunità futura, ma significava anzitutto condivisione immediata dell’esistenza degli sfruttati.
Come sopravvive quotidianamente un’operaia? A rispondere è una professoressa di filosofia che accanto a lei, nella catena di montaggio, compie gli stessi gesti, prova sul suo corpo lo stesso affanno, sperimenta la stessa oppressione. Per poter poi denunciare, nel suo “Diario di fabbrica”, la monotonia degradante, l’atomizzazione subdola, la concorrenza che ostacola ogni fraternità. «Stando in officina, confusa agli occhi di tutti e ai miei propri occhi con la massima anonima, la sventura degli altri mi è penetrata nell’anima e nella carne».
Essere schiavi senza sapere di esserlo: questa è la condizione degli operai. Ripiegati sulle macchine, finiscono per rassegnarsi docilmente rinunciando a pensare. È ciò che colpisce di più Weil. La sventura è il terribile mistero di ogni esistenza. Ma per gli operai la sventura si raddoppia, perché non sono in grado di articolarla, se non ricorrendo a frasi fatte e a quel gergo asettico che costituisce il grande problema del movimento sindacale.
Le rivendicazioni non bastano. Non sono solo i rapporti di produzione a creare la schiavitù, che riaffiora anche dove subentra lo Stato al posto dell’imprenditore. L’errore è credere, come fa Marx, che il progresso possa lenire, o addirittura mutare, la sorte degli operai. Il prodotto del capitalismo è la mortificazione del lavoro. Guardando anche agli effetti della tecnica sulla vita, e a quella che si potrebbe chiamare un’operaizzazione di massa di ogni impiegato, Weil avverte che il lavoro va completamente ripensato. Ed è in fondo questo compito che lascia in eredità.
Radicale, appassionata, sincera, intransigente, irriducibile, pronta a qualsiasi sacrificio e refrattaria a ogni compromesso – questo è il ritratto di Simone che emerge dai suoi scritti e dalle testimonianze di chi l’ha conosciuta. Qualcuno potrebbe definirla oggi un’estremista. Potremmo facilmente immaginarla in un centro sociale. Fuori dai partiti, che criticò aspramente, fu vicina alla rivista sindacale «Révolution prolétarienne».
Era stata una trotskista tanto critica, da tener testa, in un leggendario scontro, allo stesso Trotsky, accusato di non riconoscere nello Stato sovietico un apparato repressivo. Non sorprende di trovarla nel 1936, durante la guerra civile in Spagna, nella colonna degli anarchici di Buenaventura Durruti. Proprio l’anarchismo sembra oggi uno dei motivi più interessanti della sua riflessione – nessuna romanticheria nostalgica, bensì un’indicazione preziosa in tempi di sovranismo.
Weil correva incontro alla storia. Desiderava seguirne i drammi da vicino, proprio nei luoghi dove si stavano compiendo svolte epocale. Fu per ciò che nel 1932, incurante di poter essere, in quanto ebrea, vittima designata, si recò a Berlino. Hitler era ormai a un passo dal potere. Con quel suo stile da giornalista-filosofa, che legge il presente senza rinunciare alla profondità, riconobbe nella tragica sconfitta della sinistra tedesca, divisa e paralizzata, quella sconfitta da cui la sinistra solo a fatica avrebbe potuto riprendersi.
L’hitlerismo non era barbarie. Piuttosto era il potere dello Stato che si manifestava, privo di veli, facendo leva sul vecchio mito nazionalistico della patria. Ma l’ideologia nazista era «straordinariamente contagiosa» anche a sinistra, dove l’idea di Stato continuava a esercitare un fascino oscuro, come mostrava la deriva sovietica, autoritaria e tecnocratica. Il patriottismo è «l’amore dello schiavo per il suo padrone». Finché la sinistra non metterà in discussione lo Stato nazionale, il fascismo resterà la minaccia immanente in ogni repubblica democratica. Solo l’anarchismo è l’argine al pericolo sovranista.
«Contemplare il sociale è una purificazione altrettanto efficace che ritirarsi dal mondo, e dunque non ho avuto torto ad accostare per tanti anni la politica ». Simone l’operaista, Simone la mistica – due dei suoi diversi volti. Nel 1937 viaggia in Italia. È l’Umbria ad abbagliarla con le sue campagne soavi, così evangeliche, così francescane. «C’è da credere che la Provvidenza abbia creato campi ridenti e umili, toccanti oratori per preparare la sua venuta ». La povertà di Francesco la estasiò. «Mentre ero sola nella piccola cappella romanica del XII secolo di Santa Maria degli Angeli, incomparabile meraviglia di purezza, dove san Francesco ha pregato molto spesso, qualcosa di me mi ha obbligata, per la prima volta nella mia vita a inginocchiarmi». Forse potremmo immaginarla in un eremo francescano. Scherzando meditava di travestirsi da uomo per poter restare in quei luoghi.
Simone lasciò invece l’Europa per rifugiarsi con i genitori in America. Era il viaggio di tanti profughi. Ma lei si sentiva una fuggitiva: aveva preteso di sottrarsi alla sventura che colpiva chi era intrappolato nel Vecchio continente – i francesi, ma in particolare gli ebrei europei. Lo sterminio cominciava. Weil non si convertì al cattolicesimo – restò sulla soglia. Proprio per questo è difficile dire quale sia stato il suo rapporto con l’ebraismo, da cui era comunque molto distante, come lo erano gli ebrei assimilati in quel tempo. Ma in quella incredibile quantità di testi che scrisse, una volta rientrata a Londra, in attesa di congiungersi con la resistenza francese, affiora l’idea dell’esilio di Dio, lo tzimtzum ebraico, anzi kabbalistico.
Nella creazione Dio non si è esteso – si è ritratto per far spazio all’altro da sé, per dar luogo al mondo. Questo gesto di donazione è il modello per ogni persona, che si innalza così all’impersonale, per ogni esistenza che si ritrae lasciando essere l’altro. Nel mondo attuale la “decreazione”, lanciata da Simone Weil, dovrebbe indicare il nuovo paradigma di rispetto verso gli altri e verso il pianeta.
Logorata dalla passione indagatrice, consumata dalla tensione, estenuata dalla tristezza, consegnata all’esilio asettico di un sanatorio inglese, fuori da ogni fronte, Simone si lasciò andare a un’anoressia disperata, si affamò e si sfinì fino ad autoannientarsi. Come se, nel suo ritrarsi, le fosse per sempre sfuggita la presa dell’altro che avrebbe potuto salvarla.
(L’Espresso,dic 2020)

L'intelligenza dell’amore:
Simone Weil e Etty Hillesum
Wanda Tommasi **
Vorrei mostrare come nelle due autrici che prenderò in esame, Simone Weil e Etty Hillesum, l'amore di Dio sia legato all'amore per il prossimo e come vi sia in entrambe, sia pure in modi diversi, una sovversione dell'immagine di Dio rispetto alla tradizione patriarcale. Mi è necessaria una breve premessa, prima di addentrarmi nel confronto con i loro testi: scelgo di trattare insieme di queste due autrici, perché le considero entrambe scrittrici mistiche e fra le più grandi. È vero tuttavia che l'esperienza mistica è presente sicuramente in Simone Weil, che ne parla sobriamente, mentre è dubbia nel caso della Hillesum, per la quale possiamo parlare sì di esperienza vissuta di Dio, ma non di estasi mistica. È vero anche che i loro testi propriamente "mistici" sono pochissimi: si limitano al Prologo dei Quaderni e a qualche poesia nel caso della Weil e a qualche sporadica annotazione nel caso della Hillesum. Tuttavia, per entrambe, si può parlare di scrittura mistica in un senso più ampio e non "tecnico", cioè come scrittura che salvaguarda un vuoto, una presenza-assenza, che prende talvolta il nome di Dio, ma anche di infinitamente piccolo, di scintilla di luce, di granello di senape ecc.
*
In Simone Weil, l'esperienza di Dio è strettamente legata alla relazione con l'altro, con il prossimo: l'immagine di Dio che si delinea nei testi weiliani indica anche l'orientamento dell'amore verso l'altro. Per la Weil, possiamo partire dall'esperienza mistica di Solesmes del 1938. Come Simone stessa precisa nella lettera a padre Perrin nota come Autobiografia spirituale (in Attesa di Dio, Rusconi, pp. 42-43), è recitando una poesia di George Herbert che s'intitola Love (Amore), che lei ha un'esperienza di contatto, da persona a persona, con il Cristo. Ecco la poesia:
L'Amore mi accolse; ma l'anima mia indietreggiò,
colpevole di polvere e peccato. Ma chiaroveggente l'Amore, vedendomi esitare
Fin dal mio primo passo,
mi si accostò, con dolcezza domandandomi
se qualcosa mi mancava.
"Un invitato" risposi "degno di essere qui".
L'Amore disse: "Tu sarai quello".
"Io, il malvagio, l'ingrato? Ah! mio diletto,
non posso guardarti".
L'Amore mi prese per mano, sorridendo rispose:
"Chi fece questi occhi, se non io?"
"È vero, Signore, ma li ho insozzati; che vada la mia vergogna dove merita".
"E non sai tu" disse l'Amore "chi ne prese il biasimo su di sé?"
"Mio diletto, allora servirò".
"Bisogna tu sieda," disse l'Amore "che tu gusti il mio cibo".
Così mi sedetti e mangiai.
Il tema della poesia è quello dell'amore che accoglie: con l'accoglienza dell'amore inizia infatti il primo verso; ma l'invitato alla mensa si ritiene indegno, mancante, "colpevole di polvere e di peccato"; solo alla fine, dopo l'insistenza di Amore, l'invitato accetta di sedersi alla mensa e di mangiare, nonostante le propria indegnità. Di questo testo, vorrei sottolineare il fatto che l'invitato è accolto proprio nella sua "mancanza" (peccato, ingratitudine, malvagità ecc.); è amato nella sua singolarità (sono amati i suoi occhi), è amato proprio nella sua mancanza e impurità.
*
Il motivo di fondo di questa poesia, così importante nell'esperienza mistica di Simone Weil, è ripreso in uno dei pochissimi testi mistici scritti da Simone, nel Prologo dei Quaderni. Anche qui troviamo il motivo dell'amore che accoglie, con una risonanza rispetto alla poesia di Herbert, che ne riproduce e ne reinterpreta originalmente le sequenze, come spesso accade nella letteratura mistica. Ma, accanto al tema dell'amore che accoglie (qualcuno - Amore o Cristo - invita chi scrive a condividere il cibo, la luce del sole, le parole scambiate in una mansarda), troviamo quello, presente nella Weil ma non nella poesia Love, dell'amore che rifiuta. Anche qui c'è un mangiare insieme, una comunione: i due personaggi, entrambi designati al maschile, mangiarono insieme un pane che "aveva davvero il gusto del pane" e bevvero del vino "che aveva il gusto del sole e della terra dove era costruita quella città" (Quaderni, Adelphi, vol. I, p. 104). Nel Prologo, c'è sì l'accoglienza dell'amore, ma alla fine c'è la cacciata dal paradiso, dalla mansarda. Il testo si conclude con una riflessione esitante sull'amore di Dio: "So bene che non mi ama. Come potrebbe amarmi? E tuttavia in fondo a me qualcosa, un punto di me, non può impedirsi di pensare tremando di paura che, forse, malgrado tutto, mi ama" (Ivi, p. 105). L'amore di Dio (come quello di chiunque) non è certo, garantito, suggerisce la fine del Prologo: è mancanza che può sperimentare sì istanti di pienezza, ma, al di fuori dei brevi momenti di grazia dell'esperienza mistica, si è ricacciati nel mondo, rigettati nella durezza della necessità. Dio "accade" in brevi lampi di grazia, ma questo "accadere" non è garantito, può ripetersi o no. In questa conclusione, che presenta il dono dell'amore di Dio sospeso fra la speranza e il timore, c'è un accenno alla "prova" della perdita dell'amore di Dio (ribadita dalla Weil nel suo commento al "Padre nostro"): la "prova" è il malheur, che può intaccare l'animo dello sventurato fino a farlo sentire abbandonato anche da Dio. La "prova" è la perdita dell'amore di Dio, ben sintetizzata, nel finale del Prologo, nell'immagine dell'amore che rifiuta. Amore, protagonista della poesia di Herbert, viene evocato dalla Weil, alla fine del suo testo mistico, in forma dubitativa: all'esperienza dell'amore di Dio segue il dubbio, perché Dio non può essere per noi uno stabile possesso; dobbiamo restare in attesa, attendere che la grazia di Dio discenda. Alla fede segue il dubbio, necessario alla fede per non trasformarsi in idolatria.
*
Un altro testo della Weil che vorrei brevemente prendere in esame è una preghiera personale, scritta da Simone stessa, in cui lei chiede al Padre, nel nome di Cristo, di essere ridotta alla paralisi fisica, di diventare "paralizzata, cieca, sorda, idiota e guasta"; chiede inoltre che le sia tolta la capacità di collegamento fra i pensieri, fino a diventare "comme un de ces idiots complets qui non seulement ne savent ni compter ni lire, maia n'ont meme jamais pu apprendre à parler". ("Cahiers Simone Weil", 1983, n. 1, p. 55). Questa preghiera può essere interpretata in chiave masochistica, come alcuni interpreti della Weil hanno suggerito, ma può anche essere interpretata diversamente: essa si conclude infatti con un'invocazione della Weil, la quale chiede che tutte le sue doti fisiche, umane e intellettuali siano "divorate" da Dio e messe a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno. In altri termini, Simone Weil chiede, nell'ultima parte della sua preghiera personale, che sia fatta la volontà di Dio: se questa prevede la conservazione dei suoi doni, lei chiede che la sua intelligenza, nella pienezza della sua lucidità, colleghi fra loro tutte le idee in conformità perfetta con la volontà divina. Chiede, in altri termini, la morte dell'io, la totale decreazione: chiede che le sue qualità divengano impersonali, proprietà di Dio, e che siano messe a disposizione di tutti. Certo, c'è un fortissimo desiderio di kenosi, ma esso riguarda solo l'io e la sua volontà di potenza: è l'io (il "moi" degli attaccamenti) ciò che la Weil chiede che diventi "paralizzato, cieco, sordo, idiota e guasto". Questa preghiera personale della Weil mostra una relazione strettissima fra l'amore di Dio e l'amore del prossimo: il desiderio di giungere all'impersonale, alla morte dell'io, fa tutt'uno con l'amore di Dio, pensato a sua volta come impersonale (esso, precisa la Weil citando il Vangelo, cade, come la pioggia, sui giusti e sugli ingiusti). Anche per questo la Weil considera l'ateismo come una forma di purificazione rispetto a un Dio che ci assiste e ci protegge quando ne abbiamo bisogno: per questo Simone non ama Teresa di Lisieux, perché la piccola Teresa conosce solo un Dio personale, compreso in una visone che lei considera, a mio parere a torto, troppo infantile.
*
Quello di cui Simone Weil ci parla è un amore che ha in sé della distanza, dell'impersonalità, sia rispetto a Dio sia rispetto al prossimo. Nei Quaderni, vediamo infatti come lei miri alla purezza dell'amore nei confronti dell'altro, depurando sostanzialmente l'amore fisico da sensualità, piacere e voluttà, e affermando che la castità è indispensabile all'amore. Appena c'è bisogno (dell'altro), appena c'è desiderio, anche reciproco, c'è oltraggio, scrive (Quaderni, vol. I, p. 117). Inoltre, sottolinea come l'amore sia spesso un mezzo per dominare l'altro, uno strumento di potenza, un modo di accrescere il proprio io. Denuncia la commistione di amore e potere, che impedisce ogni purezza nell'amare: ogni volta che un uomo pensa una donna in funzione del proprio piacere, egli in realtà non l'ama (Ivi, p. 142). La Weil non accetta la dipendenza in cui chi ama si viene a trovare dall'essere amato: questa è per lei una situazione di mendicità, di dipendenza intollerabile (Ivi, p. 144). Di qui la necessità di una grande distanza nell'amore, di quell'impersonalità che, come si notava sopra, la Weil sottolinea anche nell'amore di Dio: amore puro è per Simone quello che non vuole subordinare l'altro, che non vuole appropriarsene; è amore per un altro di cui si desidera l'esistenza indipendente e di cui non si vuole mutare nulla. Il motivo di fondo che la Weil valorizza nell'amore è il rispetto di chi si desidera, di chi si ama. È evidente che Simone ha riflettuto come donna su questo tema: infatti, anche se parla della necessità di non subordinare l'altro, in realtà sa bene che la donna è piuttosto colei che si è sempre subordinata all'altro per amore, che ha patito la dipendenza, che è stata trattata come oggetto. Scrive ad esempio: "miscuglio di fraternità dolorosa e di gelosia tra donne ugualmente sottoposte all'arbitrio della violenza maschile" (Ivi, pp. 142-143). Rispetto a questa degradazione dell'amore, in cui esso si fa strumento di dominio e di asservimento dell'altro (ma bisognerebbe dire dell'altra), Simone Weil imposta i temi dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo in assoluto parallelismo: in entrambi i casi, si tratta d'un amore che cerca il consenso dell'essere amato, che non è mescolato con il potere, che rifiuta la forza. Tale è l'amore di Dio, che cerca e mendica il consenso dell'essere amato, tale è l'amore vero per l'altro, che non cerca di asservirselo, ma che resta in paziente attesa e che ne rispetta l'alterità; così è, ad esempio, nell'amore cortese, che la Weil apprezza molto e di cui lamenta l'assenza nella nostra epoca. Come l'amore di Dio rinuncia all'onnipotenza per lasciar essere il mondo, così noi dobbiamo rinunciare alla nostra piccola potenza umana per lasciar essere l'altro nella sua alterità. Amore di Dio e amore del prossimo hanno la stessa struttura. La forza di quest'intuizione di fondo, assolutamente centrale nella Weil, comporta una sovversione dell'immagine di Dio, che fa capire come Simone abbia pensato Dio proprio a partire dalla sua sensibilità di donna. C'è innanzitutto la sovversione dell'immagine del Dio onnipotente tramandata dalla tradizione patriarcale: Dio non è pensato come onnipotente, ma come colui che rinuncia alla potenza per amore del mondo, fino all'impotenza sulla croce. Soprattutto in un passo dei Quaderni, Simone sovverte l'immagine tradizionale di Dio e fa capire di mettere in gioco la sua sensibilità femminile nel pensare Dio: è un passo in cui Dio viene paragonato a "una donna importuna che se ne sta incollata al suo amante e gli sussurra all'orecchio, per ore, senza fermarsi 'Io ti amo - Io ti amo - Io ti amo...'" (Quaderni, Adelphi, vol. III, p. 69).
*
Possiamo aggiungere a questo passo le immagini del Dio carnefice ne La Grecia e le intuizioni precristiane (Zeus nei confronti di Prometeo, nella rilettura weiliana del mito). C'è, nei testi della Weil, anche un Dio violentatore (nel mito di Demetra e Core). È come se, dopo avere a lungo lottato contro gli attaccamenti e l'umiliazione che derivano dalla dipendenza, Simone Weil, a un certo punto, dopo l'esperienza mistica, smettesse di combattere contro tutto questo e l'accettasse, mirando solo a trasferire l'attaccamento da degli esseri particolari all'universo intero e a Dio. Simone scrive infatti che ciò che occorre è un mutamento di livello: non un amore più grande, ma un altro amore (Quaderni, vol. I, p. 282). Sappiamo da lei cosa può portarci a un tale mutamento di livello: la contemplazione del limite, delle contraddizioni insolubili, la porta stretta della contraddizione come passaggio al soprannaturale. La mistica è per lei infatti il passaggio al di là della sfera dove bene e male si contrappongono, e questo per l'unione dell'anima con il bene assoluto. In questo, la mistica non è diversa dalla filosofia, intesa dalla Weil come pratica, come metodo spirituale di purificazione dell'anima, come contemplazione delle contraddizioni insolubili fino a che da esse non sgorghi la luce. Qui ritroviamo di nuovo l'amore, perché la Weil sottolinea che non c'è conoscenza se questa non è sorretta dall'amore.
*
Dunque, per concludere sulla Weil, sottolineo ancora una volta che c'è in lei sinergia fra l'amore di Dio e l'amore del prossimo: in entrambi, c'è rinuncia alla potenza per rispettare l'alterità dell'altro. Ma ci sono anche dei passi che contrastano con questo parallelismo e che presentano piuttosto la forma del capovolgimento: quello che è inaccettabile se fatto da un uomo a una donna (violenza sessuale) o a un altro uomo (uso della forza, omicidio, schiavitù) diventano desiderabili se l'autore ne è Dio. Ho l'impressione che questi ultimi passi, per me molto inquietanti, affondino le radici nel vissuto religioso e mistico di Simone Weil, il quale ci mostra una donna che ha in parte interiorizzato il Dio della tradizione patriarcale nei suoi aspetti anche più crudeli, arbitrari e violenti, in contrasto con l'immagine di Dio generalmente prevalente nella Weil, quella di un Dio che rinuncia alla potenza per amore.
*
Anche in Etty Hillesum c'è una sovversione dell'immagine di Dio tramandata dalla tradizione patriarcale, e tale sovversione orienta anche la sua relazione con il prossimo. Etty scopre Dio come la parte più riposta di sé, come il silenzio interiore che le consente di dare senso alle cose drammatiche che le accadono, che le permette di non lasciarle sprofondare nell'insensatezza. In lei, Dio è il nome del silenzio, di un "varco nell'essere" che lascia esserci l'essere: da questo punto di vista, la questione che ponevo all'inizio in forma dubitativa, cioè se Etty Hillesum si possa o meno definire mistica, trova una risposta proprio nella relazione di Etty con l'esperienza, con l'accadere dell'essere. L'ineffabile, il mistico, non è in realtà per Etty Dio (a Dio lei parla con grande facilità e confidenza, al punto da dire che "saltella qua e là con Dio come se fosse una cosa da nulla") (Diario 1941-1943, Adelphi, p. 217), ma è l'immediato della presenza: la vita nel suo scorrere, la bellezza di un momento... Occorre del silenzio - Dio - affinché l'essere possa venire al linguaggio, affinché, nelle circostanze drammatiche in cui lei vive, l'esistenza non sprofondi nell'insensatezza, affinché lei possa arrivare a rispettare l'alterità del bello senza volerlo possedere. Così è anche nell'amore (concretamente, l'amore per il suo psicoterapeuta e amante, Julius Spier, che per Etty è propedeutico rispetto alla sua scoperta di Dio): costretta a lottare per venire a capo dentro di sé della possessività nei confronti di Spier e della gelosia verso la fidanzata di lui, che lo aspetta a Londra, Etty fa dello scacco del suo sogno d'amore l'occasione d'un passaggio a un livello più alto: "Oh, lasciar completamente libera una persona che si ama, lasciarla del tutto libera di fare la sua vita, è la cosa più difficile che ci sia. Lo sto imparando per lui" (Ivi, p. 147). Etty si ritrae, rinuncia al possesso esclusivo (cioè a consegnarsi tutta a lui), e arriva ad amare tollerando l'autonomia dell'altro: a quel punto, accetta di "perdersi per Dio o per una poesia" (ivi, p. 89), non per un uomo. Lascia del vuoto come spazio di relazione fra sé e l'altro.
*
La sovversione dell'immagine di Dio tradizionale in Etty è notevole: non solo Dio non è concepito come onnipotente, ma è visto addirittura come impotente di fronte al dilagare di un male, la cui responsabilità grava interamente sugli uomini. Dio è visto come inerme, bisognoso di aiuto: nell'intuizione straordinaria di "aiutare Dio" a non assentarsi del tutto da questo mondo, cioè dal cuore degli esseri umani induriti dalla sofferenza, Etty Hillesum sintetizza una relazione con Dio che ha tratti femminili e materni. Etty, che nella sua vita personale aveva rifiutato la maternità, si assume infine una maternità simbolica rispetto a Dio. Dopo aver cercato a lungo riparo e contenimento (in uomini tanto più maturi di lei, poi in parole che la potessero ospitare e contenere), Etty, alla fine, capovolge questo suo bisogno in disponibilità a offrirsi lei stessa come riparo, conforto e aiuto per Dio. Dev'essere riuscita davvero a ospitare Dio in sé, a essere incinta di Dio, visto che è riuscita a erodere le radici dell'odio dentro di sé e che è arrivata ad amare i propri nemici, mettendo in pratica questo così difficile insegnamento evangelico. Se il rifiuto dell'odio, nelle terribili circostanze in cui è vissuta, l'avvicina alla santità, la maternità simbolica rispetto a Dio attesta una relazione femminile con Dio che non è verticale, ma circolare: benché Dio sia colui che l'ha creata e che può tenerla per mano nei momenti più difficili, tuttavia egli non può esistere senza di lei.
*
Proponendosi di aiutare Dio, Etty suggerisce che la parte divina della creatura è proprio quella più fragile, inerme, bisognosa, piena di peccati e di debolezza. È là che abita Dio, nella fragilità della creatura, nella sua mancanza. Quest'immagine di Dio, che sovverte radicalmente quella tradizionale del Dio onnipotente, è strettamente correlata alla relazione con l'altro, con il prossimo: a Westerbork, il campo di smistamento in cui fu internata prima di finire ad Auschwitz, Etty parla d'un amore per il suo prossimo, sofferente e disperato, che non è misurato sul merito dell'oggetto amato ("la gente di Westerbork non ti offre molte occasioni di amarla", scrive nelle Lettere 1942-1943, Adelphi, p. 114), ma che è come un "ardore elementare" che alimenta la vita. Secondo Helene Cixous, qui entra in gioco un'economia libidinale femminile, un'economia del dono, creatore di legame: Etty non teme d'impoverirsi donando, perché il dono, che crea relazioni, innesca uno squilibrio positivo, al rialzo, un gioco che non è a somma zero. Infatti, a Westerbork, Etty registra come ricchezza e non come impoverimento, nel libro dei conti della vita, il fatto di provare nostalgia per gli affetti da cui è stata separata: mentre tutti gli altri vivono questa terribile situazione come una privazione violentemente imposta, lei invece vi coglie una ricchezza, perché il fatto di essere ancora capaci d'amare e di provare nostalgia in quelle circostanze significa che si è ricchi d'amore, di capacità di dare (Ivi, p. 118). L'amore per gli altri che Etty pratica concretamente a Westerbork è un amore che crea l'altro, facendolo esistere: è proprio quell'attenzione creatrice, che restituisce esistenza all'altro, di cui ci parla Simone Weil. La strategia esistenziale di Etty Hillesum tiene insieme l'amore di Dio e l'amore del prossimo: Dio è il silenzio interiore, lo spazio vuoto, la distanza dall'immersione totale nell'esistenza che le permette di non lasciar sprofondare gli avvenimenti che vive nell'insensatezza e nell'orrore, ma di dar loro senso nella scrittura, pur continuando a "esserci al cento per cento" e a viverli fino in fondo (Diario, p. 222).
*
C'è una qualità femminile nel sentire religioso di Etty Hillesum che a me sembra più limpida e inequivoca di quella di Simone Weil. Questa qualità femminile si percepisce, ad esempio, nel suo non separare mai, nel proprio itinerario spirituale, sessualità e spiritualità, corpo e spirito, ma nel farli crescere sempre insieme. Ciò si coglie nella consapevolezza dell'importanza delle pratiche femminili quotidiane, viste come un ancoramento del corpo all'esistenza che, mettendo ordine nel corpo, ordinano anche lo spirito. Si coglie anche, in Etty, nella "cura con cui ha vissuto" (l'espressione è di Carla Lonzi, Taci, anzi parla. Diario di una femminista, Rivolta femminile, p. 63): cura delle relazioni, delle amicizie e insieme, sempre, lavoro di scrittura per non perdere il filo di se stessa e per dare senso agli eventi. La strategia esistenziale della Hillesum ha puntato sul silenzio interiore - Dio - sia nella cura nel vivere sia nel salvare dall'insignificanza i gesti di cui il vivere è intessuto, dal rammendare una calza all'apparecchiare la tavola, dal ritirarsi nella "cella" della preghiera al piacere di coltivare le amicizie. Cura nel vivere significa anche che niente può avere senso se il semplice fatto di essere vivi non ne ha: questo senso viene alla Hillesum dal mettere la vita in prospettiva, dal guardarla da un punto di silenzio, a cui lei dà il nome di Dio. È questo silenzio la distanza che le permette di dare respiro all'esistenza, cosicché ogni momento che ancora le resta da vivere è percepito come un dono, tanto più prezioso perché sta per esserle tolto.
* Simone Weil, nata a Parigi nel 1909, allieva di Alain, fu professoressa, militante sindacale e politica della sinistra classista e libertaria, operaia di fabbrica, miliziana nella guerra di Spagna contro i fascisti, lavoratrice agricola, poi esule in America, infine a Londra impegnata a lavorare per la Resistenza. Minata da una vita di generosità, abnegazione, sofferenze, muore in Inghilterra nel 1943. Una descrizione meramente esterna come quella che precede non rende però conto della vita interiore della Weil (ed in particolare della svolta, o intensificazione, o meglio ancora: radicalizzazione ulteriore, seguita alle prime esperienze mistiche del 1938). Ha scritto di lei Susan Sontag: "Nessuno che ami la vita vorrebbe imitare la sua dedizione al martirio, o se l'augurerebbe per i propri figli o per qualunque altra persona cara. Tuttavia se amiamo la serietà come vita, Simone Weil ci commuove, ci dà nutrimento".
Opere di Simone Weil: tutti i volumi di Simone Weil in realtà consistono di raccolte di scritti pubblicate postume, in vita Simone Weil aveva pubblicato poco e su periodici (e sotto pseudonimo nella fase finale della sua permanenza in Francia stanti le persecuzioni antiebraiche). Tra le raccolte più importanti in edizione italiana segnaliamo: L'ombra e la grazia (Comunità, poi Rusconi), La condizione operaia (Comunità, poi Mondadori), La prima radice (Comunità, SE, Leonardo), Attesa di Dio (Rusconi), La Grecia e le intuizioni precristiane (Rusconi), Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale (Adelphi), Sulla Germania totalitaria (Adelphi), Lettera a un religioso (Adelphi); Sulla guerra (Pratiche). Sono fondamentali i quattro volumi dei Quaderni, nell'edizione Adelphi curata da Giancarlo Gaeta.
Opere su Simone Weil: fondamentale è la grande biografia di Simone Petrement, La vita di Simone Weil, Adelphi, Milano 1994. Tra gli studi cfr. AA. VV., Simone Weil, la passione della verità, Morcelliana, Brescia 1985; Gabriella Fiori, Simone Weil, Garzanti, Milano 1990; Giancarlo Gaeta, Simone Weil, Edizioni cultura della pace, S. Domenico di Fiesole 1992; Jean-Marie Muller, Simone Weil. L'esigenza della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994; Angela Putino, Simone Weil e la Passione di Dio, Edb, Bologna 1997; Maurizio Zani, Invito al pensiero di Simone Weil, Mursia, Milano 1994.
Etty Hillesum è nata a Middelburg nel 1914 e deceduta ad Auschwitz nel 1943, il suo diario e le sue lettere costituiscono documenti di altissimo valore e in questi ultimi anni sempre di più la sua figura e la sua meditazione diventano oggetto di studio e punto di riferimento per la riflessione.
Opere di Etty Hillesum: Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 1985, 1996; Lettere 1942-1943, Adelphi, Milano 1990, 2001.
Opere su Etty Hillesum: AA. VV., La resistenza esistenziale di Etty Hillesum, fascicolo di "Alfazeta", n. 60, novembre-dicembre 1996, Parma. Più recentemente: Nadia Neri, Un'estrema compassione, Bruno Mondadori Editore, Milano 1999; Pascal Dreyer, Etty Hillesum. Una testimone del Novecento, Edizioni Lavoro, Roma 2000; Sylvie Germain, Etty Hillesum. Una coscienza ispirata, Edizioni Lavoro, Roma 2000; Wanda Tommasi, Etty Hillesum. L'intelligenza del cuore, Edizioni Messaggero, Padova 2002]
**
[Dal sito www.diotimafilosofe.it riprendiamo il testo di questa conferenza tenuta a Orvieto nel luglio 2002 da Wanda Tommasi. Wanda Tommasi è docente di storia della filosofia contemporanea all'Università di Verona, fa parte della comunità filosofica di "Diotima".
Opere di Wanda Tommasi: La natura e la macchina. Hegel sull'economia e le scienze, Liguori, Napoli 1979; Maurice Blanchot: la parola errante, Bertani, Verona 1984; Simone Weil: segni, idoli e simboli, Franco Angeli, Milano 1993; Simone Weil. Esperienza religiosa, esperienza femminile, Liguori, Napoli 1997; I filosofi e le donne, Tre Lune, Mantova 2001; Etty Hillesum. L'intelligenza del cuore, Edizioni Messaggero, Padova 2002; La scrittura del deserto, Liguori, Napoli 2004.
FONTE: NONVIOLENZA. FEMMINILE PLURALE
Supplemento settimanale del giovedì de "La nonviolenza è in cammino" Direttore responsabile: Peppe Sini. Redazione: strada S. Barbara 9/E, 01100 Viterbo.
Etty Hillesum..Invece illumina!

Etty Hillesum
e l'amore alla vita
«Prometto di vivere questa vita sino in fondo, di andare avanti»
«E alla fine di ogni giornata sento il bisogno di dire: la vita è davvero bella»
«Il senso della vita non è soltanto la vita stessa»
LA SORGENTE
La sorgente di ogni cosa ha da essere la vita stessa, mai un’altra persona. Molti, invece - soprattutto donne - attingono le proprie forze da altri: è l’uomo la loro sorgente, non la vita. Mi sembra un atteggiamento quanto mai distorto e innaturale.
IL SENSO PROPRIO DELLA VITA
Di nuovo arresti, terrore, campi. di concentramento, sequestri di padri sorelle e fratelli. Ci s’interroga sul senso della vita, ci si domanda se essa abbia ancora un senso: ma per questo bisogna vedersela esclusivamente con se stessi, e con Dio. Forse ogni vita ha il proprio senso, forse ci vuole una vita intera per riuscire a trovarlo.
LA VITA È BUONA
La forza autentica, primaria, consiste in ciò, che se anche si soccombe miseramente, fino all’ultimo si sente che la vita è bella e ricca di significato, che si è realizzato tutto quanto in noi stessi e che la vita era buona.
DENTRO LA STORIA
Con tutto il dolore che ho intorno, comincio a vergognarmi di prendere sul serio i miei umori. Eppure devi continuare a prenderti sul serio, devi rimanere il centro, e in qualche modo devi venire a capo dei fatti di questo mondo; in nessuna situazione puoi chiudere gli occhi, devi ‘confrontarti’ con questi tempi orribili, e cercare una risposta alle numerose questioni di vita e di morte che essi ti pongono. E allora forse troverai una risposta ad alcune di esse, non solo per te ma anche per gli altri. Sta di fatto che devo vivere, e che devo affrontare ogni cosa. A volte mi sento come un palo ritto in un mare infuriato, fra le onde che lo battono da ogni parte. Ma io rimango ben ferma e gli anni mi passano sopra. Voglio continuare a vivere pienamente.
LA VITA QUOTIDIANA
A volte faccio così fatica a costruire l’intelaiatura della mia giornata - alzarmi, lavarmi, far ginnastica, mettermi delle calze senza buchi, apparecchiare la tavola, in breve “orientarmi” nella vita quotidiana -, che non mi rimane quasi più energia per altre cose. E se allora mi alzo per tempo come un qualunque cittadino, sono fiera di aver operato chissà quale miracolo. Eppure, fintanto che la disciplina interiore non è a posto, quella esteriore rimane importantissima per me. Se io dormo un’ora di più alla mattina questo non significa che io abbia dormito bene, ma che non so affrontare la vita e che faccio sciopero.
OGNI COSA È UNA FESTA
Ogni camicia pulita che puoi ancora indossare è quasi una festa; e così pure se ti lavi con un sapone profumato, in un bagno che è tutto tuo per quella mezz’ora. È proprio come se io mi stessi già congedando da queste raffinatezze della civiltà. E se un giorno non potrò più goderne, saprò in ogni caso che esistono e che possono rendere piacevole la vita, e in quanto tali le loderò, anche se non mi saranno toccate in sorte. Quel che conta, infatti, non è che tocchino proprio a me - vero?
LASCIARSI ABBRACCIARE DALLA VITA
Ecco la tua malattia: pretendi di rinchiudere la vita nelle tue formule, di abbracciare tutti i fenomeni della vita con la tua mente, invece di lasciarti abbracciare dalla vita. Com’era già?: va bene che tu affacci la tua testa in cielo, ma non che tu cacci il cielo nella tua testa. Ogni volta vorresti rifare il mondo, invece di goderlo com’è. È un atteggiamento alquanto dispotico.
LA CORRENTE DELLA VITA
Mi accorgo che questo stato d’animo si ripete ogni volta: dopo giorni di vita interiore terribilmente intensa, ricerca di chiarezza, doglie patite per sentimenti e pensieri che non sono affatto pronti per nascere, enormi pretese da parte mia, e la ricerca di una piccola forma propria che diventa di un’importanza capitale, ecc. ecc. ecc. - ecco che poi tutto quest’affanno, improvvisamente, mi cade di dosso; il mio cervello è piacevolmente stanco, c’è bonaccia di nuovo, sento quasi una sorta di dolcezza anche verso me stessa, e su di me cala un velo attraverso cui la vita filtra più mite, e spesso più ridente. Sento allora di essere tutt’uno con la vita. Inoltre: che non sono io individualmente a volere o a dovere fare questo o quello, ma che la vita è grande e buona e attraente e eterna - e se tu dai tanta importanza a te stessa, ti agiti e fai chiasso, allora ti sfugge quella grande, potente, e eterna corrente, che è appunto la vita.
LA VITA FUTURA: QUI, ADESSO
La vita è difficile davvero, è una lotta di minuto in minuto (non esagerare, tesoro!), ma è una lotta invitante. Una volta io m’immaginavo un futuro caotico perché mi rifiutavo di vivere l’istante più prossimo. Ero come un bambino molto viziato, volevo che tutto mi fosse regalato. A volte avevo la certezza - peraltro molto vaga - che in futuro sarei potuta diventare “qualcuno” e avrei realizzato qualcosa di “straordinario”, altre volte mi ripigliava quella paura confusa che “sarei andata in malora lo stesso”. Comincio a capire perché: mi rifiutavo di adempiere ai compiti che avevo sotto gli occhi, mi rifiutavo di salire verso quel futuro di gradino in gradino. E ora, ora che ogni minuto è pieno, pieno sino all’orlo di vita e di esperienza, di lotta e vittorie e cadute, ma subito dopo di nuovo lotta e talvolta pace, - ora non penso più a quel futuro, in altre parole mi è indifferente se riuscirò a produrre qualcosa di straordinario oppure no, perché sono certa che ne verrà fuori qualcosa. Una volta vivevo sempre come in una fase preparatoria, avevo la sensazione che ogni cosa che facevo non fosse ancora quella “vera”, ma una preparazione a qualcosa di diverso, di grande, di vero, appunto. Ora questo sentimento è cessato. Io vivo, vivo pienamente e la vita vale la pena viverla ora, oggi, in questo momento; e se sapessi di dover morire domani direi: mi dispiace molto, ma così com’è stato, è stato un bene…La vita la conosciamo, abbiamo già vissuto tutto sia pure in spirito, non siamo più così spasmodicamente attaccati alla vita.
LIBERARE LA VITA
E se si distruggono i preconcetti che imprigionano la vita come inferriate, allora si libera la vera vita e la vera forza che sono in noi, e allora si avrà anche la forza di sopportare il dolore reale, nella nostra vita e in quella dell’umanità.
CIELI SOPRA E DENTRO DI ME
Trovo bella la vita, e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave… Quel pezzetto d’eternità che ci portiamo dentro può esser espresso in una parola come in dieci volumoni. Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio, nell’anno del Signore 1942, l’ennesimo anno di guerra.
C'È POSTO PER TUTTO
La sofferenza non è al di sotto della dignità umana. Cioè: si può soffrire in modo degno, o indegno dell’uomo. Voglio dire: la maggior parte degli occidentali non capisce l’arte del dolore, e così vive ossessionata da mille paure. E la vita che vive la gente adesso non è più una vera vita, fatta com’è di paura, rassegnazione, amarezza, odio, disperazione. Dio mio, tutto questo si può capire benissimo: ma se una vita simile viene tolta, viene tolto poi molto? Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte della vita. E non viviamo ogni giorno una vita intera, e ha molta importanza se viviamo qualche giorno in più, o in meno? Io sono quotidianamente in Polonia, su quelli che si possono ben chiamare dei campi di battaglia, talvolta mi opprime una visione di questi campi diventati verdi di veleno; sono accanto agli affamati, ai maltrattati e ai moribondi, ogni giorno - ma sono anche vicina al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra, in una vita c’è posto per tutto. Per una fede in Dio e per una misera fine.
NELLA FATICA DI OGNI GIORNO
A volte devo chinare il capo sotto il gran peso che ho sulla nuca, e allora sento il bisogno di congiungere le mani, quasi in un gesto automatico, e così potrei rimaner seduta per ore - so tutto, sono in grado di sopportare tutto, sempre meglio, e insieme sono certa che la vita è bellissima, degna di essere vissuta e ricca di significato. Malgrado tutto. Il che non vuol dire che uno sia sempre nello stato d’animo più elevato e pieno di fede. Si può esser stanchi come cani dopo aver fatto una lunga camminata o una lunga coda, ma anche questo fa parte della vita, e dentro di te c’è qualcosa che non ti abbandonerà mai più.
ANCHE NELLE ASSURDITÀ
Se rimarremo vivi, queste saranno altrettante ferite che dovremo portarci dentro per sempre. Eppure non riesco a trovare assurda la vita. E Dio non è nemmeno responsabile verso di noi per le assurdità che noi stessi commettiamo: i responsabili siamo noi! Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento. So tutto quanto e non mi preoccupo più per le notizie future: in un modo o nell’altro, so già tutto. Eppure trovo questa vita bella e ricca di significato. Ogni minuto.
SINO ALL'ULTIMO RESPIRO
Bene, io accetto questa nuova certezza: vogliono il nostro totale annientamento. Ora lo so. Non darò più fastidio con le mie paure, non sarò amareggiata se altri non capiranno cos’è in gioco per noi ebrei. Una sicurezza non sarà corrosa o indebolita dall’altra. Continuo a lavorare e a vivere con la stessa convinzione e trovo la vita ugualmente ricca di significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo quando mi trovo in compagnia.
La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me come un unico, potente insieme, e come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio - così, per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per poterlo fare, e se questo non mi sarà concesso, bene, allora qualcun altro lo farà al posto mio, continuerà la mia vita dov’essa è rimasta interrotta. Ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima convinzione, sino all’ultimo respiro.
ANCHE LA MORTE
La possibilità della morte si è perfettamente integrata nella mia vita; questa è come resa più ampia da quella, dall’affrontare ed accettare la fine come parte di sé. E dunque non si tratta, per così dire, di offrire un pezzetto di vita alla morte perché si teme e si rifiuta quest’ultima, la vita che ci rimarrebbe allora sarebbe ridotta a un ben misero frammento. Sembra quasi un paradosso: se si esclude la morte non si ha mai una vita completa; e se la si accetta nella propria vita, si amplia e si arricchisce quest’ultima.
COSA SALVARE
Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili. Ma forse possediamo altri organi oltre alla ragione, organi che allora non conoscevamo, e che potrebbero farci capire questa realtà sconcertante.
Io credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che gli consente di superarlo.
Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare - se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione -, allora non siamo una generazione vitale.
UN BARLUME DI ETERNITÀ
Un barlume d’eternità filtra sempre più nelle mie più piccole azioni e percezioni quotidiane. Io non sono sola nella mia stanchezza malattia tristezza o paura, ma sono insieme con milioni di persone, di tanti secoli: anche questo fa parte della vita che è pur bella e ricca di significato nella sua assurdità, se vi si fa posto per tutto e se la si sente come un’unità indivisibile. Così, in un modo o nell’altro, la vita diventa un insieme compiuto; ma si fa veramente assurda non appena se ne accetta o rifiuta una parte a piacere, proprio perché essa perde allora la sua globalità e diventa tutta quanta arbitraria.
PER ESSERE PIÙ UMANI
Ecco, le mie rose sono sempre lì… Sono molto stanca. Sono in grado di sopportare questo tempo presente, lo capisco persino un poco.
Se sopravviverò a questo tempo e se allora dirò: la vita è bella e ricca di significato, bisognerà pur credermi.
Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile.
VITA COME PREGHIERA
Arrivo sempre alla stessa conclusione: la vita è bella. E credo in Dio. E voglio stare proprio in mezzo ai cosiddetti ‘orrori’ e dire ugualmente che la vita è bella.
Devo ogni volta esultare e acclamarti, mio Dio: ti sono così riconoscente perché mi hai concesso una vita simile.
La vita è stata davvero molto buona con me, sempre e anche ora.

Etty Hillesum..nelle braccia di Dio
Per Etty Hillesum l'esperienza della fede passa attraverso una scoperta interiore (attraverso l'introspezione, una guida, le sue letture preferite: Rilke, Dostoevskij, s. Agostino, i Vangeli…) della presenza e azione dello Spirito che le permette di dedicarsi totalmente alla cura delle sofferenze altri e alla condivisione nel campo di concentramento di Westerbok (Olanda), prima della soluzione finale a Auschwitz.
Non è una fede "confessionale" (nel senso di appartenenza a una determinata chiesa o religione), ma non è neppure semplicemente un generico sentimento di amore.
E passa attraverso uno scoperta di un Dio vicino, dentro di sé, da disseppellire dalle macerie in cui la società e i tempi (ma anche le proprie preoccupazioni individualistiche) l'hanno sepolto; della preghiera (la ragazza che ha imparato a inginocchiarsi); dall'amore alla vita in tutte le sue manifestazioni; dall'amore agli altri; dal "distendersi" e trovare la serenità nella natura; dall'incapacità di odiare anche il nemico...
Una fede "troppo umana"?
A settant'anni dalla morte, la figura di Etty si staglia come quella di una limpida testimone della potenza trasformante dello Spirito di Dio in tutti i cuori, e possiede tuttora un fascino che non ha confini, specialmente tra i giovani.
SALVARE IN NOI UN PICCOLO PEZZO DI DIO
«Preghiera della domenica mattina. Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani - ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per modificare le circostanze attuali ma anch’esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all’ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d’argento - invece di salvare te, mio Dio. E altre persone, che sono ormai ridotte a semplici ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue braccia. Comincio a sentirmi un po’ più tranquilla, mio Dio, dopo questa conversazione con te. Discorrerò con te molto spesso, d’ora innanzi, e in questo modo ti impedirò di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi magri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla mia povera fiducia; ma credimi, io continuerò a lavorare per te e a esserti fedele e non ti caccerò via dal mio territorio».
NELLE BRACCIA DI DIO
«Molte persone mi rimproverano per la mia indifferenza e passività e dicono che mi arrendo così, senza combattere. Dicono che chiunque possa sfuggire alle loro grinfie deve provare a farlo, che questo è un dovere, che devo far qualcosa per me. Ma questa somma non torna. In questo momento, ognuno si dà da fare per salvare se stesso: ma un certo numero di persone - un numero persino molto alto - non deve partire comunque? Il buffo è che non mi sento nelle loro grinfie, sia che io rimanga qui, sia che io venga deportata. Trovo tutti questi ragionamenti così convenzionali e primitivi e non li sopporto più, non mi sento nelle grinfie di nessuno, mi sento soltanto nelle braccia di Dio per dirla con enfasi; e sia che ora io mi trovi qui, a questa scrivania terribilmente cara e familiare, o fra un mese in una nuda camera del ghetto o fors’anche in un campo di lavoro sorvegliato dalle SS, nelle braccia di Dio credo che mi sentirò sempre. Forse mi potranno ridurre a pezzi fisicamente, ma di più non mi potranno fare. E forse cadrò in preda alla disperazione e soffrirò privazioni che non mi sono mai potuta immaginare, neppure nelle mie più vane fantasie. Ma anche questa è poca cosa, se paragonata a un’infinita vastità, e fede in Dio, e capacità di vivere interiormente»
C'È POSTO PER TUTTO
«La sofferenza non è al di sotto della dignità umana. Cioè: si può soffrire in modo degno, o indegno dell’uomo. Voglio dire: la maggior parte degli occidentali non capisce l’arte del dolore, e così vive ossessionata da mille paure. E la vita che vive la gente adesso non è più una vera vita, fatta com’è di paura, rassegnazione, amarezza, odio, disperazione. Dio mio, tutto questo si può capire benissimo: ma se una vita simile viene tolta, viene tolto poi molto? Si deve accettare la morte, anche quella più atroce, come parte della vita. E non viviamo ogni giorno una vita intera, e ha molta importanza se viviamo qualche giorno in più, o in meno? Io sono quotidianamente in Polonia, su quelli che si possono ben chiamare dei campi di battaglia, talvolta mi opprime una visione di questi campi diventati verdi di veleno; sono accanto agli affamati, ai maltrattati e ai moribondi, ogni giorno - ma sono anche vicina al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra, in una vita c’è posto per tutto. Per una fede in Dio e per una misera fine».
CREDO NELLA VITA
«Sì, mio Dio, ti sono molto fedele, in ogni circostanza, non andrò a fondo e continuo a credere nel senso profondo di questa vita; so come devo continuare a vivere e ci sono in me, e in lui, delle certezze così grandi, ti sembrerà incomprensibile ma trovo la vita così bella e mi sento così felice. Non è meraviglioso? Non oserei dirlo a nessuno con così tante parole».
FEDE E COERENZA
«Se tu affermi di credere in Dio devi anche essere coerente, devi abbandonarti completamente e devi aver fiducia. E non devi neppure preoccuparti per l’indomani».
IL MURO DELLA PREGHIERA
«M’innalzo intorno la preghiera come un muro oscuro che offra riparo, mi ritiro nella preghiera come nella cella di un convento, ne esco fuori più ‘raccolta’, concentrata e forte. Questo ritirarmi nella chiusa cella della preghiera diventa per me una realtà sempre più grande, e anche un fatto sempre più oggettivo. La concentrazione interna costruisce alti muri fra cui ritrovo me stessa e la mia unità, lontana da tutte le distrazioni. E potrei immaginarmi un tempo in cui starò inginocchiata per giorni e giorni - sin quando non sentirò di avere intorno questi muri, che m’impediranno di sfasciarmi, perdermi e rovinarmi».
RITROVARSI NELLA PREGHIERA
«Un giorno pesante, molto pesante. Un “destino di massa” che si deve imparare a sopportare insieme con gli altri, eliminando tutti gli infantilismi personali. Chiunque si voglia salvare deve pur sapere che se non ci va lui, qualcun altro dovrà andare al suo posto. Come se importasse molto se si tratti proprio di me, o piuttosto di un altro, o di un altro ancora. È diventato ormai un “destino di massa” e si dev’essere ben chiari su questo punto. Un giorno molto pesante. Ma ogni volta so ritrovare me stessa in una preghiera - e pregare mi sarà sempre possibile, anche nello spazio più ristretto».
VOGLIO ESSERE UN'UNICA GRANDE PREGHIERA
«Stamattina all’alba sono saltata giù dal letto e mi sono inginocchiata alla finestra. L’albero era immobile nell’alba grigia e silenziosa. Ho pregato: mio Dio, concedimi la pace grande e potente della tua natura. Se vuoi farmi soffrire, dammi il dolore grande e pieno, non le mille, piccole preoccupazioni che consumano completamente. Dammi pace e fiducia. Fa’ che ogni mia giornata sia qualcosa di più che le mille preoccupazioni per la sopravvivenza quotidiana. E tutte le nostre preoccupazioni per il cibo, i vestiti, il freddo, la salute, non sono forse altrettante mozioni di sfiducia nei tuoi confronti, mio Dio? E non ci castighi forse prontamente - con l’insonnia, e con una vita che non è più una vita? Sono disposta a rimanere tranquillamente coricata per qualche giorno, ma allora voglio essere un’unica, grande preghiera. Un’unica, grande pace. Devo portare nuovamente la mia pace con me».
NEANCHE UN MINUTO SENZA PREGHIERA
«Se vuoi proprio guarire devi vivere diversamente: devi tacere per giorni interi e rinchiuderti in camera tua e non lasciar entrare nessuno, è l’unico modo. Non va bene come ti comporti adesso. Forse diventerai ancora ragionevole.
Si dovrebbe pregare giorno e notte per quelle migliaia. Non si dovrebbe stare neanche un minuto senza preghiera».
VEDERSELA CON DIO
«Di nuovo arresti, terrore, campi. di concentramento, sequestri di padri sorelle e fratelli. Ci s’interroga sul senso della vita, ci si domanda se essa abbia ancora un senso: ma per questo bisogna vedersela esclusivamente con se stessi, e con Dio. Forse ogni vita ha il proprio senso, forse ci vuole una vita intera per riuscire a trovarlo. Comunque, io ho smarrito qualsiasi rapporto con la vita e con le cose, mi sembra che tutto avvenga per caso e che ci si debba staccare interiormente da ognuno e da ogni cosa. Tutto sembra così minaccioso e sinistro, e ci si sente anche così impotenti».
DIO, PRENDIMI PER MANO
«Mio Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Non penserò più, nella mia ingenuità, che un simile momento debba durare in eterno, saprò anche accettare l’irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora, e cercherò di non aver paura. E dovunque mi troverò, io cercherò d’irraggiare un po’ di quell’amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Ma non devo neppure vantarmi di questo ‘amore’. Non so se lo possiedo. Non voglio essere niente di così speciale, voglio solo cercare di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente. A volte credo di desiderare l’isolamento di un chiostro. Ma dovrò realizzarmi tra gli uomini, e in questo mondo.
E lo farò, malgrado la stanchezza e il senso di ribellione che ogni tanto mi prendono. Prometto di vivere questa vita sino in fondo, di andare avanti».
RIPOSARE TRA LE BRACCIA DI DIO
«Il sentimento che ho della vita è così intenso e grande, sereno e riconoscente, che non voglio neppur provare a esprimerlo in una parola sola. In me c’è una felicità così perfetta e piena, mio Dio. Probabilmente la definizione migliore sarebbe di nuovo la sua: “riposare in se stessi”, e forse sarebbe anche la definizione più completa di come io sento la vita: io riposo in me stessa. E questo “me stessa”, la parte più profonda e ricca di me in cui riposo, io la chiamo “Dio”. Nel diario di Tide ho trovato spesso questa frase: Padre, prendilo dolcemente fra le tue braccia. È così che mi sento, sempre e ininterrottamente: come se stessi fra le tue braccia, mio Dio, così protetta e sicura e impregnata d’eternità. Come se ogni mio respiro fosse eterno, e la più piccola azione o parola avesse un vasto sfondo e un profondo significato...».
DIO ASCOLTA DENTRO DI ME
«Mio Dio, è un bene che tu abbia fatto fermare il mio corpo. Devo guarire completamente per fare ciò che devo. Ma forse, anche questa è un’idea convenzionale. Lo spirito non dovrebbe forse continuare a lavorare e a essere creativo anche quando il corpo è malato? E amare e hineinhorchen [“ascoltare dentro’] se stessi, gli altri, il contesto di questa vita, e te…In fondo, la mia vita è un ininterrotto ascoltar dentro me stessa, gli altri, Dio. E quando dico che ascolto dentro, in realtà è Dio che ascolta dentro di me. La parte più essenziale e profonda di me che ascolta la parte più essenziale e profonda dell’altro. Dio a Dio».

Ma quale vista ti aspetti di scoprire se tutto ciò che è concreto intorno a te lo spingi via? Presumi di scoprire in questo modo la realtà autentica? Non dovresti respingere ciò che è concreto, ma cercare di attraversarlo con lo sguardo, di fargli luce, così che si faccia trasparente e appaia la realtà che si trova dietro. Non respingere, se no arrivi a un vuoto; invece illumina
Etty Hillesum
Il bene quotidiano
La certezza che il bene è una conquista quotidiana, che è necessario "esserci al cento per cento", che si tratta di riflettere a fondo per riuscire ad amare coloro che abbiamo intorno nella convinzione che ognuno debba sradicare e distruggere in se stesso " ciò per cui pensa di dover distruggere gli altri", tutto questo fa di Etty una grande amica; una donna davvero che possiamo imitare a modo nostro, nella quotidianità del bene.
Io scrivo perché attraverso me stessa posso capire gli altri. Questo lasciarmi immergere dai sogni, questo immergermi in me stessa, questa volontà di vivere e sentire in me stessa un infinito amore e una forza, grazie ai quali tutto può essere compreso
Non c' è alcun poeta in me, c'è solo un frammento di Dio in me che potrà crescere fino a diventare un poeta. Mi trovo presa a volte, da una tenerezza infinita, rimango sveglia e lascio che mi passano davanti i fatti, le tante, troppe impressioni di un giorno sempre troppo lungo, e penso: " lasciate che io possa essere un cuore pensante". Voglio esserlo. Sto qui adesso distesa, paziente e nuovamente calma, e mi sento già un pochino meglio.
Sento di nuovo in me la forza di andare, come vada sarà un bene. Si dovrà pregare giorno e notte per queste migliaia. Senza preghiera stare un solo minuto.
Quest'oggi ho imparato una cosa fondamentale, dove per caso ci si trova collocati, là si deve esserci con tutto il cuore. Quando si ha il cuore da un'altra parte e non si riesce a fare abbastanza alla comunità nella quale per caso ci troviamo e la comunità di conseguenza si impoverira'. Che siano impiegate prese dalla carriera o Dio sa cosa, bisogna esserci interamente e così si troverà qualche bene anche in loro.
Intensamente vivere e soffrire e immergersi in questo frammento di vita, da un giorno all'altro ma con lo spirito orientati agli orizzonti vasti che si trovano dietro questi giorni e questi anni. E quindi, avere come un sentimento di purificazione in sé stessi, il sentimento che forse avremo quanto tra diversi anni, divenuti maturi e mutati, guarderemo indietro a questo periodo. Vivere così completamente, con ogni battito del cuore, in questo adesso ricco e privato, e insieme sapere che libere e infinite, le strade si aprono verso gli anni che verranno, verso paesi lontani e anche verso il cielo.
Signore, donami la saggezza piuttosto che la conoscenza. O detto meglio unicamente la conoscenza che porta alla saggezza rende gli uomini felici(me almeno). Un po' di quiete, gentilezza e un po' di sapienza, quando le sento in me sto bene

Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto, ogni norma e appiglio convenzionale, dobbiamo osare il gran salto nel cosmo, e allora, allora sì che la vita diventa infinitamente ricca e abbondante, anche nei suoi più profondi dolori.
Etty Hillesum
Alla ricerca del senso dell’esistere..
È in modo particolare nel relazionarsi con le nuove generazioni che sperimentiamo la presenza, magari configurata anche solo o ancora come bisogno e necessità, del darsi di un senso che sia credibile e condiviso come punto di partenza concreto. Prima ancora dell’idea che il senso scaturisca dal Tu divino, sono i giovani che ci insegnano il valore fondamentale della relazione con gli altri, i quali – come accade quotidianamente – sono fonte di senso e di valore per noi. Davvero concreto e credibile è il muovere da sé e nel contempo dagli altri, in uno scambio reciproco di condivisione.
Questa è la dinamica che, da giovane, caratterizza il vivere di Etty Hillesum. Lei da un’ottica individualistica si è aperta all’altro per incontrare così con stupore e meraviglia l’Altro, e da quest’incontro scaturisce poi un rinnovato modo di relazionarsi alla comunità. Ed è a maggior ragione nella difficoltà contemporanea, che spesso finisce per disorientare e travolgere i giovani alla ricerca di un senso partecipabile, che ritengo vada accolta la testimonianza aurorale di questa giovane donna.
Una fotografia superficiale dell’universo giovanile cade in facili definizioni ed etichetta adolescenti e ragazzi come disimpegnati, bamboccioni, vittime dell’individualismo. Una generazione rinchiusa in una gabbia di amicizie più o meno virtuali, frastornata da miti falsi e illusioni, priva di orizzonti sul futuro. Eppure incontrando i giovani, in carne e ossa, si scopre che sono capaci di mettersi in gioco, pronti a sfatare il luogo comune che lega giovinezza a disinteresse e alla scarsa attitudine alla riflessione.
In un altro orizzonte invece, opposto a quello odierno, anche le nuove generazioni sarebbero accolte per i loro bisogni e riconosciute come co-soggetti di rinnovamento. Ma questo è un dovere tuttora eluso da una parte rilevante del mondo adulto e delle istituzioni. Se non vogliamo sprecare l’immenso valore del dialogo tra le generazioni né mortificare la vita di chi oggi è giovane, occorre prendere distanza dalle attuali identificazioni per cui i giovani sono il «futuro», o sono «risorse», oppure un «problema». In realtà i giovani sono un altro presente.
La loro condizione piuttosto va, a mio parere, considerata secondo la metafora concreta dell’aurora, come emersione di un’identità e una realtà inedita, lungo un percorso nel quale ci si trova dinanzi ad alternative come quelle tra la conoscenza di sé e l’adattamento al mondo così com’è, tra il mantenersi fedeli al desiderio di felicità vera oppure il consegnarsi a suoi surrogati, tra l’aderire – in sintesi e in una immagine – con coraggio alla luce aurorale del primo mattino o consegnarsi alla paura e alla disperazione delle tenebre notturne.
Se infatti si continua a guardare ai giovani con un sentimento di fondo come la paura si genera un autentico contagio: paura degli adulti per i giovani, sfiducia in essi, paure dei giovani verso il futuro, sfiducia in sé e negli adulti. Quando invece si sceglie di aderire al senso della propria esistenza, per quanto oscuro e incerto, con il coraggio della fiducia, si aprono scenari inaspettati e luminosi che ci portano a cogliere nei giovani l’incarnazione della «aurora ripetuta e mai pienamente riuscita, protesa verso il futuro», di cui parla la filosofa spagnola Zambrano.
Oltre la crisi: il dialogo nella speranza
Ovviamente un quadro concettuale, rispetto alla crisi presente, non basta a trovare soluzioni, anzi molto spesso si finisce per rimanere bloccati e pietrificati, per effetto della disperazione. Tra le esperienze che possono farci, al contrario, attraversare la paura c’è senz’altro il dialogo. Con questo intendo la vera condivisione di un cammino in cui ciascuno vede nell’altro un valore reale e incarnato. Ci si narra, si ascolta davvero, si dà tempo, fiducia agli altri, si impara a vivere i conflitti, a portarli e così a superarli. Perciò esso non è solo un dire e lasciar dire, ma è intessuto di emozione, di compassione, di sguardi, di silenzio, di contemplazione, di cura, di tenerezza e, certo, anche di parole.
Si cerca insieme e cercando si può essere attratti da un senso per la vita che sia capace di darci luce e ospitalità, che ci inviti a diventare davvero noi stessi.
Allora dialogare si trasforma in imparare a sperare, a svolgere il sogno di una vita riuscita e non a rinnegarlo per paura o a dimenticarlo. Se non è vero che «i giovani sono il futuro», ma sono il presente, si può però anche dire che essi contribuiscono a generare il futuro, poiché rinnovano il volto di una società, nel momento in cui glielo si permette. E questo è solo uno degli insegnamenti che con abbondanza e ricchezza scaturiscono dagli scritti di Etty; ripercorrendo le tracce del suo cammino impareremo ad assaporare tutta la bellezza della vita, sempre memore del senso che la intesse e che si manifesta, volta per volta, con modalità sorprendentemente differenti, perfino nei momenti di buio più cupo. Dal dialogo che inizialmente lei svolge tra sé e sé, nelle prime pagine del diario («devo affidare il mio animo represso a uno stupido foglio di carta a righe»),[2] passa alla condivisione di un percorso davvero comunitario e comunionale, in virtù dell’imparare a sperare insieme, che contagia positivamente anche le generazioni che si sono succedute alla sua epoca fino ad arrivare a noi.
La vita è così curiosa e sorprendente e infinitamente piena di sfumature, a ogni curva del suo cammino si apre una vista del tutto diversa. La maggior parte delle persone ha nella propria testa delle idee stereotipate su questa vita, dobbiamo nel nostro intimo liberarci di tutto, di ogni idea esistente, parola d’ordine, sicurezza; dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto, ogni norma e appiglio convenzionale, dobbiamo osare il gran salto nel cosmo, e allora, allora sì che la vita diventa infinitamente ricca e abbondante, anche nei suoi più profondi dolori.[3]
Dialogare con lei è un modo per superare la crisi, già a partire dal nostro io più intimo, per compiere «il gran salto» che ci libera dalle consuete paure. In tale prospettiva gli educatori devono percepire e interpretare questo tipo di svolta per partecipare al cammino dei giovani in modo maieutico, credibile e liberante, altrimenti eludono o sprecano la grande ricchezza della relazione con le nuove generazioni e fanno mancare loro dei riferimenti essenziali per crescere come persone luminose.
I giovani disposti a farsi «incontrare» dalla sua sensibilità e spiritualità, nel contempo, riceveranno in dono la rinuncia a escludere, a negare e a distruggere, acquisteranno come abitudine «il coraggio di guardare in faccia ogni dolore»,[4] premessa per giungere a una forma di vita e di convivenza libera dal dominio e da qualsiasi logica di violenza.
Il coraggio di pronunciare il nome di Dio
Il passaggio dalle tenebre alla luce aurorale nella biografia di Etty Hillesum è, secondo la mia interpretazione, ravvisabile nella svolta radicale che segue le primissime pagine del suo Diario, ancora totalmente autocentrate. La svolta non riguarda innanzitutto il fare, l’attivismo, le opere. Certo, dovrà giungere a tutto questo. Piuttosto la svolta consiste, in primo luogo, nel formarsi di una integrità sconosciuta nell’anima, di una interezza e di una elevazione a una semplicità nuova. Mi riferisco al suo incontro, personale e unico, con Dio, al suo coraggio di pronunciarlo finalmente senza esitazione né timore. Così, giorno per giorno, la sua esistenza diviene la testimonianza vissuta del consiglio rivolto da S. Paolo ai Filippesi:
«Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù» (Fil 4, 4-7).
Davvero il cammino da lei compiuto, e che cercheremo di ripercorrere, trasforma il suo essere in modo talmente radicale che ad una lettura superficiale si farebbe fatica a ritrovare la stessa ragazza dell’esordio del Diario nelle ultime pagine.
Mi hai resa così ricca, mio Dio, lasciami anche dispensare agli altri a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. (…) A volte vorrei incidere delle piccole massime e storie appassionate, ma mi ritrovo prontamente con una parola sola: Dio, e questa parola contiene tutto e allora non ho più bisogno di dire quelle altre cose.[5]
Ciò che permette l’utilizzo del termine Dio è riconoscibile quindi nella maturazione interiore e personale, grazie alla quale tale parola cessa di essere un termine, o ancora meglio, un concetto astratto, per divenire finalmente nome.
Seguendo le sue tracce si comprende come la fede però non sia solo un sentimento dell’anima umana, ma soprattutto l’ingresso dell’uomo nella realtà, nella sua totalità. Questa è per Etty una semplice constatazione, ma si intravede la contraddizione che in essa si cela rispetto all’abituale modo di pensare.
Seguire il suo percorso è rispondere ad un invito a percorrere tappe verso la «pace futura» che però nasce innanzitutto nel nostro intimo, prima di poterla scoprire nel mondo esterno. Perciò mettersi sulle sue tracce significa ripartire da una nuova spiritualità, imparando a dialogare non più solo con sé, ma ripartendo dal colloquio con Dio, per incontrare infine, in modo rinnovato, ogni altro. Questo perché certamente, per lei, la fede non investe solo il sentire umano, non è solamente legata alla sfera intima e personale, ma implica un rapporto responsabile con il reale.
Vorrei trovarmi in tutti i campi che sono sparsi per tutta l’Europa, vorrei essere su tutti i fronti; io non voglio per così dire «stare al sicuro», voglio esserci, voglio che ci sia un po’ di fratellanza tra tutti questi cosiddetti «nemici» dovunque io mi trovi, voglio capire quel che capita; e vorrei che tutti coloro che riuscirò a raggiungere – so che sono in grado di raggiungerli, fammi guarire, mio Dio – possano capire questi avvenimenti come li capisco io.[6]
È come dire che il primo coraggio sta nel pronunciare la parola Dio e successivamente ripetere questa decisione di nominare il Tu eterno declinandola nella nostra quotidianità, così come riaccade ogni giorno l’alba, attraverso scelte, frutto di comprensione reale, che rivelano il valore e il senso che per noi possiede la relazione con Lui.
La speranza pertanto che muove il mio scrivere è rivolta ai giovani, al loro essere nascente e costantemente aurorale, alla loro sensibilità spesso costretta entro schemi costruiti dagli adulti, alla loro insaziabile fame di felicità, perché dalla testimonianza di Etty Hillesum riescano a trarre svolte innanzitutto spirituali, ciascuno a suo modo nel rispetto dell’unicità personale, che permettano loro di pronunciare, alla fine del percorso compiuto insieme, quanto confidato da Jopie, una cara amica di Etty, il giorno della partenza di quest’ultima per Auschwitz:
«ed eccomi qua, certo un po’ triste per qualcosa che si è perduto eppure no, perché un’amicizia come la sua non è mai perduta, c’è e rimane».[7]
NOTE
[1] M. Zambrano, Persona e democrazia. La storia sacrificale, Bruno Mondadori, Milano 2000, pp. 28-29.
[2] E. Hillesum, Diario 1941-1943, Adelphi edizioni, Milano 2005, p. 23.
[3] Ibidem, p. 158.
[4] Ibidem, p. 233.
[5] Ibidem, pp. 253-254.

Il significato dei Diari
di Etty Hillesum
Klaas Smelik
Se non vogliamo leggere il diario di Etty Hillesum esclusivamente come opera letteraria, né come un documento di rilevanza storica, allora la domanda è : quale senso possiamodare alle sue parole settant’anni dopo? Proporrei due risposte delle molte possibili.
1. Credere in Dio
In primo luogo vorrei parlare della rilevanza teologica della sua opera. Sembra strano, perché Etty Hillesum non era una teologa. Non aveva una formazione teologica. E il suo stile di vita avrebbe suscitato qualche perplessità di quel ambiente, sicuramente in quel epoca.
Etty Hillesum non intendeva riconoscersi integralmente in alcuna concezione del mondo, in alcuna ideologia. È un aspetto importante della sua visione della vita che ben si accorda con quella maggiormente in auge ai nostri giorni, nei quali riscontriamo una profonda avversione nei confronti delle ideologie. Molti si sono cioè lasciati alle spalle le concezioni ideologiche totalizzanti. È interessante constatare come Etty Hillesum esprima questa convinzione già nel 1941. Per chiarire il punto, vorrei riportare un suo passo relativo all’incontro a cui assistette tra i suoi amici Julius Spier e Werner Levie. Ecco come una sera i due discussero sul rapporto tra Cristo e gli ebrei:
Venerdì [28 Novembre 1941] sera dialogo tra S[pier] e L[evie]: Cristo e gli ebrei. Due filosofie di vita, ambedue nettamente delineate, brillantemente documentate, compiute e armoniose, difese con passione e aggressività. Trovo tuttavia che in ogni concezione della vita difesa con piena consapevolezza penetri sempre l’inganno, e che alla fine la verità venga aggredita in nome dell’ideologia.
Tuttavia il suo diari contiene diversi brani di cui la profondità teologica non che in molte opere teologiche di rinnomate non si trovano. Per esempio il seguente brano:
Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalle bufere di questi ultimi giorni, i suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure e melmose che si sono formate sul tetto basso del garage. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire indisturbato, esuberante e tenero come sempre, e spande il suo profumo tutt’intorno alla tua casa, mio Dio. Vedi come ti tratto bene. Non ti porto soltanto le mie lacrime e le mie paure, ma ti porto persino, in questa domenica mattina grigia e tempestosa, un gelsomino profumato. Ti porterò tutti i fiori che incontro sul mio cammino, e sono veramente tanti. Voglio che tu stia bene con me. E tanto per fare un’esempio: se io mi trovassi rinchiusa in una cella stretta e vedessi passare una nuvola davanti alla piccola inferriata, allora ti porterei quella nuvola, mio Dio, sempre che ne abbia ancora la forza. Non posso garantirti niente a priori, ma le mie intenzioni sono ottime, lo vedi bene.
E ora mi dedico a questa giornata. Mi troverò fra molta gente, le tristi voci e le minacce mi assedieranno di nuovo, come altrettanti soldati nemici assediano una fortezza inespugnabile.
In questo e in altri brani Etty Hillesum scrive “mio Dio” e a Lui rivolge la parola. Dobbiamo però chiederci: quale significato riveste, per lei, questo modo di scrivere? Anche una lettura sommaria del diario dimostra come la parola Dio non abbia sempre la stessa accezione. Cerchiamo di comprendere meglio questo punto esaminando alcuni frammenti dei primi quaderni diaristici nei quali è presente la parola Dio.
L’uso di questa terminologia potrebbe essere un’imitazione della figura stilistica usata da Rilke, che per la Hillesum costituiva un traguardo. Il poeta praghese, una personalità assai complessa, ebbe una carriera letteraria che si sviluppò attraverso varie fasi. Nel cosiddetto secondo periodo egli pubblicò il poema Das Stunden-Buch (Il libro d’ore, 1905) e anche il carteggio con Lou Andreas-Salomé, alla quale il poeta dedicò l’opera. Fu questa la fase creativa che più interessò Etty Hillesum, anche se costei lesse diverse altre opere di Rilke scritte successivamente.
Ne Il libro d’ore il poeta parlò a Dio come se stesse parlando a sé stesso. Rilke non considerava Dio un’entità trascendente ma qualcosa presente dentro di sé. Ci si potrebbe domandare se il nome ‘Dio’ non fosse soltanto una metafora letteraria volta alla spiegazione delle sue idee. Se così fosse, il termine ‘Dio’ non avrebbe alcun significato al di fuori dei confini dell’opera letteraria del poeta.
Etty Hillesum ha introdotto la parola Dio come una figura immaginaria con lo scopo di rendere più agevole l’espressione dei suoi pensieri. Lo si vede con chiarezza nella citazione seguente:
Quando prego, non prego mai per me stessa, prego sempre per gli altri, oppure dialogo in modo pazzo, infantile o serissimo con la parte più profonda di me, che per comodità chiamo «Dio».
Dio, in questo caso, non è che una comoda locuzione per quello che l’autrice considerava la parte più profonda di sé. Abbiamo a che fare, a mio parere, con un’imitazione del modello letterario che Rilke applicò ne Il libro d’ore.
Se le cose stanno così, pregare è solo un modo di parlare a sé stessi. Ma perché Etty Hillesum avrebbe dovuto prendere in prestito da Spier un rituale che questi aveva mutuato dal cristianesimo? Perché mettersi in ginocchio come fosse una cattolica fervente? Non è un gesto superfluo, se non si fa altro che accingersi a parlare con sé stessa? Ma vediamo cosa ha scritto al riguardo il 10 ottobre 1942:
Di questa vita e di questa epoca credo di poter sopportare e accettare ogni cosa. E quando la burrasca sarà troppo forte e non saprò come uscirne, mi rimarranno sempre due mani giunte e un ginocchio piegato. È un gesto che a noi ebrei non è stato tramandato di generazione in generazione. Ho dovuto impararlo a fatica. […] Com’è strana la mia storia – la storia della ragazza che non sapeva inginocchiarsi. O con una variante: della ragazza che aveva imparato a pregare. È il mio gesto più intimo, ancor più intimo dei gesti che riservo a un uomo.
Mettersi in ginocchio per pregare segnò l’inizio del percorso che l’avrebbe portata al concetto di ‘Dio’, concetto che acquisisce sempre maggior significato col procedere della stesura dei suoi diari, sebbene risulti molto difficile tracciare la precisa cronologia di questa evoluzione.
Trascendenza rispetto a immanenza
Possiamo avvicinarci a questo sviluppo prendendo in considerazione la differenza tra la trascendenza e l’immanenza di Dio. La Bibbia ritrae Dio come un essere trascendente, un essere che regna nel cielo. Il Dio di Israele è un individuo con un carattere ben definito e non, a differenza di come è stato descritto da alcuni filosofi greci, un principio generale. Il Dio della Bibbia non può essere trovato in un essere umano. Al Suo cospetto l’uomo non è altro che polvere e cenere.
Ma nonostante questa disuguaglianza Egli vive con il suo popolo, per riportare un pensiero di Martin Buber, uno degli autori letti da Etty Hillesum, un rapporto Io-Tu.
In contrasto con tutto ciò, Etty Hillesum tende ad alludere a un’immagine di Dio come alla parte più intima dell’essere umano, ovvero a un dio immanente. Scrive il 17 settembre 1942:
Il mio sentimento della vita è così intenso e grande, sereno e riconoscente, che non voglio neppure provare a esprimerlo in una parola sola. In me c’è una felicità assolutamente perfetta e piena, mio Dio. E ciò, come al solito, trova la sua espressione migliore nelle sue parole [di Spier]: «riposare in se stessi», e sarebbe forse anche l’espressione più compiuta del mio generale sentire nei confronti dellavita: io riposo in me stessa. E chiamo questo «me stessa», la parte più ricca e profonda di me in cui riposo, «Dio».
È un linguaggio chiaro. Questo Dio non è il l’essere trascendente della Bibbia che risiede nei cieli. È invece la serenità che la giovane ebrea sente nel suo intimo. Nel passo che segue la Hillesum sembra voler abbandonare il nome ‘Dio’: questo il brano del 22 giugno 1942
Mi trovo a iniziare, ma è un inizio che c’è, lo so per certo. Significa aver richiamato su di sé tutte le forze possibili e vivere la propria vita con Dio e in Dio e avere Dio in sé stessi. (A volte trovo la parola Dio davvero primitiva: è solo qualcosa che le somiglia, dopotutto, un avvicinamento alla nostra più grande e ininterrotta avventura interiore; credo di non aver neppure bisogno della parola Dio, che a volte mi sembra un suono primitivo, primordiale. Una struttura di rinforzo.) E se la sera, a volte, sento il bisogno di parlare a Dio e dico molto infantilmente: Dio, con me non può andare avanti così e talvolta le mie preghiere possono essere molto incerte e imploranti –, allora è proprio come se mi rivolgessi a qualcosa dentro di me, o come se cercassi di padroneggiare una parte di me stessa.
Il punto cardine presente in questo passo è il commento chiarificatore proposto da Etty Hillesum: “credo di non aver neppure bisogno della parola Dio, che a volte mi sembra un suono primitivo, primordiale. Una struttura di rinforzo.” Quest’affermazione va molto oltre rispetto alla definizione di Dio citata prima: “la parte più ricca e profonda di me in cui riposo, io la chiamo «Dio»”. La locuzione “Una struttura di rinforzo” ci riporta all’uso rilkiano della parola Dio.
Dio vive dentro di noi
Tutto ciò ci porta a formulare la seguente domanda: se Etty Hillesum chiama ‘Dio’ la parte più profonda di sé stessa, vuol dire che Dio è la parte più profonda della sua persona o è qualcosa che, dall’esterno, ha messo radici nella sua interiorità? Tra questi due concetti c’è una notevole differenza. Nel primo caso, la parte più profonda presente in un individuo è divina; nel secondo, Dio ha scelto di dimorare in ogni essere umano. Quel che abbiamo letto nel passo appena citato sembra avvalorare la prima opzione. Altri brani dimostrano invece come Etty Hillesum immagini Dio che va a risiedere nella persona muovendosi addirittura all’interno del corpo, dalla testa al cuore. Ciò viene spiegato dal brano contenuto in una lettera del 25 gennaio 1942:
Il Cosmo si è spostato dalla testa al cuore o, per quanto mi riguarda, al diaframma: in ogni caso, dalla testa a un’altra zona. E una volta che Dio ha traslocato dentro di me, prendendo possesso di uno spazio in cui ancora risiede, allora sì, di colpo sono cessati i dolori alla testa e allo stomaco!
Non sempre Etty Hillesum aveva accesso a Dio. La giovane ebrea illustra dunque questa situazione ricorrendo, il 26 agosto 1941, all’immagine che segue:
Dentro di me c’è un pozzo molto profondo. E in quel pozzo c’è Dio. A volte riesco a raggiungerlo, più spesso è coperto da pietre e detriti, allora Dio è sepolto. Allora bisogna dissotterarlo di nuovo.
All’inizio Etty Hillesum non sarebbe stata in grado di effettuare questo lavoro di scavo da sola, avrebbe avuto bisogno dell’aiuto di Julius Spier. Un ausilio che, in una lettera del 11 settembre 1942, descrive così:
La grande opera che [Spier] ha svolto sulla mia persona: ha dissotterrato Dio dentro di me e lo ha portato alla vita e adesso sarò io a continuare, scavando alla ricerca di Dio nel cuore di tutti gli uomini che incontrerò, in qualsiasi luogo di questa terra.
Dissotterrare Dio dentro sé stessa e le altre persone: una tematica che la Hillesum considera fondamentale. Durante il periodo in cui lavorò nel campo di Westerbork ritenne che questo fosse il suo compito principale. Il 17 settembre scrive:
Non è sufficiente di predicarti soltanto mio Dio, di annunciarti agli altri, di disseppellirti nei cuori degli altri. Tocca a liberare negli altri la strada che porta a te, mio Dio e perciò uno deve essere un grande conoscitore dell’animo umano. Si deve essere uno psicologo esperto. I rapporti con padre e madre, ricordi giovanili, sogni, sensi di colpa, complessi d’inferiorità, insomma tutto quanto. In ognuno che viene da me comincio un cauto cammino di ricerca. Gli attrezzi per aprire negli altri un varco che porta a te sono ancora rudimentali. Ma qualche strumento c’è già e lo migliorerò, pian piano e con pazienza. E ti ringrazio, che mi hai dato il dono di poter leggere negli altri e di poter trovare la via negli altri. A volte le persone sono per me come case con la porta aperta. Entro e giro per i corridoi e le stanze e ogni casa è arredata in modo un po’ diverso ma tuttavia sono tutte uguali alle altre, di ognuna si dovrebbe fare una dimora consacrata a te, mio Dio. E ti prometto, ti prometto, cercherò di trovarti ospitalità e un focolare nel maggior numero di case possibile.
Dio come una persona di fronte a sé
Quando Etty Hillesum promise a Dio che Gli avrebbe trovato una dimora, Gli parlò come se stesse parlando a una persona che le stava di fronte, quindi nella maniera della Bibbia che abbiamo indicato sopra. Sembra che abbia attraversato il confine tra un Dio immanente e uno trascendente. Ma è davvero così? Vediamo il passo del l’11 luglio 1942:
Molte persone mi rimproverano l’indifferenza e la passività e dicono che mi arrendo così. E dicono: chiunque sia in grado di sfuggire alle loro grinfie deve provare a farlo, è un dovere. […] Il buffo è che, sia che rimanga qui, sia che venga trasferita altrove, non mi sento nelle loro grinfie. Trovo tutto questo banale e grossolano, non riesco assolutamente a seguire il ragionamento, non mi sento nelle grinfie di nessuno, mi sento solo nelle braccia di Dio, per dirla con qualche bella parola; e che ora mi trovi qui, a questa scrivania terribilmente cara e familiare, o fra un mese in una nuda camera del quartiere ebraico o fors’anche in un campo di lavoro sotto la sorveglianza delle SS, credo che mi sentirò sempre nelle braccia di Dio.
In questo passo Etty Hillesum esprime la sensazione stando alla quale si sente più nelle braccia di Dio che nelle grinfie dei nazisti. L’immagine è in contrasto con la metafora del Dio che si trova dentro di lei. Nel brano appena citato descrive Dio come qualcuno che la prende tra le sue braccia e la protegge. Si tratta di una metafora? O magari di alcune frasi volte a esprimere un senso di sicurezza e calore derivante dalla presenza di un Dio che esiste al di fuori di lei?
In un altro brano la giovane ebrea non parla delle braccia di Dio ma della Sua mano, che la guida sul proprio cammino. Il 25 novembre 1941 scrive:
Dio, prendimi per mano, ti seguirò da brava, non farò troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita, cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di tranquillità. Non penserò più, nella mia ingenuità, che un simile momento debba durare in eterno, saprò anche accettare l’irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza mi piacciono ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo, purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora, e cercherò di non avere paura.
Risulta evidente, nel passo appena riportato, che Dio è un essere nelle cui braccia Etty Hillesum riposa e di cui seguirà il volere. Oltre all’immagine di Dio che dimora nella sua interiorità, aveva un altro modo di scrivere di Dio: traendo cioè spunto da quanto è stato scritto sul Dio di Israele nella Bibbia. E tutto ciò ci induce a porre la seguente domanda: fino a che punto la Hillesum si è ispirata, per il proprio concetto di Dio, al Dio della Bibbia?
Il Creatore del cielo e della terra
Su un punto la Hillesum si trovò sulla stessa lunghezza d’onda degli autori biblici: Dio è il creatore del cielo e della terra. Trova il primo capitolo della Bibbiaaffascinante ma, come scrive il 28 giugno 1942, anche “terribilmente ingenuo”:
Con 5 tavolette di carbone e una mentina, prese a stomaco vuoto, ho letto il primo capitolo della Genesi. La trovo davvero impressionante: “La terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.” E forse, da parte mia, può sembrare impertinente, mi sembra però che il resto del capitolo sia alquanto naïf. Mi hanno commossa soprattutto quei “grandi mostri marini”.
Ho già tentato di irrompere in più passi della Bibbia, una volta in Giovanni, un’altra nei Salmi, ecc. Stamattina mi sono ripromessa di ricominciare dalla prima lettera dell’Antico testamento e ogni mattina, a stomaco vuoto, un passetto oltre. Prima o poi dovrò chiedere al mio amico lettore-della-Bibbia perché trovo quel capitolo così naïf da lasciarmene, in un modo o nell’altro, commuovere.
L’immagine di Dio come Creatore del cielo e della terra viene sottolineata nel seguente passo tratto da una lettera del 18 agosto 1943:
Mi hai resa così ricca, mio Dio, lasciami anche dispensare agli altri a pieni mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i piedi piantati sulla tua terra, gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono sul volto, lacrime che sgorgano da profonda emozione e riconoscenza. Anche di sera, quando sono coricata nel mio letto e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia e questa è la mia preghiera.
In Etty Hillesum ci imbattiamo nell’opinione, da ritenersi tipicamente ebraica, che valuta positivamente la creazione. Nonostante tutto ciò che gli uomini si fanno l’un l’altro, la Hillesum continua a lodare la creazione di Dio. Fa inoltre sua l’idea, risalente agli scrittori biblici, stando alla quale l’uomo è stato creato a immagine di Dio. Per lei, come abbiamo già visto sopra, è un punto fondamentale. Sono stati creati a immagine di Dio – c’è Dio anche in loro – pure gli uomini che si combattono durante la guerra. La Hillesum vuole tenere i piedi per terra, in realtà, ma nel frattempo continua a lodare la creazione, come vediamo molto chiaramente nel seguente passo del 29 maggio 1942:
Dio, certe volte non si riesce a capire e ad accettare ciò che i tuoi simili si fanno l’un l’altro su questa terra, in questa epoca tempestosa. Ma non per questo mi rinchiudo nella mia stanza, Dio: continuo a guardare le cose in faccia e non voglio sfuggire dinanzi a nulla, cerco di comprendere i delitti più gravi, cerco ogni volta di rintracciare il nudo, piccolo essere umano che spesso non dà più traccia di sé. Io non me ne sto qui in una stanza tranquilla ornata di fiori, a sguazzare tra Poeti e Pensatori glorificando Iddio, non sarebbe affatto difficile, né credo di essere così «fuori dalla realtà» come dicono inteneriti i miei buoni amici. Ogni persona ha la sua realtà, lo so, ma io non sono una visionaria, persa nei sogni, un’«anima bella» ancora un po’ immatura […]. Guardo il tuo mondo in faccia, Dio, e non sfuggo alla realtà per rifiugiarmi nei sogni – voglio dire che accanto alla realtà più atroce c’è posto per qualche bel sogno – e continuo a lodare la tua creazione, malgrado tutto!
La vita è bella e ha un senso – e vediamo di nuovo come Etty Hillesum esprima il tipico ottimismo ebraico, che ha dato a questo popolo la forza di sopravvivere a duemila anni di persecuzioni e angosce. Anche se la Hillesum era consapevole delle intenzioni dell’occupante tedesco, volte alla distruzione degli ebrei d’Europa, ha continuato a credere in Dio e nella vita. Vediamo questo brano scritto il 7 luglio 1942:
Di minuto in minuto desideri, necessità e legami si staccano da me, sono pronta a tutto, a ogni luogo di questa terra nel quale Dio mi manderà, sono pronta a testimoniare, in ogni situazione e nella morte, che questa vita è bella e colma di senso e che non è colpa di Dio, ma nostra, se le cose sono così come sono, ora.
Ma perché – ci domandiamo – non è stata colpa di Dio se nel 1942 la Sua creazione era così a repentaglio da indurre tutti quanti, nel mondo, a correre, a combattere, a rubare e ad ammazzare? Questa domanda ci porta al cuore del messaggio che Etty Hillesum ha lasciato ai posteri.
Responsabilità
Abbiamo visto come negli scritti della Hillesum Dio sia il creatore del cielo e della terra; il che viene affermato del resto anche nella Bibbia. Secondo il credo degli Apostoli, Dio possiede però un ulteriore connotato, e cioè la sua onnipotenza.
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
Ma non è così che Etty Hillesum percepiva Dio. Egli, a differenza di quanto ci insegna la tradizione, non è onnipotente. Non può aiutarci. Siamo noi, vale a dire coloro che da Lui sono stati creati, a doverlo aiutare, come risulta dal testo hillesumiano forse più celebre, la preghiera della domenica mattina che risale al 12 luglio 1942:
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire l’oggi con il peso delle miei preoccupazioni per il futuro, ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché tu dentro di me non ceda, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, Dio. E forse possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa fare molto per modificare le circostanze, appartengono a questa vita anch’esse. Io non ti chiamo a risponderne, sarai tu più tardi a chiamarci a risponderne. E, quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutarti, e che dobbiamo difendere fino all’ultimo la tua casa dove tu dimori in noi.
Etty Hillesum è del parere che Dio non riesca a influenzare le vicende umane. Questa idea costituisce l’esatto contrario dell’immagine biblica di un Dio Redentore che agisce nella storia. La Hillesum fa un ulteriore passo in avanti e afferma che “siamo noi a dover aiutare Te”. A differenza dell’affermazione precedente, tale ultima nozione non è estranea all’ebraismo. Concetti cabalistici quali Tsimtsum e Tikun Olam hanno ricevuto, col passare del tempo, un’interpretazione più pratica e meno spirituale; nella filosofia ebraica moderna l’uomo è di conseguenza concepito come colui che aiuta Dio nel rimettere in ordine il mondo. Questa convinzione appare agli antipodi della dottrina di un Dio onnipotente, ma non oltrepassa i confini del pensiero ebraico.
Il passo citato del diario ha dato origine a qualche equivoco. Etty Hillesum non sostiene che Dio sia indifeso e che noi esseri umani dobbiamo dunque aiutarlo. Il concetto di un ‘Dio indifeso’, in lei, è assente – la Hillesum intende dire che Dio si trova al di fuori delle vicende umane e non è pertanto in grado di intervenire. Badare a sé stessi spetta agli uomini.
Invece di aspettarsi aiuto da Lui, sono questi ultimi che devono aiutarlo. Dio non può fare nulla per mutare il corso delle vicende belliche. Non è colpa sua, se gli orrori si perpetuano – sono imputabili agli esseri umani. La creazione di Dio è buona come bella è la vita – nonostante la guerra e le persecuzioni. In una lettera della fine di giugno del 1943, indirizzata al suo amico Han Wegerif, la Hillesum scrive:
E malgrado tutto si approda sempre alla stessa conclusione: la vita è pur sempre buona, non dipende da Dio se le cose, a volte, vanno tanto male, ma dipende da noi. Questa è la mia conclusione, anche ora, anche se sarò spedita in Polonia con tutta la famiglia.
Dal momento che la violenza è commessa dagli uomini, delle cui azioni Dio non è responsabile pur riservandosi il diritto di chiamarli a risponderne. Egli non è responsabile di tutta questa violenza e ingiustizia. Non lo riguarda, è affare degli uomini. Costoro non possono nascondersi dietro Dio ma, come sta scritto nella Bibbia, dovranno giustificarsi al Suo cospetto. Diceva la Hillesum nel passo appena citato: “Io non chiamo in causa la Tua responsabilità. Più tardi sarai Tu a dichiarare responsabili noi.” E lo ripete addirittura due volte, con profonda partecipazione emotiva, nel passo del 29 giugno 1942:
Dio non è responsabile verso di noi, siamo noi a esserlo verso di lui. So quel che ci può ancora succedere. Adesso io sono separata dai miei genilori e non li posso raggiungere, anche se si trovano a due ore di viaggio da qui: ma so esattamente in che casa abitano, so che non patiscono la fame e che sono circondati da molte persone ben disposte verso di loro. E anche loro sanno dove sto io. Ma potrà venire un tempo in cui non saprò più niente, e i miei genitori saranno deportati e moriranno miseramente, chissà dove: so che può succedere. Le ultime notizie dicono che tutti gli ebrei saranno deportati dall’Olanda in Polonia, passando per la Drenthe. E, secondo la radio inglese, dall’aprile scorso sono morti 700.000 ebrei, in Germania e nei territori occupati. Se rimarremo vivi, queste saranno altrettante ferite che dovremo portarci dentro per sempre.
Eppure non riesco a trovare insensata la vita, Dio, non ci posso fare nulla. E Dio non è nemmeno responsabile verso di noi per le insensatezze che noi stessi commettiamo: i responsabili siamo noi! Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento. So tutto quanto e non mi preoccupo più per le notizie future, in un modo o nell’altro so già tutto. Eppure trovo questa vita bella e ricca di senso. Ogni minuto.
Mentre la Shoah veniva perpetrata, Etty Hillesum ha dato una risposta inequivocabile alle molte domande che sono state poste nel dopoguerra sul perché Dio non sia intervenuto quando i nazisti hanno perseguitato e sterminato il Suo popolo. “E Dio non è nemmeno responsabile verso di noi per le assurdità che noi stessi commettiamo: i responsabili siamo noi!” Mentre altri ritenevano Dio responsabile per i crimini di guerra commessi dagli uomini, la Hillesum era in grado di distinguere tra i diversi ambiti di responsabilità. Gli esseri umani sono responsabili per quel che fanno. Dio non c’entra. La domanda non è: dov’era Dio durante la Shoah, ma piuttosto: dov’era il genere umano durante la persecuzione del popolo ebraico?
Per quanto riguarda la concezione di Dio di Etty Hillesum, abbiamo pertanto due elementi fondamentali.
C’è, in primo luogo, un doppio concetto di Dio. La combinazione tra la nozione di Dio in quanto parte più profonda di sé e la visione biblica di un Dio che ci guarda, è un modo di pensare Dio che trova ampi consensi. In questa immagine di Dio ben si integrano due concetti teologici: quello relativo a un Dio immanente e a uno trascendente.
In secondo luogo, c’è l’idea di un Dio che non interviene nella storia umana; riguardo alle nostre azioni, Egli può tuttavia sempre richiamarci alle nostre responsabilità. Si tratta di un concetto davvero intrigante che toglie ogni ragion d’essere a una serie di domande inutili quali: perché Dio permette il genocidio? Perché permette lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo? Quesiti di questo genere si fondano su un presupposto: Dio deve impedire agli uomini di fare del male. E ponendoci domande simili noi tendiamo a declinare ogni responsabilità per le nostre azioni e quelle altrui. Tale tipo di domande, inoltre, non chiarisce affatto la nostra concezione di Dio. Quello che ha scritto Etty Hillesum ci porta invece fuori dalle ombre dell’agire umano e sulla strada che ci riconduce a Dio.
2. Credere negli uomini
Etty Hillesum non si limita ad affermare il suo credo in Dio ma, nonostante tutte le atrocità da loro commesse durante quegli anni di guerra, anche negli uomini. Non si stancò mai di ripetere che le persone non avrebbero dovuto odiarsi a vicenda ma, al contrario, si sarebbe dovuto lavorare per eliminare l’odio nel mondo o, almeno, per tentare di mitigarlo. Questa convinzione irenica suscitò delle reazioni negative già durante la sua vita ma anche oggi, dopo la pubblicazione dei suoi diari, rimane per alcuni lettori un aspetto difficilmente comprensibile. Il secondo aspetto del significato attuale della sua opera, che desidero proporvi riguarda il modo in cui Etty Hillesum si oppose alla coltivazione di un immagine del nemico, di cui intuiva le importanti conseguenze.
È importante notare come Etty Hillesum abbia rifiutato le conseguenze delle azioni destinate ad alimentare l’animosità. L’idea che vede nel singolo individuo il nemico del suo simile sta alla base di ogni conflitto armato. La guerra in Bosnia ne è un esempio straziante. Fino al 1992, i diversi gruppi etnici che formavano l’insieme della popolazione (croati cattolici, serbi ortodossi, bosniaci musulmani ed ebrei), avevano vissuto in pace. Dopo la disintegrazione della Jugoslavia le popolazioni si sono trovate coinvolte in una spirale di violenza, odio e terrore, il tutto basato sulla convinzione della reciproca ostilità. E ora, finita la guerra, quelle stesse popolazioni sono chiamate a collaborare per ricostruire la propria vita e il proprio paese.
Considerata da questa prospettiva, la concezione di Etty Hillesum non ha perso nulla del suo significato per noi oggi. Nell’annotazione diaristica del 27 febbraio 1942 la giovane ebrea descrive, con il suo stile inconfondibile, la visita alla scuola di Amsterdam che era stata espropriata dalla Gestapo:
Mercoledì mattina presto, quando ci siamo trovati in tanti in quel locale della Gestapo, i fatti delle nostre vite erano tutti uguali: eravamo tutti nello stesso ambiente, gli uomini dietro la scrivania quanto quelli che venivano interrogati. Ciò che avrebbe deciso la vita di ciascuno sarebbe stata la disposizione mentale nei confronti di quei fatti.
Si notava subito un giovane che camminava su e giù con un`espressione palesemente scontenta, assillato e tormentato. Davvero interessante da osservare. Cercava dei pretesti per urlare a quei poveri ebrei: Mani fuori dalle tasche per favore. ecc. Per me era da compiangere più di coloro a cui stava urlando; e questi, a loro volta, facevano pena nella misura in cui erano impauriti.
Quando mi sono presentata davanti alla scrivania, mi ha urlato improvvisamente: Che ci trova di ridicolo? Avrei risposto volentieri: Niente, tranne lei, ma per diplomazia m’è parso meglio lasciar perdere. Lei non fa che ridere, continuava a urlare lui. E io, in tutta innocenza: Non me ne accorgo proprio, è la mia faccia normale. E lui: Per favore non dica scemenze, vada fffuori, con una faccia che voleva dire: tra poco mi sentirai. Credo che questo fosse il momento psicologico in cui avrei dovuto spaventarmi a morte, ma quel trucco l’ho capito troppo in fretta.
Nel passo citato la Hillesum unisce alla lucida analisi di quel che succede nell’aula della scuola un ammirevole distacco e una sottile ironia. Rifiutò di partecipare alla scena, allestita dalla Gestapo allo scopo di intimidire e spaventare gli ebrei presenti, sottraendosi dall’interpretare il ruolo che le era stato assegnato, quello del nemico. Rifiutò per non lasciare che l’odio, nutrito per il giovane membro della Gestapo solo in quanto schierato nella parte avversa, la soggiogasse. Per lui, sentiva piuttosto pietà.
Sarebbe tuttavia scorretto pensare che Etty Hillesum non si rendesse conto che quel tipo di persona avrebbe potuto essere un assassino. Scrive, al contrario, nello stesso passo:
[…] ben sapendo che questi ragazzi sono da compiangere finché non possono fare del male, ma che diventano pericolissimi se sono lasciati liberi di aggredire altri esseri umani, e vanno eliminati. Ma a essere criminale è solo il sistema che utilizza questi uomini.
Rinunciare all’animosità non significa certamente rinunciare a combattere il male con tutti i mezzi. Ma è il sistema, e non l’individuo, che va combattuto. Pensando a quanto l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 abbia risvegliato l’animosità dell’occidente, è interessante notare come la pagina del diario del 23 settembre 1942 sia tornata a essere estremamente attuale. Per me questo passo è particolarmente significativo perché è indirizzato a mio padre, con il quale condivido il nome:
Klaas, volevo solo dire questo: abbiamo ancora così tanto da fare con noi stessi, che non dovremmo neppure arrivare al punto di odiare i nostri cosiddetti nemici. Siamo ancora abbastanza nemici fra noi. E non ci siamo nemmeno quando dico che esistono carnefici e persone malvagie anche tra noi. In fondo, non credo affatto nelle cosiddette «persone malvagie».
Vorrei poter raggiungere le paure di quell’uomo e scoprirne la causa, vorrei ricacciarlo nei suoi territori interiori, Klaas, è l’unica cosa che possiamo fare di questi tempi.
Allora Klaas ha fatto un gesto stanco e scoraggiato e ha detto: Ma quel che vuoi tu richiede tanto tempo, e ce l’abbiamo forse? Ho risposto: Ma a quel che vuoi tu si lavora da duemila anni della nostra era cristiana, senza contare le molte migliaia di anni in cui esisteva già un’umanità – e che cosa pensi del risultato, se è lecito chiedertelo?
E con la solita passione, anche se cominciavo a trovami noiosa perché finisco sempre per ripetere le stesse cose, ho detto: È proprio l’unica possibilità che abbiamo, Klaas, non vedo alternative di sorta, ognuno di noi deve raccogliersi ed estirpare da se stesso e distruggere ciò per cui ritiene di dover distruggere gli altri. E convinciamoci che ogni atomo di odio che aggiungiamo a questo mondo lo rende ancora più inospitale.
E Klaas, vecchio e indomabile militante di classe, ha replicato sorpreso e sconcertato insieme: Sì, ma… ma questo sarebbe di nuovo cristianesimo!
E io, divertita da tanto smarrimento, ho risposto con molta flemma: Certo, cristianesimo – e perché no poi?
Ma come possiamo eliminare l’odio dai nostri cuori, avendo tanti motivi per odiare? L’unica soluzione individuata da Etty Hillesum stava nel cercare la risposta nell’amore, come indica il passo che proponiamo qui, che sembra tratto da un libro dei nostri giorni avente per argomento la gestione di un modo di vivere ma che, invece, fu scritto nella notte del 20 giugno 1942, alle dodici e mezzo:
Per umiliare qualcuno si dev’essere in due: colui che umilia e colui che è umiliato e soprattutto: che si lascia umiliare. Se manca il secondo, e cioè se la parte passiva è immune da ogni umiliazione, questa evapora nell’aria. Restano solo delle disposizioni fastidiose che interferiscono nella vita di tutti i giorni, ma nessuna umiliazione e oppressione capace di angosciare l’anima. Si deve insegnarlo agli Ebrei. Stamattina pedalavo lungo lo Stadionkade e mi godevo l’ampio cielo ai margini della città, respiravo la fresca aria non razionata. Dappertutto c’erano cartelli che ci vietano di percorrere le strade verso la campagna. Ma sopra quell’unico pezzo di strada che ci rimane c’è pur sempre il cielo, tutto quanto. Non possono farci niente, non possono veramente farci niente. Possono renderci la vita un po’ spiacevole, possono privarci di qualche bene materiale o di un po’ di libertà di movimento ma a privarci delle nostre forze migliori, col nostro atteggiamento sbagliato, siamo noi stessi: col nostro sentirci perseguitati, umiliati e oppressi, col nostro odio e la millanteria che maschera la paura. Certo, ogni tanto si può essere tristi e abbattuti per quel che ci fanno, è umano e comprensibile che sia così. E tuttavia: a derubarci da soli siamo soprattutto noi stessi. Trovo bella la vita, e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma ciò non è grave. Dobbiamo cominciare a prendere sul serio il nostro lato serio, il resto allora verrà da sé: e «lavorare a se stessi» non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso – se ogni uomo si sarà liberato dell’odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest’odio e l’avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore, se non è chiedere troppo. Eppure è l’unica soluzione possibile.
“Credo in Dio e negli uomini.” Questo è il risultato finale della ricerca spirituale intrapresa da Etty Hillesum durante gli anni della guerra. Un credo che dimostra come la sua spiritualità non costituisse solo un cammino verso la propria interiorità più profonda ma come la fede in Dio segua anche il percorso inverso, dall’interiorità al mondo esterno. Il rivolgersi verso il sé diventa in tal modo un impegno nei confronti del prossimo. L’incontro con Dio, per lei, era indissolubilmente legato alla ricerca di Dio nei suoi simili, negli individui, malgrado le nostre scelte privilegino sovente l’odio sull’amore, la guerra sulla pace. Qualche volta la cruda realtà delle persecuzioni, con la quale dovette fare i conti, fu tuttavia troppo difficile da sopportare anche per lei. Nella lettera del 24 agosto 1943 scrisse:
Se penso alle facce della scorta armata in uniforme verde, mio Dio, quelle facce! Le ho osservate una per una, dalla mia posizione nascosta dietro una finestra, non mi sono mai spaventata tanto come per quelle facce. Mi sono trovata nei guai con la frase che è il leitmotiv della mia vita: E Dio creò l’uomo a Sua immagine. Con me questa frase ha vissuto una mattinata difficile.
Nonostante ciò che visse quotidianamente, la Hillesum non venne meno al suo credo: in Dio e negli uomini. Un credo che, avendo costei affidato i suoi diari a mio padre, Klaas Smelik, è ormai da decenni a disposizione dei lettori di tutto il mondo. E ciò soddisfa il suo desiderio di diventare utile ai posteri.
Mi piacerebbe vivere a lungo per riuscire a spiegarlo, e se questo non mi sarà concesso, bene, qualcun altro lo spiegherà al posto mio, e colui continuerà a vivere la mia vita dove è rimasta interrotta e perciò debbo viverla meglio, in ogni suo aspetto e con la massima convinzione sino all’ultimo respiro, in maniera che quanti mi succederanno non dovranno più ricominciare tutto daccapo né superare le mie stesse difficoltà. Non è qualcosa fatto per i posteri anche questo?
I due temi che vi ho proposto bastano per sottolineare come questa donna ebrea seppe dare forma alla sua dignità e identitità, in un’epoca in cui si fece di tutto per eliminarli. Ed è per questo motivo che le generazioni dopo di lei si ispirano alla sua opera e al suo pensiero. Che la sua memoria sia la nostra benedizione.
Testo, rivisto dall’Autore, della conferenza tenuta a Brescia l’11.12.2014 su invito della Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura
Edith..un angolo tranquillo ogni giorno con Dio

"L'essenziale è solo che ogni giorno si trovi anzitutto un angolo tranquillo in cui avere un contatto con Dio, come se non ci fosse nient'altro al mondo.“
Edith Stein
Alla scuola della Croce
Se ci si allontana da lui per andare verso la ve-«0 rità, non si farà molta strada senza cadere fra le sue braccia» (S. Weil, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, p. 32). Simone Weil oblitera con noi pellegrini il biglietto per un breve sguardo sul cammino di fede di Edith Stein. In Storia di una famiglia ebrea, la Stein racconta che presto perse la fede della sua infanzia, la fede ebraica, maturando il suo non liquet rispetto al problema della fede, profondo grido di chi, assetato di verità, rifugge la "fabbrica di immagini di Dio" e detronizza tutti gli dèi, cifra della sua lotta con l'angelo. Negli appunti in cui rielabora il vissuto di quel periodo si legge: «quello che non rientrava nei miei piani, era nei piani di Dio. Ad ogni nuovo evento di tale tipo, si fa più viva in me la convinzione, dettata dalla fede, che nella prospettiva di Dio non esiste il caso, che la mia intera vita è tracciata, fin nei minimi particolari, dai disegni della Provvidenza divina» (E. Stein, Essere finito e essere eterno, Città Nuova, Roma 1988, p. 153). Così sembra provvidenziale, per la gestazione della sua fede, l'appassionata attitudine alla ricerca filosofica, libera dal pericolo di ogni riduzionismo ed esclusivismo, complice sia il metodo fenomeno-logico dell' epochè, che rigetta schemi preconcetti e accoglie ogni cosa senza pregiudizi, sia l'ambiente di amici come Scheler e Reinach, filosofi da poco convertiti al cristianesimo. D'altronde, la fede biblica si nutre pienamente di ciò che l'uomo produce e al tempo stesso lo rielabora.
Anche lo scandalo del male sembra provvidenzialmente ordinato all'esperienza del Numinosum che le si manifesta in primis con la testimonianza di pace di una giovane amica rimasta vedova. Questa, seppur confessandole di essere lacerata nel cuore per la perdita in battaglia del marito, riesce ad accettare la morte vivendola come partecipazione al sacrificio della Croce. Edith annota: «quello fu il primo incontro con la Croce, con quella forza divina che essa comunica a chi la porta... In quello stesso istante la mia incredulità crollò... vinta dalla luce del Cristo che si sprigionava dal mistero della Croce» (cit. in Teresa Renata dello Spirito Santo, Edith Stein, Morcelliana, Brescia 1952, p. 104). Il grido umano era diventato un grido divino, Dio non spiega il motivo del male, ma lo abita.
L'illuminazione definitiva avvenne nel 1921 leggendo d'un fiato la Vita di santa Teresa d'Avila. Il dubbio di fede tace, la voce atea ora confessa: questa è la verità! Verità che non lascia più spazio alla paura: «So di essere conservato e per questo sono tranquillo e sicuro: non è la sicurezza dell'uomo che sta su un terreno solido per virtù propria, ma è la dolce, beata sicurezza del bambino sorretto da un braccio robusto, sicurezza... O sarebbe "ragionevole" il bambino che vivesse con il timore continuo che la madre lo lasci cadere? Nel mio essere, dunque, mi incontro con un altro essere, che non è il mio, ma che è il sostegno e il fondamento del mio essere» (E. Stein, Essere finito e Essere eterno, cit., p. 96). Nella maturità dell'opera Essere finito e Essere eterno, la filosofa si smarca dal sentimento della paura che nasce dalla considerazione della finitezza umana: la caducità dell'uomo non è limitante distanza da Dio, ma confine tra due terre che si schiudono reciprocamente nella realtà descritta dalla Genesi dell'homo imago Dei. Se il chicco di grano non muore resta solo e non porta frutto, ma se, sapendosi sostenuto, sceglie di morire a se stesso per un amore più grande, allora porta frutto. Edith Stein ormai suor Teresa Benedetta della Croce fa propria la lezione di san Giovanni della Croce sulla Notte oscura: «Ecco perché l'anima può considerare l'aridità e l'oscurità come felici indizi; indizi che Dio è intento a liberarla da se stessa, strappandole di mano l'iniziativa» (E. Stein, Scientia Crucis, Ed. Ocd, Roma 2011, p. 159), amando non più i doni di Dio ma il Dio dei doni. Scrive la Weil: «Egli è colui che, mediante la notte oscura, si ritira per non essere amato come un tesoro da un avaro. Elettra che piange Oreste morto. Se si ama Iddio pensando che non esiste, egli manifesterà la sua esistenza» (S. Weil, L'ombra e la grazia, Edizioni di Comunità, Milano 1951, p. 63).
(Flavia D'Avola)

Da Edith Stein a Teresa Benedetta
La giovinezza inquieta di una filosofa, martire cristiana
Lodovica Maria Zanet
Bad Bergzabern (Renania-Palatinato), estate 1921. In casa di amici, una trentenne intellettuale tedesca di famiglia ebraica, Edith Stein, si ritrova sola. Potrebbe uscire anche lei, incontrare qualcuno, forse andare a camminare. Decide invece di restare a casa, e fa la cosa a lei più consona: si avvicina ai rifornitissimi scaffali della biblioteca e prende un libro. Non vi presta grande attenzione, non lo sceglie dopo attenta disanima, escludendo altre opzioni: piuttosto, se lo ritrova in mano. È il Libro della Vita di Teresa de Cepeda y Ahumada, scritto dalla stessa. In quelle pagine, la grande santa di Avila, mistica, poi dottore della Chiesa – donna “inquieta e vagabonda” come i suoi nemici la definivano – racconta se stessa e le sue grazie mistiche ai direttori spirituali. Da una parte dunque sta, in quella notte di Bad Bergzabern, il raffinato siglo de oro spagnolo, con i suoi fasti e la sua cultura, la sua temibile Inquisizione e le conquiste oltre oceano; dall’altra la cupa Germania tra le due guerre, prostrata dalla sconfitta nel Primo Conflitto Mondiale e in disperata ricerca di riscatto. Da una parte c’è il cristianesimo, raccontato per via esperienziale da una donna, Teresa, che trattava Gesù come amico e definisce la preghiera come il frequente trattenersi, da soli a Solo, con Colui da cui sappiamo d’essere amati. E dall’altra c’è lei, Edith Stein: nata a Breslavia (oggi Wrocław in Polonia) il 12 ottobre 1891, ebrea di famiglia, atea dichiarata sin dalla prima adolescenza, esploratrice in punta di concetto tra le tesi della fenomenologia tedesca dell’epoca, professata dal celebre e incompreso Edmund Husserl.
Non c’è dunque nulla, in Edith, che paia ricollegarla al mondo di Teresa. Non la fede, non la tradizione culturale. E senz’altro non il carattere: riservato e schivo per Edith, solare ed espansivo per Teresa. Teresa chiedeva a Dio il dono di essere amata da molti. Edith ambiva a capire molto. Teresa si lasciava invadere dalla realtà. Edith muoveva alla sua conquista, con acribia non inferiore a quella che il suo maestro, Husserl appunto, amava descrivere citando l’incisione di Dürer Il cavaliere, la morte, il diavolo: una scena in bianco e nero ove per restar vivi urge superare lo scoglio dell’inganno.
Qualcosa però, in quella notte, accade. Edith divora le pagine del Libro della Vita: il mattino dopo si dice l’avesse già terminato. «Questa è la verità», afferma. Acquista un Messale e un Catechismo e si presenta al parroco del luogo, chiedendo il battesimo. Lo riceverà alcuni mesi più tardi, il 1° gennaio 1922. Morirà, carmelitana scalza e martire, ad Auschwitz nell’agosto 1942. Nel 1933, nell’infuriare della follia nazista, quando ogni strada di docenza le era ormai preclusa, dopo 12 anni di attesa sarebbe entrata lei stessa nel Carmelo, riformato da Teresa nella sua Castiglia nel 1562.
Chi è Edith
Chi è, però, Edith Stein? E perché quel passo, in apparenza così azzardato e illogico – che non cesserà di stupire gli amici e scandalizzare i familiari –, dall’ebraismo al cristianesimo transitando da oltre quindici anni di convinto ateismo? «Secretum meum mihi», lei dice: confermando che le cose più importanti stanno dentro, e nessun le saprà mai. Sappiamo però alcune cose. Edith è la più piccola di una numerosa famiglia slesiana. Sono ebrei e professano la fede dei padri. Piccolissima, spetta a lei porre le domande di rito per il Seder di Pesah. Cresce sveglia e riflessiva, interiormente vivace. Composta all’esterno, Edith custodisce però dentro le cose più vere. Le attende, le chiede, le accoglie. Solo dopo le comunica, se necessario. Grande osservatrice, esamina i comportamenti umani con scientifica analiticità: ma sa comprendere e scusare, e ha una spiccata intelligenza emotiva. Tredicenne, la prima svolta: non avrebbe più creduto in Dio. L’atto del credere aveva smarrito per lei ogni ragionevolezza. Edith non si riconosceva nelle tradizioni di famiglia, non riusciva a farle proprie ed era interessata ad altro. E allora se ne distacca, con una radicalità per certi aspetti sconcertante, ma sua tipica: la (reale o supposta) chiarezza di pensiero determina qui un’assoluta linearità della volontà, un’inflessibilità della scelta che non ammette ripensamenti. Ed Edith comincia allora a cercare nell’umano la risposta al divino ormai assente, senza ancora sapere che in Cristo essi erano già ricongiunti.
Sceglie così di studiare letteratura tedesca, storia, psicologia. Ma è brava e si stanca presto di maestri che esauriscono davanti a lei gli argomenti e il fascino. Le parlano allora della fenomenologia, un nuovo modo di fare filosofia praticato a Gottinga da Edmund Husserl, Adolf Reinach e un gruppo di temerari giovani, che criticavano Kant, le altre grandi autorità del pensiero e volevano ritornare alle cose stesse. «Ritornare alle cose stesse» significava: privilegiare la realtà per come appare e si manifesta, rispetto alle teorie (pur necessarie) che ambiscono a comprenderla. Era come se avessero detto ad Edith di tornare a camminare in montagna anziché studiare il tracciato dei sentieri sulla cartina. Lascia tutto e parte. Trova un mondo molto diverso, di confronto ampio, di amicizie al femminile e al maschile. Di amore, anche, che farà però fatica ad accogliere e a integrare nel proprio vissuto, senza riuscire ad arrendersi a un sentimento che diventasse progetto di vita.
Edith Stein ha quasi 23 anni quando scoppia la guerra. Lei diventa crocerossina volontaria al fronte. Husserl perde un figlio. Muore il suo migliore amico, Adolf Reinach: era sposato con Anna, una della poche donne laureate in Fisica del tempo. Ed Edith, un giorno, la va a trovare. È convinta di incontrare una donna annientata dal dolore. Forse prova a prepararsi parole consolatorie, senza però sapere bene – e si tratta per lei di un’esperienza inedita! – cosa dire. Quando però incontra Anna capisce che le sue sarebbero state parole vuote, parole vane. La luce della Croce di Cristo si staglia davanti a lei, per la prima volta, come un mistero affascinante di dolore e di amore.
Edith intanto è una studentessa che si avvia a diventare una studiosa. Si laurea infatti, con una tesi sull’empatia: quel fondamentale atto umano per cui siamo capaci di gioire con chi è nella gioia, di piangere con chi è nel pianto, di farci tutto a tutti, di avere gli stessi sentimenti: sono parole di San Paolo – che la Stein allora non conosce –: in un mondo che precipitava in quegli anni nell’odio, lei si era scelta questo problema, il «problema dell’empatia», per indagare il fondamento delle relazioni sociali cooperative. Scommetteva così sul fatto che esistesse qualcosa oltre l’odio, la rabbia cieca, l’irragionevole furia, o anche solo l’indifferenza che uccide; indaga ciò che accomuna invece di ciò che divide. Inserita in un gruppo di ricerca dove ci si occupa del tema dei valori, degli atti sociali, del bello estetico, della filosofia della natura, Edith aveva cominciato ad allenare nella vita quotidiana quella fondamentale attitudine che la fenomenologia le aveva trasmesso: guardare la realtà a occhi sgranati, se possibile senza pregiudizi, dandole la possibilità di rivelarsi non per quello che si vorrebbe fosse, ma per quello che è. Quando a Bergzabern legge Teresa, in fondo Edith ha solo concesso al diverso la possibilità di bussare alla sua porta.
La conversione
La conversione è folgorante, totale: Edith passa dal nulla al tutto, anche se il tutto era stato lungamente preparato dalla pazienza del cercare laico e dal rigore altamente sfidante della filosofia. Per lei conversione al cattolicesimo e chiamata al Carmelo sono un tutt’uno: il Carmelo di Teresa, ma soprattutto il Carmelo che si rifà ad Elia, alla Terra del Santo, a quell’Israele parte della sua vita: Edith cristiana recupera così l’ebraismo, che diviene per lei angolo prospettico privilegiato per capire Gesù; e ritorna in sinagoga con la madre, lacerata dalla scelta della figlia ma stupita di ritrovarsela accanto.
Se dai 20 ai 30 Edith aveva bruciato le tappe, in una giovinezza folgorante e dalle molte conversioni – intellettuali, affettive, volitive, religiosa infine –, ora però deve di nuovo affidarsi: quando i suoi coetanei costruiscono e concretizzano una famiglia o una carriera (o entrambe), a lei è chiesto di pazientare. Vorrebbe entrare al Carmelo, ma ne è trattenuta da sacerdoti che la esortano a servire la Germania del tempo come studiosa e docente; ambisce all’Università, ma non riuscirà mai a fare una vera carriera e le leggi razziali ve la estrometteranno definitivamente; legge i santi carmelitani, ma trascorre ogni anno la Settimana Santa nell’abbazia benedettina di Beuron, grande centro di studio. Edith pensa alla consacrazione, eppure il suo cuore di donna le fa intuire la bellezza di un rapporto affettivo, anche se sarà sempre ferma nell’attenersi al proposito di dedizione esclusiva a Cristo e alla Chiesa e sperimenta intanto le tappe esigenti di una maturazione verso il cuore indiviso. Sono passaggi che potrebbero riportarla a un momento di grave crisi simile a quello attraversato da studentessa e allora intrecciato al suo indagare filosofico, quando era arrivata ad auspicare che la morte sopraggiungesse a por fine alle sue sofferenze («Non riuscivo più a percorrere una strada senza avere il desiderio che una macchina mi investisse»). Ma la santità non ha nemici nemmeno nella fatica, nello svuotamento, nella notte oscura dell’anima e della psiche: e ora Edith ha la fede a sorreggerla e il sogno del Carmelo sempre all’orizzonte. Attraverso le ferite della vita e del cuore di Edith Stein, comincia quindi a passare una grazia che consola e conforta le persone che le stanno accanto: allontanatasi per scelta dal mondo della filosofia in senso stretto, insegna per otto anni dalle Domenicane di Spira, divenendo importante punto di riferimento (lei laica) per le giovani in formazione; quindi all’Istituto di Pedagogia scientifica di Münster.
Solo nel 1933, per il precipitare della situazione e la crescente esasperazione della persecuzione antiebraica, l’insegnamento verrà definitivamente precluso ad Edith. Potrebbe forse continuare a insegnare in Sud America: ma lei, abituata a cercare la verità nelle evidenze positive, adesso inizia a comprendere che rappresentano altrettanti segni anche quelle negative, cioè i vincoli, i limiti e le mancanze. Che le indicano ora un tipo di fecondità diversa. Anche chi la dirige spiritualmente (celebre il rapporto con il grande Gesuita padre Erich Przywara) l’aiuta a capire che è venuto il momento di entrare in quel Carmelo dal quale era sempre stata trattenuta per potere servire di più – e meglio – attraverso i doni di parola e di scrittura che aveva ricevuto.
Il Carmelo
Edith entra al Carmelo di Colonia il 14 ottobre 1933, a 42 anni appena compiuti. La anima il chiarissimo convincimento che non l’attività umana, ma solo la passione di Cristo possa salvare: ad essa intende ora prendere parte. Professa perpetua nel 1938 con il nome di Suor Teresa Benedetta dalla Croce, al Carmelo continua l’attività di scrittrice approntando anche la sua ultima e più celebre opera, Essere finito ed Essere eterno: un testo originalissimo, lontano dai parametri della critica scientifica, in cui Edith cita Aristotele con Tommaso, Heidegger con Teresa, insegnando che se la sintesi viene fatta nella vita, essa ha diritto di esistere anche sulla pagina scritta.
Per aver salva la vita passa quindi al Carmelo di Echt, in Olanda. Ma anche qui viene raggiunta, all’inizio dell’agosto 1942. Le SS le intimano di uscire dalla clausura: Edith, con la sorella Rosa (anch’ella convertita al cattolicesimo), superato il campo di smistamento di Westerbork, morirà nel campo di sterminio di Auschwitz pochi giorni dopo: aveva superato i 50 anni e, non rientrando nei criteri di efficienza da lavoro dei prigionieri al campo, era semplicemente stata gettata via come un oggetto inutile. Chi la ricorda, afferma che Edith in quegli ultimi frangenti si prese cura dei bambini, abbandonati dalle loro mamme rese folli dall’ebbrezza del dolore.
Beatificata il 1° maggio 1987, Edith Stein viene canonizzata l’11 ottobre 1998, come martire: infatti ad Auschwitz era arrivata sì come ebrea, ma come ebrea convertita al cattolicesimo, catturata in ritorsione a un proclama ufficiale con cui i Vescovi olandesi prendevano posizione contro le efferatezze del Terzo Reich. L’umano e il divino, dunque, arrivano ora anche in Edith a perfetta sintesi: nel patire della propria carne, è testimone di un mondo che nega Dio e in cui ad Auschwitz anche il silenzio di Dio diventa assordante.
Spiegando cosa fosse il Carmelo, Edith Stein un giorno aveva scritto: «Chiunque entri al Carmelo deve consegnarsi tutto al Signore, solo chi valuta il suo posticino in coro, davanti al Tabernacolo, più di tutte le magnificenze del mondo può vivervi e trovarvi di certo allora una felicità quale nessuna magnificenza può offrirle […]. Quanto Dio opera nelle ore di preghiera silenziosa nell’anima si sottrae ad ogni sguardo umano, è grazia per grazia e tutte le altre ore della vita ne sono il ringraziamento». Era il ritornare di Edith – con consapevolezza nuova e la piena maturità dell’età adulta – su quella custodia di sé che non nasceva da un rifiuto della visibilità o dell’amicizia, ma era animato dalla più profonda consapevolezza che non si può dare agli altri quello che non si è; che occorre custodire per donare; che le cose più importanti e vere non vanno mai esibite.
